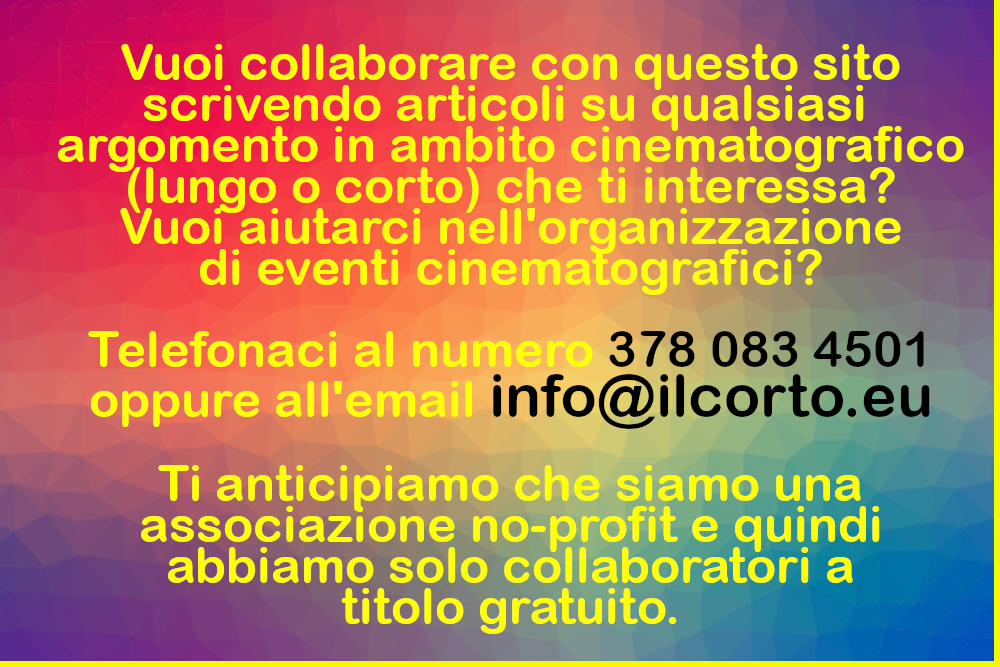Entrate e uscite, presentazioni e congedi, anticipazioni e/o stacchi
Nella prima parte di questo corso ci siamo soffermati sulla creazione dei personaggi.
Nella seconda parte abbiamo compiuto un excursus tra i generi e relative strutture narrative.
In questa terza parte esamineremo una serie di situazioni obbligate che uno sceneggiatore si trova usualmente ad affrontare, per qualsivoglia personaggio e in qualsiasi genere di film.
Questa terza parte sarà meno teorica e più pratica della precedente, e spero risulti utile a farvi comprendere quali problemi nascono e quali tecniche narrative possono essere messe in gioco nello sceneggiare delle situazioni “obbligate” nel senso di ricorrenti, perché non solo sono quasi inevitabili in ogni tipo di film, ma possono replicarsi anche all’interno dello stesso film.
Comincerò da una situazione sommariamente già affrontata nella prima parte (nella lezione sui modi di presentare un personaggio) e che qui cercherò di approfondire. Cioè quella delle Entrate e Uscite di scena.
L’ingresso del nostro personaggio in un nuovo ambiente spesso prelude alla sua presentazione ad altri personaggi (anche se a noi pubblico il personaggio si è già presentato) e alla sua conoscenza di nuovi personaggi (finora ignoti al pubblico). Come evitare, soprattutto in un film che prevede molti ambienti di passaggio e molti incontri con personaggi occasionali, che queste continue presentazioni diventino noiose e tutte uguali?
L’uscita del nostro personaggio da un ambiente prelude a uno spostamento del personaggio, rappresentato attraverso uno stacco narrativo oppure seguendo un percorso lineare dal luogo A al luogo B. Questa uscita va legata al seguito? Dipende se vogliamo sottolineare una stretta continuità oppure se vogliamo operare uno stacco deciso che frammenti la narrazione spostandola di netto altrove e/o in un momento successivo, operando cioè un salto di tempo. Ma anche qui, come possiamo evitare che i meccanismi di passaggio da un ambiente all’altro, da una fase temporale alla successiva, a furia di ripetersi diventino scontati?
Se si trascura di considerare questi problemi già in sede di sceneggiatura, come per molti anni si è fatto in Italia da parte dei molti che consideravano la sceneggiatura non come una “Bibbia” (come si suol dire oggi), ma come un mero “canovaccio” (secondo la tradizione antica della Commedia dell’Arte), si finisce per girare delle scene con degli inizi e dei finali magari quotidiani e realistici (perché la vita è piena di situazioni ripetitive e di cerimoniali standardizzati) ma narrativamente troppo monotone (presentazioni reciproche al principio, saluti e congedi alla fine). In genere scene scritte e girate così vengono tagliate al montaggio, sforbiciando tanto i preliminari, quanto le code. In questo modo però rischiano di saltare le presentazioni dei personaggi che a quel punto diventano presenze troppo generiche, e nell’alternanza delle scene si rischia un racconto poco fluido e a sbalzi. Gli attacchi e i finali è sempre bene studiarli prima, in sede di sceneggiatura, non delegarli al regista al momento della messa in scena o al montatore in fase di editing. Una buona sceneggiatura non è una Bibbia e neanche un canovaccio: è un programma di lavoro basato su uno stile adeguato e coerente di racconto. Bisogna riservarsi la libertà di poterlo adattare alle circostanze, ai luoghi, alla recitazione, però non al prezzo di renderlo solo una traccia da interpretare scena per scena, altrimenti si sacrificano gli equilibri narrativi.
Ricaviamo il nostro esempio di riferimento dalla sceneggiatura del film Little Caesar (1930) di Mervyn LeRoy, film scritto dal grande sceneggiatore W.R. Barnett e ispirato a una vicenda reale di cronaca nera (la storia della banda criminale di un certo Sam Cardinelli). Il protagonista, Caesar Bandello, alias Rico, e Joe Massara, suo amico e complice, vengono presentati nella prima scena del film, freschi reduci da una rapina. Quella rapina per Rico è solo l’inizio di una carriera criminale da affrontare in modo più consapevole e organizzato per acquisire il Potere di un autentico boss; per Joe invece, più incline al “mordi-e-fuggi” dovrebbe essere festeggiata in allegria, in attesa della prossima, altrettanto improvvisata e casuale. Rico è tra i due, la personalità dominante. Nel corso della scena, Joe, con una certa timidezza, chiede al suo compagno, deciso ad andarsene al più presto, dove intenda spostarsi e Rico risponde in un misto di precisione e di vaghezza, “Oh… a est… sì, ad est. Laggiù si fanno le cose in grande.” (Questa battuta è già un esempio importante: si annuncia uno sviluppo, unitamente a un’intenzione del personaggio, ma non si anticipa troppo quale sarà la scena successiva, infatti si ha cura di non precisare esattamente quale città, quale posto Rico abbia in mente per dare inizio alla sua scalata. Dal punto di vista realistico e psicologico la battuta non fa una piega: Rico ha deciso cosa fare “da grande”, ma non ha ancora scelto il luogo esatto da dove cominciare. Il personaggio non deve apparirci troppo esperto dell’ambiente criminale, altrimenti non saremmo coerenti con le sue attuali caratteristiche, quelle cioè di un banditello da strada che rapina i distributori di benzina).
La seconda scena è a stacco, presume cioè un salto di tempo. Lo sceneggiatore non ci racconta né il viaggio di Rico verso est, né le sue prime esplorazioni alla ricerca della città e del luogo giusto. Va subito al punto. La scena si ambienta in un locale di cui vediamo l’insegna: si chiama Club Palermo. Più chiari di così… il nome inequivocabile rende superflua ogni altra spiegazione. E’ un locale da gioco d’azzardo e anche questo lo comprendiamo subito da un DETTAGLIO delle mani di un personaggio che dispongono su un tavolo le carte di un solitario. Su questa immagine udiamo da fuori campo la voce di Rico:
RICO - … e questo è tutto. Me la sono filata a est, come ho detto. Vorrei entrare nel vostro giro se vi va. Che ne dite?
Lo sceneggiatore taglia la presentazione tra Rico e l’ancora misterioso proprietario del locale. E’ perfettamente inutile narrativamente che al pubblico vengano ripetute informazioni che conosce già.
Ma per dare realisticamente l’idea che la presentazione e il racconto dei precedenti sono stati svolti, si fa iniziare il discorso di Rico dalla fine e con una sorta di riepilogo, limitato ad un accenno. E nella stessa battuta si passa subito alla fase immediatamente successiva: la richiesta di Rico di entrare a far parte della banda.
Ora vediamo Sam Vettori, cioè il boss, che sta giocando al solitario. Anche la scelta del solitario è significativa. Il boss, in quanto tale, è solo, se ne sta nel suo ufficio, non gioca a carte con gli altri, è superiore a chiunque, lo sceneggiatore indica precisamente che “sembra non prestare alcuna attenzione a Rico.” Infatti non gli risponde neanche. Rico insiste (ma sempre da f.c., è anche questo è espressivamente un dettaglio importante. Non dobbiamo sminuire il protagonista mostrandolo in un atteggiamento di eccessiva sudditanza. E stiamo ancora sul boss perché è lui, qui, il centro esclusivo della narrazione). Nella successiva battuta, Rico lo chiama per nome ( Signor Vettori) veicolando così un’altra informazione al pubblico. Il boss si esprime solo quando Rico dice che è disposto ad obbedirgli in tutto e per tutto, per poi aggiungere subito con ritrovata fierezza: “Non ho paura di niente!” Allora il boss solleva gli occhi, su un Rico ancora invisibile al pubblico, e chiede:
SAM – Così credi di essere un duro, eh?
Solo adesso la camera mostra entrambi gli interlocutori e notiamo che Rico è in piedi di fronte al tavolo del boss, lo guarda fisso e ha un atteggiamento determinato:
RICO- Datemi la possibilità di dimostrarvelo.
SAM- Che ne sai di me?
RICO- Ne ho saputo abbastanza. Di come controllate questa parte della città. Di questo Palermo Club che usate da base. Ne ho sentite un sacco, in proposito.
E’ dunque Rico, il nostro protagonista, a presentare al pubblico il boss. Ma in pratica questa informazione si riduce a qualificarlo per quel che è, precisando che il locale è soltanto la facciata di un’attività criminale presumibilmente vasta e diffusa. Notiamo anche che Joe, il compare di Rico, è scomparso. Rico è andato da solo all’incontro con il boss. E’ come se lasciando Joe, avesse anche lasciato alle spalle il suo passato da delinquentello. Un uomo ambizioso non si presenta in compagnia, è deciso ad affrontare il destino per proprio conto. L’obiettivo da conseguire è più importante dell’amicizia. Non c’è bisogno di spiegarlo, la situazione parla da sola.
Segue un breve scambio di battute sul grado di “durezza” che Rico può garantire. Il boss chiede anche un suo impegno solenne all’obbedienza incondizionata. Rico conferma tornando a chiamarlo, con rispetto, Mister Vettori.
Il capo si alza e va verso la stanzetta adiacente, per presentare a Rico gli altri membri della banda, che come vedremo di lì a poco, stanno giocando a carte.
SAM- Su, fai conoscenza coi ragazzi… tutti elementi di prim’ordine… Quello è Tony Passa… il migliore guidatore in circolazione… e quello è Otero, altrettanto in gamba. E Scubby… tipo sveglio! E quello è Killer Pepi… ragazzi, voglio farvi conoscere uno nuovo. E’…
Sam sembra essersi scordato il nome.
RICO- Caesar Fredrico Bandello.
SAM ( pizzicandogli le guance)- Piccolo Cesare, eh?
La prima battuta ci presenta i personaggi con rapide caratterizzazioni, di ruolo e di valore. Di Killer Pepi non c’è bisogno di aggiungere altro, il nome indica la funzione. Sintesi e rapidità estreme, come potete vedere. Nessun inutile indugio. Resta la precisione psicologica nel rappresentare la superiorità del Boss : nessuno si presenta per conto suo, è lui a farlo per tutti, con sbrigativi giudizi espressi ad alta voce. Rico è ancora tutto da provare. Non solo il boss non può dare giudizi su di lui, ma al momento lo considera un aggiunto qualsiasi di cui s’è persino scordato il nome. Di nuovo Rico reagisce con una fierezza un po’ tronfia. Subito il capo lo ribattezza con superiore sarcasmo. Ma questa è la definitiva, esemplare presentazione del protagonista: un piccolo Cesare, appunto.
Non vediamo la reazione di Rico a questa battuta che dovrebbe in teoria fargli abbassare le penne. La scena dissolve.
La scena successiva stacca sull’antagonista, presenza ancora invisibile, ma annunciata e rimarcata dal titolo a caratteri cubitali di un giornale che parla del Nuovo Capo della Commissione Anticrimime, Alvin McClure, che all’atto dell’insediamento ha promesso misure drastiche contro le gang. Dopo due scene successive dedicate a Rico, era necessario uno stacco netto. Il personaggio di McClure non sarà però presentato nella scena successiva, ambientata in una sala da gioco. Se lo sceneggiatore avesse fatto questa scelta avrebbe replicato lo stesso meccanismo usato in precedenza. Prima lo stacco ci aveva portato all’insegna del Palermo Club e subito dopo al suo proprietario. Qui se dal giornale fossimo passati direttamente alla presentazione di McClure, avremmo raccontato nello stesso modo. D’altro canto, questo stacco digressivo, in cui leggiamo semplicemente il titolo di un giornale, non deve apparire come un inserto completamente slegato dal flusso narrativo. Così lo sceneggiatore usa un altro espediente tecnico di passaggio, né teatrale né letterario, ma specifico del linguaggio cinematografico. Si passa in dissolvenza incrociata dal giornale all’immagine in movimento di una roulette. E’ un modo per evidenziare un collegamento tra la criminalità e il gioco, a un livello di sviluppo superiore e successivo a quello presentato prima: al Club Palermo si giocava a carte e non abbiamo neanche visto la clientela, qui ci sono tavoli da gioco e un salone affollato.
Tornando alle scene precedenti, c’è da sottolineare un altro momento. La prima scena del film, in cui abbiamo visto Rico e Joe in uno squallido bar, si concludeva con l’uscita dal bar dei due compari. La scena successiva, in cui abbiamo visto Rico da solo, al Club Palermo, si concludeva di netto, senza mostrarci se Rico restava o se usciva. Al di là della pura efficacia narrativa, non è mai consigliabile che due scene vicine si concludano allo stesso modo.
Le scene che abbiamo esaminato, inoltre, sono disposte sulla base di un criterio narrativo unitario. Noi stiamo raccontando una carriera criminale in ascesa. Nel passaggio degli ambienti: dal bar di quarta categoria, al Club Palermo, alla sala da gioco, mostriamo di fatto questa ascesa per immagini. Si procede dalla miseria al lusso, per gradini successivi. Le scene per quanto alternate a stacco e senza connessioni spaziali e temporali tra loro, sono tuttavia in continuità narrativa, e dunque intimamente legate.
L’errore più normale che fa uno sceneggiatore alle prime armi è quello di raccontare la vicenda avendo come riferimento la vita quotidiana più che la sua rappresentazione. Si scrive dunque ogni scena dal principio alla fine, come è abituale figurarsela: il personaggio X entra e si presenta (o viene presentato). Poi esce. Si sposta altrove e ne mostriamo lo spostamento (magari seguendo la sua auto in movimento). Il personaggio arriva nel posto successivo. Di nuovo entra, si presenta, conosce nuovi personaggi, esce e così via. Raccontare così risulta di una monotonia sconfortante, rallenta il racconto, e impedisce drammaturgicamente di raccontare quello che più ci interessa: cioè, nel caso, gli inizi (rapidi) della carriera (altrettanto rapida) di un piccolo criminale che ambisce a grandi imprese. Il vero fulcro narrativo è questo, non dobbiamo disperderlo in scene a se stanti, troppo lunghe e troppo ripetitive nello stile narrativo. Raccontiamo una dinamica in progress, non raccontiamo diverse “stazioni” immobili perché configurate e strutturate narrativamente allo stesso modo. Nelle vita le circostanze possono ripetersi, sia pure in un quadro mutato. Nella rappresentazione, la ripetizione va bene solo se per esigenze espressive e di contenuto dobbiamo sottolineare appunto la ripetitività. Ma anche in questo caso, cinematograficamente possono esserci modi più incisivi di mostrare la ripetitività senza dover replicare la stessa situazione.
Un esempio: dobbiamo mostrare i riti ripetitivi di una giornata in fabbrica. Ogni giornata inizia allo stesso modo. Il lavoro comporta la ripetizione degli stessi gesti. Persino le pause pranzo sono un rito identico a se stesso giorno dopo giorno. Come racconta Chaplin questa situazione in Tempi Moderni (1936)? L’immagine della schiera degli operai anonimi che entrano in fabbrica a spalle curve, già esprime la ripetitività affliggente della situazione. Chaplin vi sovrappone simbolicamente un gregge di pecore, rendendo esplicito ed espressivamente forte ciò che nell’immagine della folla è già implicito. Al di là di questa geniale (e non replicabile) cifra d’autore, l’insegnamento vale in generale: non c’è bisogno di raccontare una serie di entrate tutte uguali, per raccontare la ripetitività. Ne basta una, raccontata nel modo giusto e con la dovuta intensità espressiva.
Dedicheremo un’apposita lezione alle scene a tavola, ma in riferimento al tema qui trattato, se vogliamo sottolineare la ripetitività rituale di un pranzo in famiglia, basta che gli attori si muovano come se i loro gesti siano automatici, irriflessi, prigionieri di un’abitudine quotidiana. Se in una famiglia riunita per pranzo si litiga e noi non vogliamo raccontare quel litigio in particolare, ma solo il fatto che in quella famiglia i rapporti sono tesi ed esplodono sempre a tavola, allora i gesti, le reazioni di fastidio dei personaggi, devono sembrarci eterni: l’argomento del contendere è pretestuoso, non deve essere il fulcro narrativo. E’nei dettagli minuti che si vive la ripetitività: il modo di mangiare, il modo di servire in tavola, i litigi che nascono da stupidaggini insignificanti.
Basta che uno reagisca con insofferenza rassegnata di fronte, che so, alla “solita zuppa” per farci capire che stiamo assistendo a un rito infinitamente replicato di cui i personaggi si sentono e sono prigionieri. Se vogliamo sottolineare che in una famiglia non si parla neppure perché si sa che altrimenti si litigherebbe, possiamo carrellare lungo una tavolata muta, dove tutti mangiano senza piacere e senza neppure guardarsi in faccia. In cinema si racconta per sintesi esemplari: una scena deve valere per tutte. Replicare ogni volta la stessa situazione è solo affliggente per il pubblico. Dà la sensazione di un racconto fermo, non di una storia che procede e si sviluppa.
Le scene è spesso utile mostrarle in corso, da un certo punto e fino a un certo punto, decisi da noi sulla base delle esigenze narrative, e non dal “reale” principio alla “reale” fine. Il tempo che dobbiamo seguire è il tempo cinematografico, il tempo della narrazione, non il tempo della vita quotidiana.
Pericolosissimo è anche annunciare in una scena quale sarà la successiva. Luis Bunuel disse che se alla conclusione di una scena due personaggi si danno appuntamento al posto X, la scena seguente può essere ambientata ovunque tranne che nel posto X. Certo a volte può rivelarsi utile anticipare informazioni circa la situazione seguente, però è bene che la scena successiva non le confermi pedissequamente, altrimenti il pubblico, magari inconsciamente, si chiede: ma se vedo il posto X, che bisogno c’era di annunciarmelo prima? Se i due personaggi che ho visto in una scena, in quella seguente li vedo in un altro posto, è ovvio che hanno deciso di andarci, non c’era bisogno di perdere tempo a raccontarlo. Un racconto resta intenso se è in continua evoluzione, il pubblico resta attento se partecipa alla narrazione colmandone i vuoti. Se invece consideriamo il pubblico come una massa di idioti a cui devono essere spiegati anche i passaggi più ovvi e impliciti, il risultato è che uno si addormenta perché dopo un po’ sa benissimo che se si perde un passaggio, essendo i passaggi spesso superflui, non si perde niente.
Questo risulta evidente dalla nostra stessa esperienza di spettatori davanti alla televisione: cogliamo istintivamente quando è il momento giusto per andare a prenderci una birra in frigo. Non perché il film o telefilm sia del tutto sprovvisto di interesse, ma perché abbiamo capito che è raccontato in modo talmente scontato che un certo passaggio possiamo tranquillamente risparmiarcelo, senza che al ritorno non si capisca più niente della storia. Queste zone morte, uno sceneggiatore deve evitarle con cura. Un eccesso di zone morte fa venir voglia di cambiare canale esattamente come un eccesso di spot pubblicitari. Nel secondo caso danno fastidio le pause forzate, estranee alla dinamica del racconto, nel primo risultano seccanti le troppe pause del racconto, il ritmo lento e ripetitivo, le troppe anticipazioni, anche più intollerabili in un racconto che già di per sé allinea luoghi comuni e situazioni prevedibili.
In un film in cui il protagonista passa per una serie di ambienti, conoscendo situazioni e personaggi sempre diversi, risulta micidiale raccontare sempre allo stesso modo l’arrivo del protagonista nell’ambiente, le relative presentazioni eccetera. Studiatevi Ladri di biciclette (1948) di Vittorio de Sica. Lì il protagonista, alla ricerca della sua bicicletta rubata, per tutto il film incontra situazioni, personaggi e ambienti diversi. In partenza, si trova, dunque, ogni volta nella stessa condizione. Ma noi, da sceneggiatori, dobbiamo strutturare le scene in modi sempre diversi.
Qual è la sequenza degli ambienti? Anzitutto il protagonista, Antonio, accompagnato dal figlio, va a Piazza Vittorio dove sa che di solito si trova la merce rubata. Poi a Porta Portese, dove la si vende. Poi finisce in una chiesa vicina dove è riunito un comitato di beneficenza e si è rifugiato un vecchio che potrebbe avere informazioni utili. Dopo una pausa meditativa in trattoria, Antonio, disperando di poter trovare la bici, va da una santona e ne resta di nuovo deluso. Poi ha un incontro casuale con il ladro, che lo conduce, dopo un inseguimento, in una casa di tolleranza. Ma il ladro ha una crisi epilettica e il nostro protagonista realizza che il recupero è ormai impossibile. Infine, Antonio (sempre accompagnato da suo figlio) si ritrova davanti allo stadio dove sta finendo una partita di calcio, e tenta di rubare una bicicletta.
Gli ambienti sono disposti in un ordine non casuale: si comincia esplorando il circuito della merce rubata, cioè secondo logica. Con la scena della chiesa, comincia l’esplorazione delle vie “miracolose”: se la chiesa delude, ecco la santona. Il bordello è una strada ancora diversa, è un luogo di spasso, come lo stadio del finale, ma nel contesto di questi “luoghi del divertimento” si raggiungono le punte più drammatiche.
Come per la carriera criminale del Piccolo Cesare, anche qui seguiamo un percorso evolutivo, dove ogni tappa è successiva non solo temporalmente, ma in termini simbolici. Passiamo dalla piazza agli interni e di nuovo concludiamo in piazza. Ma non è un cerchio, è una spirale. La prima piazza è il posto dove le persone si frequentano e si conoscono, l’ultima piazza è il luogo dell’anonimato di massa. I vari passaggi sono altrettante “curve a salire” di una ricerca che procede dal conosciuto all’incognito. La ricerca della bicicletta diventa esplorazione sociale ed è insieme una quest spirituale. Gli ambienti non sono scelti a caso. Sono luoghi reali, ma anche luoghi simbolici.
La ripetizione della situazione non è dunque statica, non conduce semplicemente ogni volta dalla speranza alla delusione, comporta un’evoluzione e un cambiamento anche interiore del protagonista. Se noi raccontassimo sempre allo stesso modo ogni singola tappa, non basterebbe la varietà degli ambienti a muovere il racconto. Ogni ingresso, ogni uscita devono essere strutturalmente diversi, perché devono corrispondere a un successivo livello di narrazione. Molte tecniche narrative vengono messe in campo da De Sica e dagli sceneggiatori (Oreste Biancoli, Suso Cecchi d’Amico, Adolfo Franci, Gherardo Gherardi, Gerardo Guerrieri, Cesare Zavattini) perché il racconto, nei modi e nello stile, non solo nel contenuto, sia in costante crescendo. L’esplorazione nasce lenta e diventa via via più rapida. Questo comporta che le scene diventano più contratte, e per non risultare sciatte, devono avvalersi della maggiore sintesi e del ritmo più serrato, per sprigionare maggior forza espressiva e simbolica.
A Ladri di biciclette potete affiancare lo studio de Il Sorpasso (1962) di Dino Risi, prototipo non solo italiano ma internazionale, dei road movie. Anche qui la scrittura della sceneggiatura si trova alle prese con il problema di una continua, ripetuta presentazione di personaggi e di ambienti, e anche qui le tappe non sono disposte su un piano orizzontale, ma a salire. Ogni ingresso, ogni uscita da un ambiente, ogni passaggio/trasferta al successivo, vengono narrati in modo diverso, per annullare l’effetto di ripetitività in cui il racconto potrebbe annegare. Le anticipazioni ci sono (fin dal principio i due protagonisti, sotto traccia, sono condotti in un viaggio verso la morte: non a caso, una delle prime tappe è un cimitero) ma si ha cura di non renderle così trasparenti da annullare la sorpresa finale. Solo una volta visto il finale possiamo, ripensando alla storia, cogliere il senso di anticipazione di certe sequenze, il valore simbolico di certi ambienti. Se tutto fosse reso subito esplicito, ci fregheremmo da soli. In Easy Rider (1969), chiaramente ispirato al Sorpasso, è egualmente presente, anche se spostata più avanti, una scena al cimitero. In Thelma e Louise (1991) anch’esso ispirato al Sorpasso, una delle due donne, mentre fa i bagagli per la partenza, prende con sé una pistola. Questo ci annuncia subito, e molto più esplicitamente, che il viaggio avrà una svolta drammatica. Ma di nuovo: si tratta di un richiamo visivo, che al principio pare addirittura incongruo. Le due donne vanno a rilassarsi in un viaggio/fuga/vacanza da cui si attendono una piacevole evasione. Nei dialoghi tra di loro, nulla annuncia il peggio. Né si informa il pubblico circa il programma di viaggio, cioè non ci si anticipano a parole le tappe che vedremo. E le anticipazioni da scena a scena vengono scrupolosamente evitate. Ogni viaggio ha un sapore d’avventura, e l’avventura è tale perché i protagonisti, come gli spettatori, si attendono sorprese. Possiamo anche , se lo riteniamo fondamentale per chiarezza narrativa, scrivere una scena in cui dei viaggiatori studiano un percorso. Ma se poi il viaggio è l’esecuzione pura e semplice di quel percorso, la scena è inutile. E se i viaggiatori sono costretti per varie evenienze a mutare percorso, allora è altrettanto inutile che le indicazioni che diamo all’inizio siano circostanziate. E’ sufficiente indicare una meta generica.
Noi, da sceneggiatori, possiamo utilmente usare una cartina per fissare delle tappe realistiche al nostro racconto, ma mostrarla al pubblico può risultare controproducente. Non solo non si deve svelare la storia nel suo insieme, ma neppure i suoi immediati sviluppi. Questo genere di anticipazioni che sembrano di comodo, sono in realtà scomodissime da gestire. Essere chiari non significa essere didascalici. Collocare dei segnali rivelatori al punto giusto è un gioco con il pubblico, una sfida alla loro capacità di anticipazione, non deve essere una rivelazione anticipata dei passaggi del racconto.
In retorica si consigliava un tempo agli oratori, di esordire tracciando in anticipo di fronte all’uditorio i punti che si sarebbero toccati nel discorso, per esigenze appunto didascaliche e di chiarezza espositiva.
Ma un film, un romanzo, una storia a fumetti, non sono una conferenza, una predica, una lezione, sono un racconto. In un racconto non si svela mai prima dove si vuole andare a parare. Da questo punto di vista il richiamo di Bunuel, sopra citato, è da considerare vincolante. Se il pubblico, di scena in scena, viene condotto per mano come un bimbo disorientato, o come un allievo un po’ tardo da istruire passo passo, il suo coinvolgimento diventa impossibile.
Studiate bene le singole scene dei film sopra citati, per scoprire in quanti modi diversi si può presentare una situazione che tende a ripetersi e che implica molteplici presentazioni, ingressi ed uscite da ambienti successivi. I consigli di visione che vi ho suggerito e vi suggerisco durante il corso, non hanno lo scopo di farvi interessare alla storia narrata dal film, ma di farvi smontare i film per studiarne i meccanismi. I difetti più evidenti delle tracce e delle sceneggiature che mi avete inviato, non riguardano tanto la storia in sé, ma il modo di raccontarla. Una certa impreparazione tecnica è giustificabile e non deve impensierirvi. Ma certi errori, nelle successive revisioni, tendono a restare. E i più frequenti sono questi: 1. Scrittura della scena a partire dal dialogo e non dalla scena stessa; 2. Eccessiva lunghezza delle battute, senza riuscire a focalizzare la cosa essenziale che va detta, spesso perduta in mezzo ad altre notazioni casuali, più preoccupate dal realismo della quotidianità che dall’efficacia del racconto; 3. Troppi ingressi con presentazione e poche scene rappresentate in corso; 4. Troppa ansia di chiarire a parole le motivazioni del racconto e il suo senso, con un esubero di anticipazioni che rivela più una vostra volontà di mettere ordine nei vostri pensieri, più che un’attenzione all’esigenza del pubblico di formarsi una propria idea e di seguire a proprio modo e con i suoi tempi lo sviluppo del racconto.
Specie nei corti, prevale in voi la voglia di costruire degli apologhi in cui la conclusione risulta o scontata (perché troppo anticipata nelle premesse) oppure incongrua e gratuita perché preoccupata soltanto di essere sorprendente e inattesa. Gli sviluppi non devono essere troppo prevedibili, ma neppure devono essere incoerenti alle premesse. Non si tratta soltanto di coerenza psicologica dei personaggi, ma di coerenza narrativa da perseguire in ogni singolo momento di sviluppo del racconto. Da questo punto di vista, smontare i film e studiarli scena per scena, vederli anche a confronto per analogia di argomento e/o di situazione narrata, valutando nel confronto, quali funzionano e quali no, è un esercizio assolutamente fondamentale. Non troverete mai nessun manuale di sceneggiatura in cui si analizzano trasversalmente i film per situazione: scene a tavola, scene a letto, scene in bagno, scene sul posto di lavoro, eccetera. E’ un lavoro che dovete imparare a fare da soli. E vi risulterà utilissimo perché più modi riuscirete a conoscere per raccontare la stessa situazione, più facilmente potrete trovare quello giusto per voi, in quel dato momento e nel contesto del film che state scrivendo.
(Sarebbe da questo punto di vista assai importante poter avere a disposizione delle compilation visive, simili a quelle che si trovano a disposizione per la sonorizzazione. Chi sonorizza può scegliere ad esempio, grazie alle compilation, tra molti e diversi rumori di traffico. Può trovare un rumore di riferimento e poi lavorarci sopra per adattarlo alle proprie esigenze. Chi invece ha il problema di scrivere ad esempio una scena di famiglia intorno a un tavolo, non trova e non troverà mai, finché non cambieranno le leggi sul diritto d’autore, una compilation con un paio d’ore di scene a tavola tratte da film diversi e messe a confronto. Sarebbe uno strumento prezioso invece, non per rubare la scena di un film e per schiaffarla nel proprio, ma per studiare le varianti, le diverse possibili soluzioni, rispetto a situazioni che presentano per tutti coloro che le affrontano gli stessi problemi di base. Le scuole di sceneggiatura più attrezzate e importanti, dovrebbero produrli, questi sussidi. Limitandosi alla carta scritta, si rischia sempre , per quanti sforzi si facciano, di restare “al di qua” del cinema).
31° Lezione di Gianfranco Manfredi