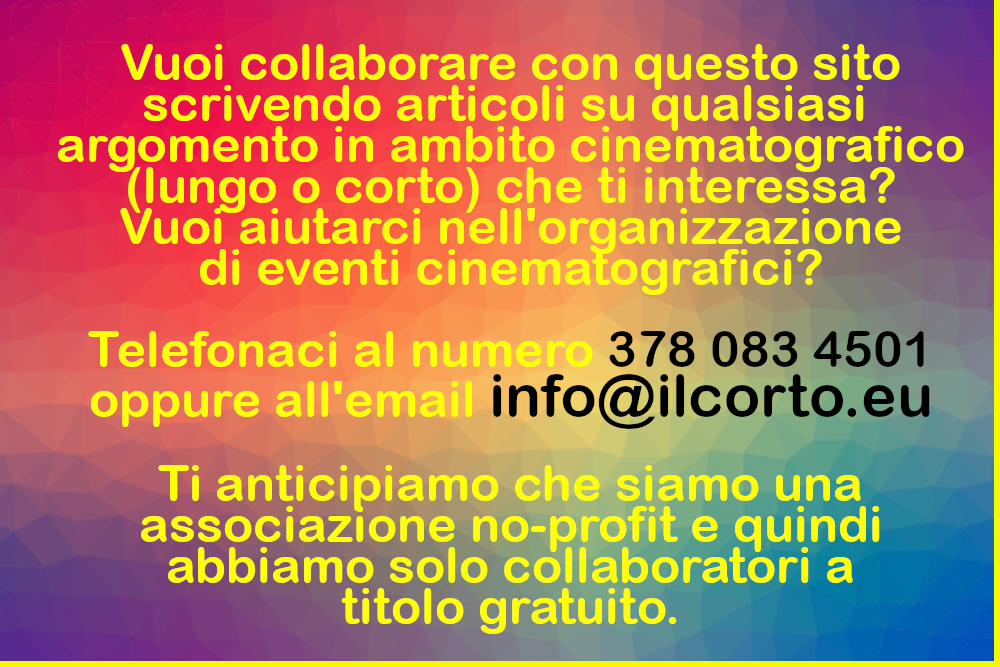Ho chiesto al collega Pietro Montani – professore ordinario di Estetica nella Facoltà di Filosofia de “La Sapienza” – di esporre agli studenti del corso di Istituzioni di regìa e del corso di Istituzioni di regìa digitale, dal suo punto di vista di filosofo e studioso di estetica, il senso dell’ attuale rivoluzione digitale, in rapporto alla storia dell’estetica cinematografica del XX secolo.
Quello che segue è il testo della lezione che ha tenuto al Teatro Ateneo il 20 novembre 2001.
(Ferruccio Marotti)
Pietro Montani
Cinema, multimedialità, esperienza narrativa
1. La cultura dell’immagine attraversa oggi una nuova rivoluzione, dopo quella legata alla riproducibilità fotografica da cui è nato il cinema e che ha interessato come un fenomeno decisivo il XX secolo, con profonde ripercussioni sul sistema moderno delle arti e sui nostri stessi comportamenti percettivi.
Questa rivoluzione riguarda in particolare le tecnologie elettroniche e digitali, le quali
consentono di produrre simulazioni ad altissima definizione svincolando del tutto l’immagine
dalla base riproduttiva ottica e fotografica che è propria del cinema. Il fenomeno ha una
portata enorme, ma qui vorrei affrontarlo da un punto di vista specifico: mi interessa, cioè, la
sfida che queste nuove tecnologie sembrano lanciare al modello narrativo e drammaturgico
che si è imposto nel cinema fin dalle origini - e che fu una scelta, un fatto storico rilevante
proprio in quanto non obbligatorio (il cinema aveva molte altre possibilità che furono in
sostanza lasciate cadere).
Ora, la forma narrativa è tuttora l’aspetto essenziale del cinema: noi andiamo al
cinema essenzialmente per vedere delle storie. E tuttavia, sembra che la sfida del digitale
abbia cominciato a contrastare la vocazione narrativa del cinema e la sua tradizione
contrapponendole un’estetica del videogame. Quella per cui non si va più al cinema per
seguire una storia, ma ci si va per abbandonarsi all’emozione del videogioco, alla pura qualità
attrazionale dell’immagine e degli “effetti speciali” (come si chiamavano una volta). Ci sono
già segni evidenti di questo fenomeno: l’aspetto della costruzione narrativa e drammaturgica
conta sempre meno. L’estetica del videogame è un’estetica antinarrativa.
Come reagisce il cinema narrativo? O ignorando il problema (e può darsi che sia la
soluzione più saggia, ma ci credo poco); oppure resistendo alla penetrazione delle nuove
tecnologie, in particolare con atteggiamenti reattivi nei confronti del dominio pervasivo
dell’immagine (del tutto esemplare il Wenders di Lisbon’s Story); oppure cercando di rendere
le nuove tecnologie funzionali al racconto. E’ questa, per me, la soluzione obbligata se il
cinema vuol salvare la sua natura di autentica esperienza narrativa.
Tuttavia bisogna riconoscere che gli esempi sono scarsissimi. Quanti film ci vengono
in mente nei quali si fa un uso direttamente ed esplicitamente narrativo delle nuove
tecnologie? Personalmente ho seguito con molta partecipazione l’eccezione lodevole
costituita, a suo tempo, dal lavoro pionieristico di Zemeckis (Roger Rabbitt, La morte ti fa
bella, Forrest Gump), ma pare, a giudicare dai suoi ultimi film (peraltro notevoli), che la serie
si sia interrotta. Ma se ne può discutere.
In realtà, sembra accadere oggi qualcosa di analogo a ciò che accadde col sonoro.
Grandissimi registi andarono in crisi (quanto grandi cineasti del muto sono restati grandi
anche dopo il sonoro? Non riesco a trovare altri nomi oltre a quelli di Ejzenstejn e Buñuel).
All’epoca la scelta si orientò sulla soluzione più semplice, tuttora di gran lunga dominante:
quella del cinema, diciamo così, parlato, recitato, musicato. Le possibilità di un autentico
cinema audiovisivo, che sappia fare un uso autonomamente costruttivo della colonna sonora,
rimasero largamante inesplorate. E lo sono ancora: quanti film ci vengono in mente in cui il
sonoro abbia un’autentica funzione costruttiva?
2. Ma se vogliamo porre correttamente il problema, dobbiamo essere meno generici e
risalire più a monte. Dobbiamo spiegare che cosa intendiamo con cinema narrativo o
racconto cinematografico. Intendiamo la semplice illustrazione, magari magnificamente
confezionata, di un intreccio letterario? Sono certo che nessuno di voi la pensa così. Dunque,
quando parliamo di un cinema narrativo, e della sfida che gli viene lanciata dalle nuove
tecnologie, ci riferiamo evidentemente a un modo autonomo di raccontare del cinema. Una
narrazione che è accessibile solo al cinema, che è intraducibile nel linguaggio letterario.
Due esempi di film recenti. Pensate a La stanza del figlio: è un film (come sempre in
Moretti con l’eccezione forse di Palombella rossa) quasi interamente traducible. Ma provate
a fare l’esperiemento con Dancer in the dark e vedrete che nella traduzione si perde quasi
tutto.
Che cos’è che resta fuori dalla traduzione? Molte cose, certo, ma innanzitutto proprio
quegli elementi nei quali il racconto si avvale di risorse multimediali, quando cioè il film
racconta non con le azioni e i personaggi, ma con la forma: col suono, con la luce, col colore.
Nella Stanza, per es., il sonoro ha un certo rilievo autonomo; e anche la qualità della luce
(nell’ultima scena, in particolare); o, ancora, il carrello che segue il protagonista nel rituale
serale della infinita chiusura delle porte ecc. Badate: non si tratta di puri elementi formali, di
effetti estetici “aggiuntivi”, si tratta di elementi narrativizzati, che partecipano direttamente al
racconto, lo articolano, lo costruiscono.
Ma se ci riferiamo a Dancer in the dark, si vede facilmente che qui tutto il corpo del
film racconta, con la pluralità irriducibile delle sue forme e con la fittissima rete di rapporti
che queste forme contraggono reciprocamente: sul piano visivo, pensate alla camera a mano
che con la sua velocità confonde lo sguardo e mette disordine di contro alla perfezione, alla
trasparenza, all’ordine perfetto del musical; sul piano sonoro pensate allo straordinario lavoro
del rumore ecc. Vediamo una sequenza del film, precisamente quella in cui i rumori della
fabbrica “lavorano” l’immagine fino a farle cambiare statuto.
3. Comincia a profilarsi la seguente tesi, che sarà quella che intendo proporre: il
cinema raggiunge la qualità di esperienza narrativa autonoma proprio quando funzionalizza
sul piano narrativo e drammaturgico la propria natura multimediale (in senso ampio). Ora
presenterò e articolerò meglio questa tesi, ma per il momento vorrei farvi notare che se le
cose stanno così, la multimedialità non è affatto un nemico del cinema narrativo, ma il suo
primo alleato. Il grande e autonomo cinema narrativo nasce infatti proprio dalla scoperta di
poter mobilitare ai fini della narrazione tutte le risorse della sua natura intimamente
multimediale. Ejzenstejn, che per primo se ne accorse, chiamava questa proprietà del cinema
«drammaturgia della forma». E sarà questo il primo concetto su cui vorrei soffermarmi.
Anticipo però che ne troveremo un secondo, e altrettanto importante, anche se molto diverso,
in Dziga Vertov. Qui vedremo come mai il cinema abbia la tendenza a trasformare questa sua
multimedialità in un elemento narrativo in senso pieno.
Sviluppiamo un po’ il concetto di una «drammaturgia della forma». Il problema è ben
chiarito nella teoria del montaggio di Ejzenstejn.
Il punto di partenza di Ejzenstejn, ciò che fa la differenza con altre teorizzazioni del
montaggio, è che il rapporto tra montaggio e narrazione per lui non può essere adeguatamente
illuminato nel contesto di una teoria cinematografica ma dev’essere preso più a monte, nel
contesto di una teoria generale del montaggio. Solo su questo sfondo, infatti, possono
apparire col giusto rilievo quei tratti che caratterizzano in modo autonomo la forma
audiovisiva del racconto e la peculiare esperienza che questa dimnsione fa fare.
Prendiamo le mosse da un riferimento importante, che si colloca quasi esattamente a
metà dell'itinerario di Ejzenstejn, cioè in un momento di bilanci e di progetti. Siamo nel 1937,
e Ejzenstejn elabora, ma non pubblica, la sua più ampia e sistematica riflessione sul
montaggio, una vera e propria Teoria generale (TGM).
In quest'opera si incrociano due movimenti: una tesi storiografica, vale a dire una
suddivisione della pratica del montaggio cinematografico in tre fasi o periodi; e una proposta
di carattere teorico, vale a dire una distinzione tra «rappresentazione» e «immagine».
Partiamo da questa distinzione: io posso produrre molte rappresentazioni di una barricata - è
il primo esempio di Ejzenstejn - ma una buona immagine di una barricata sarà quella che mi
restituisce sul piano dell’espressione qualcosa di fondamentale del suo contenuto. Per far
questo, però, io devo decostruire il dato rappresentativo e rimontarlo in modo nuovo.
L’immagine nasce da questo smontaggio e rimontaggio del dato rappresentativo.
L’esperienza che ne facciamo dovrebbe proprio farci sentire la violenza della decostruzione e
la forza della ricostruzione.
Per esempio: in una barricata l’insegna di una panetteria, che di solito si trova in alto,
starà in basso e rovesciata: la rappresentazione ha incorporato il senso di un rivolgimento
nell’ordine abituale delle cose e lo esibisce, lo fa vedere, ce ne fa fare esperienza: per questo
è un’immagine.
La tripartizione della storia del montaggio è molto semplice: si tratta di capire in che
modo nel cinema sia stato concepito questo nesso tra rappresentazione e immagine, tra
decostruzione e ricostruzione.
In una prima fase, dice Ejzenstejn, montare significava essenzialmente comporre
l'inquadratura, l’immagine qui è una ricomposizione significativa del visibile; nella seconda
fase la composizione di montaggio si emancipa dall'inquadratura e si sposta sulla correlazione
tra inquadrature diverse e sul ritmo della loro successione; nella terza, infine (e si tratta del
periodo che si è aperto in quegli anni), montare significa risolvere in modo creativo il
problema della coordinazione di suono e immagine perché il montaggio è ormai, in primo
luogo, montaggio audiovisivo.
Un punto qui dev’essere sottolineato. E precisamente il fatto che, assunto in termini
così generali, il principio del montaggio (decostruzione e ricostruzione) denota un
procedimento che non è affatto peculiare del cinema. Ejzenstejn infatti mostra con
innumerevoli esempi che il principio del montaggio è all'opera non solo in letteratura, in
musica e in teatro ma anche in pittura, cioè in una forma espressiva che una vecchia
tradizione vorrebbe spaziale e non temporale. In realtà nel leggere un quadro noi rispettiamo
sempre una scansione temporale che consiste nel perlustrare via via il dato percettivo
segmentandolo in elementi più o meno discreti e nel reintegrare, poi, questi elementi secondo
una nuova unità. Anche qui il montaggio coincide con un atto di scomposizione e
ricomposizione: se la rappresentazione pittorica ha un significato, se - soprattutto - essa
esercita un'efficacia sull'osservatore, vuol dire che essa è il risultato di uno smontaggio e di
un rimontaggio; vuol dire che non è una copia del mondo ma una sua ridescrizione.
3.1.. Facciamo un esempio da TGM. Ejzenstejn ci mostra un quadro di Serov, che
risale all’inizio del secolo: è il ritratto di una celebre attrice teatrale, la Ermolova.
Il problema è: come Serov sia riuscito a fare in modo che il ritratto ci comunichi un
evidente senso di spiritualità, di «elevazione ispirata».. La risposta è: non con mezzi
espressivi (tutto qui rispetta la più assoluta verosimiglianza e compostezza), ma con mezzi
compositivi, precisamente con un montaggio: non con la rappresentazione, ma con
l’immagine.
E infatti a ben guardare, e con mezzi estremamente sobri e senza alcuna forzatura,
l’immagine si compone via via in quattro inquadrature: la prima è un totale, la seconda un
piano americano, la terza un primo piano, la quarta un primissimo piano. Ma non basta: la
scansione procede ad evidenza dall’alto verso il basso. Per cui è come se lo sguardo dello
spettatore fosse stato condotto via via ad abbassarsi, quasi come a inchinarsi di fronte alla
figura che via via si eleva verso l’alto. La figura resta immobile, ma lo sguardo assume,
grazie al montaggio, un movimento discendente e compone la rappresentazione in
un’immagine che porta con sé, alla lettera, i tratti dell’elevazione. Il senso dell’immagine, la
sua efficacia comunicativa dipende dunque da un atto di montaggio, da una precisa alternanza
dei punti di ripresa che decostruiscono e ricostruiscono l’immagine.
Questo è solo un esempio tra i numersossimi proposti da Ejzentejn nelle sue
incomparabili indagini sul montaggio e sul movimento nella pittura.
3.2. Ma se c'è montaggio in pittura - oltre che in letteratura, in teatro e in musica -
qual è allora la peculiarità del cinema? L’originale risposta di Ejzenstejn è la seguente: il
cinema può coinvolgere nell'insieme delle operazioni che convertono il dato rappresentativo
in immagine significante la più grande eterogeneità di elementi percettivi. Il montaggio
cinematografico, dunque, non è una combinatoria sequenziale di elementi visivi - come
troppo spesso si è creduto, e come Ejzenstejn rimproverava a Kulesov, Pudovkin e Vertov - è,
più radicalmente e profondamente, un grande lavoro di scomposizione e ricomposizione di
molti piani espressivi. In altre parole: il montaggio cinematografico porta al pieno
dispiegamento un principio che nelle altre forme artistiche può valersi solo di risorse limitate.
Nessun'altra forma artistica può convertire in immagine un quoziente così alto di dati
sensibili come fa il cinema, nessun'altra forma può far lavorare la percezione dello spettatore
su registri altrettanto molteplici. Lungi dal limitarsi al registro visivo, il cinema è innazitutto,
e fin dall'inizio, una grande orchestra di stimoli: «drammaturgia della forma», allora, significa
che in via di principio qualunque elemento di questa orchestra - dallo spazio alla luce, dal
movimento al gesto, dall'espressione fisiognomica alla parola, dal suono al colore ecc. - può
caricarsi direttamente di elementi del piano del contenuto, facendosi così veicolo di
significati e di emozioni che articolano la composizione del racconto cinematografico.
4. Facciamo alcuni esempi.
Mi riferirò in particolare al più bello e complesso tra i film muti di Ejzenstejn, Il
vecchio e il nuovo (1929, VN). Non c’è dubbio che si tratti di un film ‘narrativo’: racconta
infatti episodi della nascita e dello sviluppo di un kolchoz, cioè di una cooperativa agricola, e
ha anche - per la prima volta nel cinema di Ejzenstejn - un protagonista individuale: la
contadina Marfa che si fa promotrice del kolchoz. Ma da che cosa sono legati questi episodi?
Qual è il criterio della loro composizione? E’ facile vedere che si tratta proprio di un’azione
narrativa classica, una specie di romanzo di formazione: il film racconta, in parallelo alla
nascita e alla crescita della cooperativa agricola, la progressiva trasformazione dell’identità di
Marfa.
Ma è altrettanto facile vedere come questa azione narrativa non sia affidata solo alla
protagonista ma si carichi di numerosi altri piani di senso che non rompono l’unità del testo
ma la rimettono continuamente in questione, fino alla fine. Vediamo ora i nostri esempi.
Cominciamo da una sequenza in cui il montaggio (cioè la conversione della rappresentazione
in immagine) lavora prevalentemente all’interno dell’inquadratura:
La visita di Marfa al kulak che le nega il cavallo in prestito è composta essenzialmente
in profondità di campo e giocata su una dominante volumetrica: Marfa è sempre sovrastata e
schiacciata dalla potenza elementare, animalesca, di ciò che si oppone al suo progetto di
rinnovamento: le bestie, l’aspetto bestiale degli uomini. Ma la cosa che ci interessa, qui, è che
la linea narrativa si arricchisce, grazie alla composizione, di numerosi effetti concettuali.
L’immagine è sempre molto ‘densa’, e per questo deve fare appello (paradossalmente, perché
non può garantirlo) a un tempo di lettura prolungato (come quello della visione di un quadro).
E’ questo il tempo della simbolizzazione o dell'allegoria, un tempo poco ‘processuale’, se
così si può così dire. Ottobre , un film contemporaneo a VN, abbonda di queste condensazioni
che si potrebbero definire prevalentemente intellettuali: come se il cinema, secondo un’idea
sviluppata da Ejzenstejn in quegli anni, potesse concettualizzare in proprio, meglio: farci fare
l’esperienza della nascita di un concetto.
Vediamo ora una famosa sequenza di Ottobre: la «sequenza degli dei», che
Ejzenstejn. commenta, tra l’altro, nel saggio dedicato alla «drammaturgia della forma».
Il commento di Ejzenstejn si può leggere in Il montaggio, pp. 34-5. Ne riporto il passo
più significativo: «Qui il conflitto si svolge tra il concetto di ‘divinità’ e la sua
simbolizzazione. Mentre nell’immagine del Cristo barocco concetto e raffigurazione
appaiono in completo accordo, i due elementi si discostano sempre più ad ogni ulteriore
immagine. Si mantiene il concetto di ‘dio’ e lo si rappresenta con immagini che non
corrispondono alla nostra intuizione di tale concetto».
Qui è evidente (pur se non esplicito) il riferimento all’Estetica di Hegel, ma la cosa
davvero notevole è il fatto che, secondo le intenzioni di E., il lavoro dello spettatore viene a
collocarsi esattamente tra la rappresentazione sensibile (la figura) e il concetto, e gioca sulla
loro progressiva non coincidenza. Il flusso narrativo si interrompe e allo spettatore viene
chiesto di esercitare una specie di ragionamento per immagini.
Vediamo ora un esempio di quella modalità di montaggio che, secondo la scansione in
tre fasi teorizzata da Ejzenstejn in TGM (montaggio interno all’inquadratura, montaggio
sequenzaiale, montaggio audiovisivo) corrisponde al momento in cui l'immagine nasce
dall’alternanza dei punti di ripresa e dal ritmo della successione (vi ricordo che l’abbiamo
esemplificata con il quadro di Serov): la doppia sequenza della processione per la siccità e
della centrifuga.
Sia sul piano della grandi unità (il rapporto tra le due sequenze) sia su quello della
rispettiva scansione interna qui è assolutamente chiaro che si mira a un tempo processuale
(l’immagine, cioè, sta nel ritmo della successione: il piano del contenuto è: intensificazione
quantitativa che non arriva - nel primo caso - e arriva - nel secondo - a scaricarsi in una
trasformazione qualitativa). Ma la cosa che ci interessa di più è che qui al processo di
produzione dell’immagine coopera una pluralità di registri espressivi («drammaturgia della
forma») che arricchisce e articola le medesime possibilità del racconto.
La processione procede prevalentemente col livello che Ejzenstejn considerava il più
elementare: la recitazione. Ma c’è anche un crescendo giocato su elementi della forma
sensibile: calore, tensione, caricamento ecc. Come una molla che si carica ma non viene
rilasciata. Questo scarico della tensione avviene nella sequenza successiva (la centrifuga), ma
qui la forma abbandona immediatamente il livello recitativo per innestarne via via molti altri:
fa giocare il movimento in quanto tale, la luce, e infine elementi che prescindono da ogni
preoccupazione di verosimiglianza narrativa (i getti d’acqua che mirano esclusivamente a
introdurre una componente di intensificazione; i numeri che mirano a introdurre una
componente intellettuale ecc.).
Diverso è il terzo caso, il montaggio audiovisivo, che compare nel film solo per
accenni. E’ tuttavia del più alto interesse che compaia in un film muto. La sequenza più
interessante, per noi, è quella del grillo e della falciatrice.
Per comprendere il senso, strettamente narrativo, della sequenza noi abbiamo dovuto
mobilitare simultaneamente numerosi schemi percettivi, compreso un decisivo schema
sonoro. Intendo dire che la medesima leggibilità dell’immagine non può prescindere
dall’attivazione di questo schema sonoro. Abbiamo dovuto inoltre sovrapporre al tempo
lineare una serie di ritensioni e di protensioni, in un complesso andirivieni (dal rumore del
grillo a quello della falciatrice, dalla forma delle zampine del grillo a quella delle pale
meccaniche). Abbiamo insomma lavorato, in funzione del racconto, con una figuratività
complessa e con una temporalità complessa. E’ questo il tipo di esperienza narrativa che
l’audiovisivo rende possibile.
Ora vediamo meglio come funziona per Ejzenstejn l’autonomia narrativa
dell’immagine cinematografica (e in particolare audiovisiva): come un gioco complesso di
mobilitazione sensibile a cui è sempre connesso un lavorio del pensiero.
Ne possiamo trarre questa conclusione: il cinema nasce multimediale e il racconto
autonomo del cinema non deve far altro che imparare a servirsi narrativamente di questa
multimedialità.
Ejzenstejn, come si è detto, sintetizzava questo pensiero nel concetto di
«drammaturgia della forma cinematografica». Da un punto di vista narrativo ciò significa che
qualsiasi elemento della forma, dallo spazio alla luce, dal colore al suono, dal gesto alla
parola, può caricarsi direttamente di compiti narrativi.
E’ facile vedere che questa potenzialità dell’immagine audiovisiva è stata sfruttata
pochissimo. Pensate al colore: nel migliore dei casi ha una funzione espressiva, ma quanti
film vi vengono in mente in cui il colore ha una funzione narrativa o drammaturgica?
Pensiamo a Schindler’s list (al valore drammaturgicamente determinante delle due sequenze
in cui compare il cappottino rosso); molto felice anche l’uso direttamente drammaturgico del
rapporto bn/colore in Pleasentville. E poi Hitchcock (Vertigo), Fellini (Giulietta degli spiriti),
Von Trier (Europa), Greenaway (Il ladro, il cuoco...), Jarman (Wittgenstein, Blue),
Almodovar (Tutto su mia madre)... Ma il conto si esaurisce presto.
6. Vorrei ora toccare un altro punto che deve portarci a prendere in considerrazione la
teoria dell’immagine e del montaggio di Dziga Vertov.
Il punto è questo: il cinema, abbiamo visto, può sviluppare (anche se lo ha fatto solo
abbastanza marginalmente) questo progetto di massimo dispiegamento della drammaturgia
della forma (cioè della sua intrinseca multimedialità) sul piano narrativo. Ma può anche
capitare che il cinema si orienti verso la sua natura mutimediale per farne un oggetto di
racconto. Ebbene, qui scopriamo una cosa molto notevole, e su cui si è riflettuto poco: cioè
che questa scelta il cinema l’ha fatta molto più spesso di quanto non si creda, e non solo in
modo intenzionale ma anche in modo quasi istintivo, quasi fisiologico. E’ accaduto e accade
molto spesso che il cinema abbia accordato proprio alla sua multimedialità il compito di
condurre il gioco narrativo.
Qualche esempio a caso: Blow up di Antonioni, Blow out di De Palma; La
conversazione di Coppola; Lisbon’s story di Wenders. Ma se allarghiamo il nostro modello di
riferimento il campione si estende in modo impressionante: pensate all’inserimento narrativo
dell’elemento pittorico (Paris Texas, Deserto rosso, La ricotta, Passion, Il mistero del
giardino di Compton house...), oppure teatrale (Zio Vanja nella 43 strada, Teatro di
guerra...), oppure televisivo (Videodrome, Autostrade perdute, Truman Show...), oppure
fotografico (Shining, La doppia vita di Veronica, Prima della pioggia...), per non parlare
dell’elemento cinematografico (a tutti i livelli: dal filmino amatoriale come in Muriel o in
Palombella rossa al videotape al film che racconta se stesso), dove gli esempi sono una
legione (mi limito solo a tre esempi diversissimi: Lo stato delle cose, Matinée, Sotto gli ulivi),
fino all’insieme di tutti questi livelli, come in molti film di Godard, compreso Passion, o in
molti film di Orson Welles, in particolare F for Fake.
Questi esempi sono talmente numerosi e talmente diversi tra loro da far nascere un
sospetto: che non si tratti affatto di una scelta stilistica, o di una ‘poetica’, ma di qualcosa che
riguarda la natura stessa dell’immagine nel senso di Ejzenstejn. Dunque: un tratto peculiare
dell’esperienza narrativa autonoma che il cinema è capace di farci fare.
Ora, di questo fenomeno notevole noi troviamo una magnifica spiegazione nel cinema
e nella teoria dell’immagine di Dziga Vertov (che fu un contemporaneo di Ejzenstejn), su cui
dobbiamo fermarci per concludere.
5.1. Vertov era per un cinema delle ‘cose stesse’, dei ‘fatti’, della ‘realtà’. Vertov
condannava senza appello il cinema che si rifà a modelli letterari o teatrali; il cinema che
illustra testi belli e pronti o che scimmiotta il teatro e il racconto, a cui contrapponeva il
progetto di un «cinema non-recitato». Se le cose stanno così qual è il contributo che può
offrire alla nostra riflessione, che riguarda il racconto cinematografico, cioè il cinema di
fiction?
Questo contributo, che è straordinario almeno quanto quello di Ejzenstejn, si può
riassumere in due parole d'ordine di Vertov: da un lato c'è l'idea del Kinoglaz, il
«cineocchio», inteso come «la vita colta sul fatto» e dall'altro c'è l'idea di «film che
producono film», l'idea di un'interminabilità di questo lavoro che coglie e fissa la vita. Come
vedete i due slogan si dispongono in un campo di tensione tra vita e forma al cui interno si fa
strada l'intuizione fondamentale di Vertov.
L'intuizione è questa: il Kinoglaz, l'occhio che esplora le cose nel loro accadere, che si
immerge nella fattualità e nella contingenza del mondo è, al tempo stesso, un elemento di
quella fattualità e di quella contingenza; non è un occhio esterno al mondo che va
riprendendo ma ne fa parte. E' un occhio che vede ma è anche visto, e dunque non può vedere
tutto: soggetto e oggetto della visione, vedente e visibile, luogo di attività e di passività. Ora,
questo essenziale sdoppiamento della visione si proietta, per Vertov, sull’immagine,
trattenendola in una condizione intermedia tra la cosa vista e l’atto del vedere.
Nulla sarebbe più sbagliato, dunque, che ridurre l’esperienza di Vertov nel contesto
del cosiddetto «documentarismo». Un concetto, questo, contro cui Vertov non smise di
polemizzare duramente. Noi cadremmo in un fraintendimento completo se pensassimo che
l'alternativa alla finzione sia quella di un cinema ‘mimetico’ che documenta la realtà come se
la realtà fosse già bella e pronta per essere documentata.
Mimetico, al contrario, è per Vertov proprio il cinema di finzione perché il suo modo
di rappresentazione non è originario ma derivato, cioè è una rappresentazione che non si
fonda su un’autonoma formatività, ma dipende da altre forme: il teatro, le arti figurative e
soprattutto la letteratura.
Vertov ha dunque percepito con assoluta lungimiranza (pochissimi come lui: per es.
Benjamin) che il nuovo strumento di rappresentazione è stato fin qui utilizzato ben al di sotto
delle sue possibilità, le quali potrebbero invece inaugurare una rivoluzione nel nostro
rapporto con il mondo visibile. Ma anche con il mondo udibile, va aggiunto, perché Vertov
pensò fin dall'inizio il cinema in termini audiovisivi, anche se non ne esisteva ancora la
possibilità tecnica (anzi, storicamente, i primi esperimenti di Vertov furono ricerche sul
suono e il primo film sonoro russo fu di Vertov: La sinfonia del Donbass del 1931)
Vertov comincia a sperimentare queste idee nel suo giornale cinematografico, la
Kinopravda, di cui uscirono 23 numeri dal 1922 al 1925. Kinopravda significa la Pravda
cinematografica, cioè un giornale che realizza nel cinema l'analogo del quotidiano Pravda.
Ma significa anche la pravda, la «verità» delle cose, così come il cinema la può far apparire e
mettere in forma. O meglio ancora - e indichiamo così un altro punto assolutamente
qualificante il cinema non-recitato - la verità che si dichiara come «verità cinematografica»,
si autodenuncia per quello che è ricordando allo spettatore che ciò che sta vedendo è cinema.
Il cinema non-recitato prevede dunque uno spettatore distanziato, critico, mai
assorbito nell'illusione, a cui viene continuamente ricordata la situazione enunciativa di cui
sta facendo esperienza con una strategia, più o meno complessa, di rimandi autoreferenziali
(la Kinopravda si apre spesso con un'autocitazione: l'immagine di un rullo che viene inserito
nel proiettore).
6. Ho parlato di una strategia più o meno complessa, perché in effetti la Kinopravda
ebbe per Vertov una funzione propedeutica, una scuola per la «cinematizzazione», come la
chiamava in analogia con «alfabetizzazione». Ma se l'esperienza della Kinopravda resta
ancora un compromesso con le forme usuali della cronaca cinematografica, con il progetto
intitolato Kinoglaz (1924) Vertov si spinge oltre ogni ancoraggio meramente documentario e
procede al primo vero tentativo di cinematografia non recitata.
Kinoglaz fu progettato come una ricognizione in sei fasi (provvisoriamente, perché
l’impresa aveva l’ambizione di diventare permanente). Ma Vertov, a cui furono bloccati i
fondi, realizzò solo la prima, quella che potete vedere oggi col titolo Kinoglaz. Vertov in
realtà aveva definito questa prima serie con la parola d'ordine: Zizn' vrasploch, «la vita colta
in flagrante» o «sul fatto». Una prima ricognizione del tutto intuitiva, fondata
intenzionalmente sulla semplice registrazione delle prime impressioni colte girando per la
città e i luoghi di lavoro.
E' decisivo capire che qui di programmatico vi era proprio la mancanza deliberata di
un programma. Cioè: il Kinoglaz deve partire da un fare impressionistico, passivo, ma il
materiale così raccolto non è altro che il set delle successive elaborazioni. Queste non solo
saranno del tutto attive, cioè dovranno organizzare, interpretare ed estendere la realtà visibile
posta sotto costruzione; ma saranno anche esplicitamente riferite a una realtà di cui il
kinoglaz è parte, dovranno cioè esplicitare lo sguardo del kinoglaz come uno sguardo interno
al mondo visibile di cui organizza l'intelligibilità. Infatti, dopo la prima ricognizione
sarebbero entrate in funzione numerose macchine da presa.
Come vedete questo non ha niente ache fare con il necessario impressionismo della
prima ricognizione del kinoglaz e inoltre è il contrario dell'idea di una documentazione
oggettiva dei fatti: è invece un lavoro di interpretazione complessa della realtà visibile
dall'interno della realtà visibile.
Il suo primo, costitutivo, contrassegno strutturale è che la visione si sdoppia
esplicitamente in cosa vista e atto del vedere (osserveremo tutto questo in L'uomo con la
macchina da presa). Il secondo è che questo insieme costituito dalla cosa vista e dallo
sguardo si apre in via di principio a un processo di interminabile ridefinizione. Quello che ho
definito il set del kinoglaz si allarga, cioè, in un processo di interpretazione illimitata che si
rivolge a una comunità di comunicazione autorizzata a incrementarlo ulteriormente in modo
produttivo, cioè con un'attiva pluralità di punti di vista (rete è la parola usata da Vertov).
Ne risulta che l'immagine cinematografica, grazie a Vertov, ci svela un aspetto
essenziale della sua natura: quello di essere in via di principio un'immagine intimamente
sdoppiata, cioè una presentazione della cosa vista e insieme presentazione dell'atto del vedere.
Dunque è un'immagine che non si compie mai in se stessa, che può e deve farsi oggetto di
inesauribili riprese, di commenti infiniti (dunque: di «film che producono film»).
Vertov qui anticipa un tema fenomenologico che sarà centrale nella filosofia di un
grande filosofo moderno, Merleau-Ponty: lo sguardo non è fuori dal mondo, ma ne fa parte, il
vedente vede solo in quanto è anche visibile. Merleau-Ponty parlava della visione come di
una «precessione di ciò che è su ciò che è visto e mostrato e di ciò che è visto e mostrato su
ciò che è» (L’occhio e lo spirito). Ebbene questo raddoppiamento costitutivo della visione,
questo andirivieni dalla cosa all'immagine e dall'immagine alla cosa che fa sì che il mondo sia
oggetto di un'esplorazione inesauribile è esattamente il tema essenziale del cinema di Vertov.
E’ un peccato che Bazin, che la pensava esattamente nello stesso modo, non se ne sia accorto
(ma per mancanza di documentazione adeguata).
Voi vedete bene che questo lavoro che aspira a cogliere le cose stesse non solo è
costitutivamente sdoppiato, ma è anche interminabile. Infatti Vertov fa esplodere il concetto
di film-opera e lo sostituisce con quello di «film che producono film».
Quando, nel 1975, Orson Welles realizza il suo film più complesso, F for fake, sembra
proprio che abbia in mente un esperimento narrativo perfettamente esemplato sulla teoria
dell’immagine di Vertov.
Ora, in che modo la fondamentale intuizione di Vertov potrebbe farci capire meglio la
tendenza del cinema ad assumere la propria multimedialità come oggetto di racconto? La
risposta è semplice.
Vertov ha mostrato che se la relazione tra realtà e simulazione, tra dato e costruito è
costitutiva dell'immagine, allora il cinema sembra avere la facoltà di lavorare precisamente
nell'«intervallo» (altro termine caratteristico della teoria di Vertov) tra i due, nell'andirivieni
tra il dato e il senso. Attenzione: non si tratta di una poetica dell'autoriflessività (del tipo di
quella che fu cara ai formalisti russi e a tanto - spesso mediocre - cinema contemporaneo), ma
dell'individuazione e della messa a frutto di un tratto costitutivo dell'immagine
cinematografica.che ci fa vedere meglio dove la drammaturgia della forma può esercitare la
sua più grande autonomia, qual è il territorio dell’immaginario narrativo di cui può garantire
un’esplorazione impareggiabile.
Se le cose stanno così ci si potrà dunque aspettare che un cinema narrativo capace di
raccogliere la lezione di Ejzenstejn e di Vertov faccia largo e forse sistematico uso di
sdoppiamenti e che tenda a narrativizzare proprio lo spazio che si apre nel cuore
dell’immagine. E si capisce, allora, la tendenza a far lavorare questi sdoppiamenti sulle forme
mediali: per es. il rapporto tra colonna sonora e visiva, tra sguardo fotografico e sguardo
naturale, tra cinema e televisione ecc.
Ma ci si dovrà anche aspettare che questo cinema sia portato a elaborare con
particolare insistenza la questione della chiusura del testo o anche, di nuovo, sia portato, per
così dire, a introiettarla, a darle una pertinenza tematica (per es. mettendola intenzionalmente
in questione: e allora si potrà parlare anche di una poetica, per es. quella del cinema
cosiddetto ‘moderno’ ecc.).
Per concludere: vediamo ora con più chiarezza i termini della possibile risposta
creativa del cinema alla sfida di un’estetica del videogame e di una sostituzione del narrativo
con la spetacolarità del virtuale: questa risposta non è regressiva, non è una fuga nostalgica,
al contrario è la piena valorizzazione delle potenzialità dell’audiovisivo che erano chiare al
cinema fin dalla sua nascita. In altri termini: se il cinema racconta in modo autonomo, lo fa
sfruttando creativamente la sua multimedialità; inoltre la natura doppia dell’immagine
cinematografia apre tutto un campo di soluzioni narrative in cui questa multimedialità diventa
a diverso titolo l’oggetto del racconto, o più precisamente, entra a far parte del racconto
facendo in modo che sia proprio il conflitto o il rapporto multimediale a configurare la
narrazione. Si apre qui la possibilità di un’interazione tra immagine cinematografica e
immagine elettronica che è ancora tutta da esplorare.