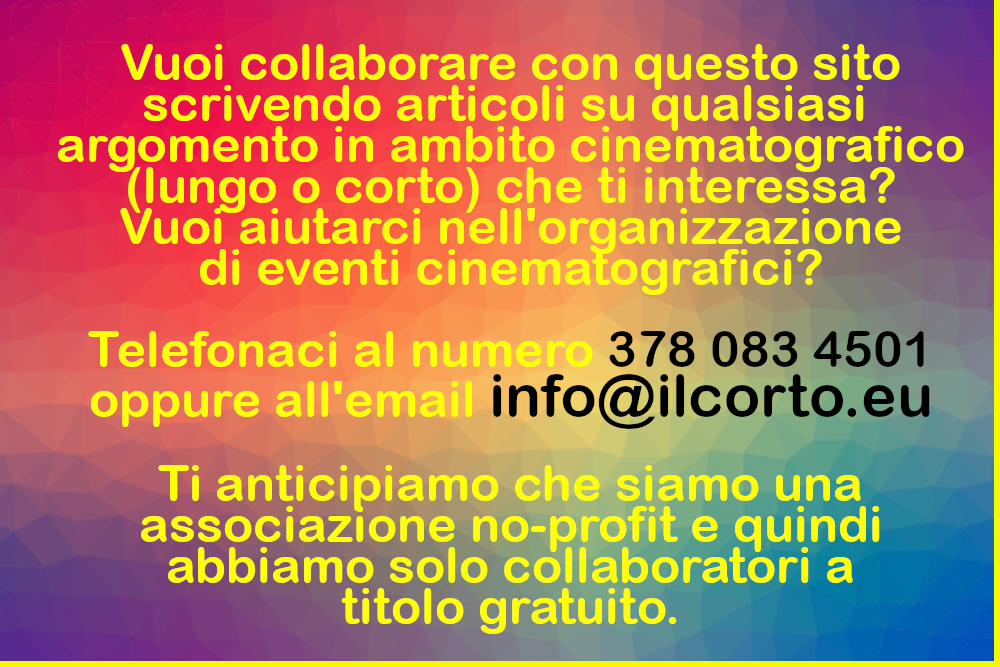Los Angeles. Appena scaricato da un’azienda di armamenti dipendente dal Ministero della Difesa statunitense, il cinquantenne Bill Foster (Michael Douglas) è affetto da un disturbo di personalità borderline che lo ha costretto a tornare a vivere con la madre (Lois Smith) dopo la separazione dalla moglie Elisabeth (Barbara Hershey) costatagli anche un ordine restrittivo che gli impedisce di avvicinare la piccola figlia Adele (Joey Hope Singer). Il suo disagio esplode la torrida mattina del compleanno di quest’ultima quando, dopo essere rimasto bloccato in un pazzesco ingorgo sulla freeway, abbandona la sua macchina (targata D-FENS) per l’ira degli altri automobilisti coinvolti tra i quali c’è anche l’anziano sergente LAPD, Martin Prendergast (Robert Duvall) che sperava di passare diversamente le sue ultime ore di servizio prima della pensione.
Los Angeles. Appena scaricato da un’azienda di armamenti dipendente dal Ministero della Difesa statunitense, il cinquantenne Bill Foster (Michael Douglas) è affetto da un disturbo di personalità borderline che lo ha costretto a tornare a vivere con la madre (Lois Smith) dopo la separazione dalla moglie Elisabeth (Barbara Hershey) costatagli anche un ordine restrittivo che gli impedisce di avvicinare la piccola figlia Adele (Joey Hope Singer). Il suo disagio esplode la torrida mattina del compleanno di quest’ultima quando, dopo essere rimasto bloccato in un pazzesco ingorgo sulla freeway, abbandona la sua macchina (targata D-FENS) per l’ira degli altri automobilisti coinvolti tra i quali c’è anche l’anziano sergente LAPD, Martin Prendergast (Robert Duvall) che sperava di passare diversamente le sue ultime ore di servizio prima della pensione.
Da quel momento, la giornata di Foster diventa una personale discesa agli inferi parallela a un’escalation inarrestabile e parossistica di follia e violenza: perché Bill dapprima distrugge un minimarket gestito da un coreano dopo aver questionato per un futile motivo (il prezzo di una lattina di soda), quindi malmena due balordi ispanici dopo aver sconfinato nel loro quartiere, poi si incaponisce al telefono con l’ex moglie per portare a tutti i costi un dono alla sua bambina nonostante il provvedimento disciplinare che lo riguarda. Da quel momento, dopo altre manifestazioni di rabbiosa aggressività, “D-FENS” entra nel mirino proprio di Prendergast e della sua giovane collega Sandra Torres (Rachel Ticotin): e finirà con l’uccidere a sangue freddo un fanatico neonazista (Frederic Forrest) proprietario di un negozio di abbigliamento militare dopo che questi avrà distrutto il regalo di Adele al termine di una furiosa lite ideologica. Oltrepassando senza possibilità di redenzione o salvezza il suo punto di non ritorno.
Presentato nelle sale americane il 26 febbraio 1993 e poi (troppo audacemente) invitato in concorso al Festival di Cannes qualche mese dopo, “Un giorno di ordinaria follia” (Falling Down) di Joel Schumacher è stato un film di grande successo (anche da noi, dove uscì immediatamente dopo la presentazione sulla Croisette) malgrado le sue qualità intrinseche fossero ben distanti da quelle del cinema “d’autore” hollywoodiano che pure qualcuno all’epoca fu pronto a riconoscergli. Interpretato da un cast di prim’ordine (Douglas era all’apice della sua carriera, dopo “Attrazione fatale”, “Wall Street”, “La guerra dei Roses” e “Basic Instinct”, e non si riesce a immaginare un altro attore coevo nel ruolo; Duvall già un mostro sacro), poggiava su una sceneggiatura (di Ebbe Roe Smith) volutamente in bilico tra un registro dichiaratamente grottesco e una volontà di fotografare le tensioni sociali e private dell’America che di lì a poco sarebbe stata “clintoniana” ma su cui ancora pesava la gestione di George Bush sr; ed è un film oggi forse giustamente dimenticato ma che resta suo malgrado un esempio limpido di cascame fuori tempo massimo del cinema mainstream più isterico e a suo modo irripetibile che ha caratterizzato tutti gli anni Ottanta e che sarebbe forse continuato se non fosse stato spazzato via definitivamente da Quentin Tarantino (“Pulp Fiction” è del 1994) e soprattutto dai suoi numerosissimi e impari epigoni.
Tuttavia, a voler ben vedere, come giustamente puntualizzava all’epoca il famoso critico Roger Ebert, le radici più profonde di “Un giorno di ordinaria follia” sono addirittura da ricercarsi nel decennio precedente, e in particolare in “Quinto Potere” (Network, 1976) di Sidney Lumet: dove l’anchorman squilibrato Howard Beale, al grido di “Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più!” esortava i suoi spettatori a ribellarsi a un ordine delle cose pesantemente sfuggito di mano a scapito del cosiddetto “cittadino medio”. Nell’era della grande recessione Usa, il film di Schumacher fu effettivamente per i primi anni Novanta ciò che quello (parimenti retorico) di Lumet fu per l’era post-Watergate: uno strumento con cui valutare lo stato comatoso della Nazione uscita dalla presidenza Nixon e traghettata da Ford prima e Carter poi in un cambiamento analogo a quello promesso da Clinton, e quindi la pantografia di una “malattia dello spirito” che rifletteva tutti quei motivi per cui quel cambiamento era di fatto necessario e auspicabile.
Probabilmente, in mano a un regista meno (amabilmente) rozzo, “Un giorno di ordinaria follia” e il suo eroe Bill Foster/D-FENS sarebbero diventati il paradossale paradigma ideologicamente cortocircuitato di un (anti)eroismo certamente “sbagliato” ma in qualche misura “necessario”. E del resto, ad andare in scena tra le righe era anche l’epilogo di tre legislature repubblicane a fila e del loro pesante lascito sociale: diseguaglianza economica, orrore per l’altro da sé, rigurgiti fascistoidi, disoccupazione e disintegrazione capitalista della stessa etica del lavoro; nonché la dissoluzione dei confini tra ideologia “reazionaria” e semplice desiderio di rivalsa (come mostra benissimo la lite “teorica” tra il neonazista del negozio e Foster, che pur agendo “in opposizione” depreca la forma mentis perversamente odiante dell’uomo). Ma a quella dimensione beffardamente catartica para-eastwoodiana a cui il film avrebbe potuto ambire si sostituisce progressivamente una più cartoonesca (e cialtronesca) declinazione “diurna” della furia bronsoniana (leggi “Il giustiziere della notte”) sciolta con la più “naturale” ma qualunquista delle soluzioni.
Perché dapprima il film chiede quasi di parteggiare per l’everyman impazzito che reagisce a un mondo-giungla altrettanto fuori controllo, ma poi ci fa quasi sentire in errore o vergognarci per averlo fatto, quando l’inevitabile autodistruzione del protagonista viene oltretutto propiziata da una giustizia forse superiore che però ancora una volta si sostanzia nel distintivo di un tutore dell’ordine, seppur stanco e in qualche misura riluttante. Difficile dire a quali spettatori dell’epoca possa venir voglia, oggi, di celebrare il trentennale del film con una revisione, ma anche capire quale motivo d’interesse potrebbero avere i “giovani” che ne approccino una prima lettura: malgrado tutto, però, potrebbe non essere tempo perso né per gli uni né per gli altri.
Articolo di Filippo Mazzarella per www.corriere.it/spettacoli