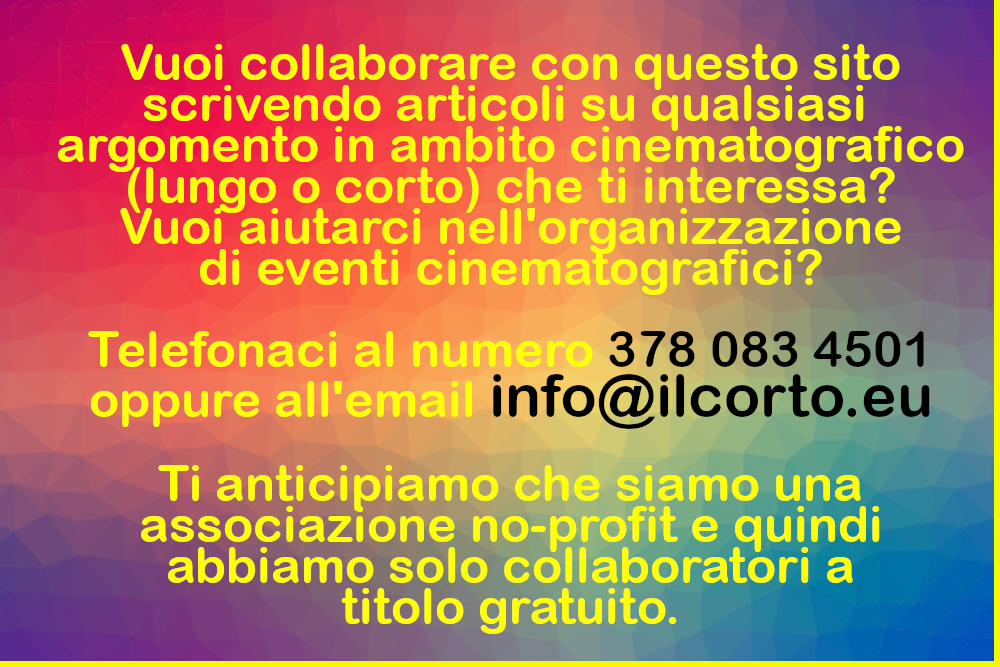“Giulia!”. La voce del Piero scendeva il fianco della collina crepata di caldo, si incuneava nella carona umida di robinie e rimbalzava sulla collina di fronte per disperdersi.
“Giulia!” chiamava sua madre venticinque anni prima in un pomeriggio identico a quello se non fosse che allora c’erano più uccelli nel cielo in stormo, come una nuvola di malaugurio che si estende e si riduce a capriccio e tu non sai quale sventura ti promette. Lei non riusciva a non pensare all’esame di riparazione di greco allora, mentre lo stormo si estendeva e si riduceva a capriccio
I pioli della scala di legno scricchiolavano e non si capiva come facessero a reggere mentre lei saliva sul fienile venticinque anni prima.
Sapeva che il ragazzo da dietro le vedeva le mutande sotto la gonna: era impossibile evitarlo. Avrebbe dovuto mandare su prima lui ma era salita prima lei e lui le veniva dietro col muso quasi nel suo sedere e a lei veniva da ridere per quella situazione indiscreta.
Giulia, venticinque anni dopo, nello stesso fienile, pensava che la vigna manda odore dalle foglie quando c’è tutto quel caldo estivo, e anche l’argilla delle colline esala odore attraverso le crepe del terreno.
Quegli odori, pensava, erano gli stessi di venticinque anni prima.
“Bisogna arare perché ci rimanga un po’ d’umido” diceva nonno Anselmo seduto al tavolo annerito. Il caffelatte fumava nelle tazze di terraglia sbeccate e il ragazzo annuiva con gli occhi furbi fissandola e lei sapeva che prima o poi l’avrebbe seguita su per la scala del fienile guardandole le mutande da dietro.
La voce del Piero si lamentò ancora nel caldo: “Giulia!”. Nonno Anselmo era già morto da un pezzo. Lei aveva dovuto chiedere il permesso in ufficio, a Milano, per venire a seppellire nonno Anselmo. Aveva inforcato la Uno bianca, era passata a caricare il Piero sotto alla ex-Motta, in Battistotti Sassi, ed erano corsi giù a Stradella che le
colline azzurre erano bellissime sullo sfondo perché era un’estate luminosa come quella di adesso ma nonno Anselmo se n’era andato al Creatore quella notte. I due ragazzi, Marco e Alfredo, non c’erano ancora allora, e Piero aveva ancora tutti i capelli sulla testa.
Venticinque anni prima il ragazzo con gli occhi furbi: “Saliamo in fienile oggi, quando dormono” le aveva sussurrato. “Per fare cosa?” aveva detto lei. “Quando ci siamo, vediamo” aveva detto lui.
Giulia ricordava ora benissimo l’odore del suo coso, come se fosse successo pochi minuti prima. Era l’odore del coso di un ragazzo dalla pelle liscia, odore come della polvere della terra crepata dal caldo o delle foglie delle viti scaldate dal sole a picco. E ricordava come se fosse successo cinque minuti prima il suo sapore salato, che poi lui l’aveva tenuta stretta in mezzo al fieno baciandole i capelli e “adesso faccio io” le aveva detto che aveva già la bocca fra le sue gambe e lei aveva spostato di lato le mutandine e per lei non era mai stato più così, mai più, mai più nella vita né con Piero né con nessun’altro.
“Che cosa rimane?” pensò Giulia quel pomeriggio di venticinque anni dopo.
Era un pensiero che la incalzava negli ultimi tempi. Le si offriva improvviso quando non se lo sarebbe aspettato e la innervosiva, le faceva lasciare la tastiera del computer e alzare la testa togliendo gli occhiali per guardare dai vetri il Pirellone che di fronte svettava nel cielo con gli uccelli in stormo che ci sbattevano contro a morirci perché erano ingannati dal riflesso delle nuvole nei finestroni. “Farcela” ripeteva a se stessa: “Devo farcela”. E: ”Devo farcela” aveva dovuto ripetere a se stessa ininterrottamente per tutti quei venticinque anni, dall’esame di riparazione di greco in poi. “Devo farcela” aveva gridato con le cosce spalancate sul lettino mentre espelleva dal ventre prima Marco e poi Alfredo. E sempre, sempre, aveva ripetuto “Devo farcela” aggirandosi con carte e pratiche e fotocopie in mano per gli uffici che guardavano il Pirellone eretto dal ventre della città come un pene.
Giulia si mise a piangere. Marco e Alfredo e Piero la stavano cercando, ma non sarebbero saliti in fienile. L’avrebbero cercata nella vigna, o nella carona all’ombra scura delle robinie, o fra i fichi che stavano cominciando a maturare i frutti verdini.
Giulia poteva piangere senza riguardo ora. Nessuno sarebbe venuto a cercarla lì. Le voci di Piero e dei ragazzi diventavano sempre più fioche mentre scendevano nella vigna, e lei poteva lasciare che i singhiozzi le scuotessero le spalle e il costato e i fianchi. Pensò che la sua bocca doveva sembrare quella di una maschera greca.
Non poteva sentirla piangere neppure il ragazzo con gli occhi furbi, sepolto sotto un metro e mezzo di terra nel cimitero appartato dove anni prima avevano inumato nonno Anselmo. Era tornato in una cassa di zinco dalla missione di pace in Bosnia, questo le avevano detto.
Giulia piangeva senza ritegno ora, abbandonata, e mentre piangeva una dolcezza nuova le inondava il ventre, il costato, la schiena, il corpo intero per via delle sue dita che la frugavano sotto i jeans aperti ed era quella la prima volta che non le pareva che qualcuno la guardasse mentre lo faceva, la prima volta, sotto i coppi malfermi e le travi scurite, nell’odore benevolo del fieno.
Era finalmente sola, Giulia, sotto il tetto di travi scurite e di coppi del vecchio fienile da cui filtrava la luce del cielo abbagliante che chiazzava il fieno, sola nel rumore delle cicale che fuori assordavano e ormai coprivano del tutto i richiami di coloro che la stavano cercando.
Sola.
Sola con il ragazzo dagli occhi furbi disteso nella sua cassa di zinco sotto un metro e mezzo di terra nel piccolo cimitero di paese poco distante che non l’aveva mai abbandonata in tutti quegli anni.
L'autore ringrazia Fabrizio Pedroni per l'editing del racconto che
commenta così (e non posso che essergliene enormemente grato):
C'è una malinconia diffusa e velata, quasi un anelito di ritorno al
ventre caldo e ovattato di una madre ideale, alla brama di protezione da
una vita per la quale nessuno ci prepara davvero e che procede
casualmente e inesorabilmente, a prescindere dal nostro essere pronti ad
affrontarne momenti e sfide; la sorpresa, stizzita e frustrante, di chi
conosce da tempo il mondo ma non si arrende alla consapevolezza che odora
di cinismo e disillusione. Conoscendo l'autore, è lo stesso velo che si
annida dentro ogni sua trama, che si svela in qualsiasi personaggio, che
caratterizza tutte le azioni. Il tentativo, sommo ed estremo, di
costruire una vita che non sia semplice somma di istanti, di decifrare le
regole di un universo che possa sperare in un ordine logico e matematico,
che sia bello, pulito, prevedibile, pur nel suo essere sempre
diverso da se stesso, come può esserlo una serie numerica che non sia
semplice successione casuale scandita dal ticchettio del prodotto di un
vecchio, stanco e inconsapevole orologiaio cieco. Ma questo non è, né può
essere, il difetto di questo racconto; semmai, è la cifra, il marchio a
fuoco di Renato.
di Renato Di Lorenzo <