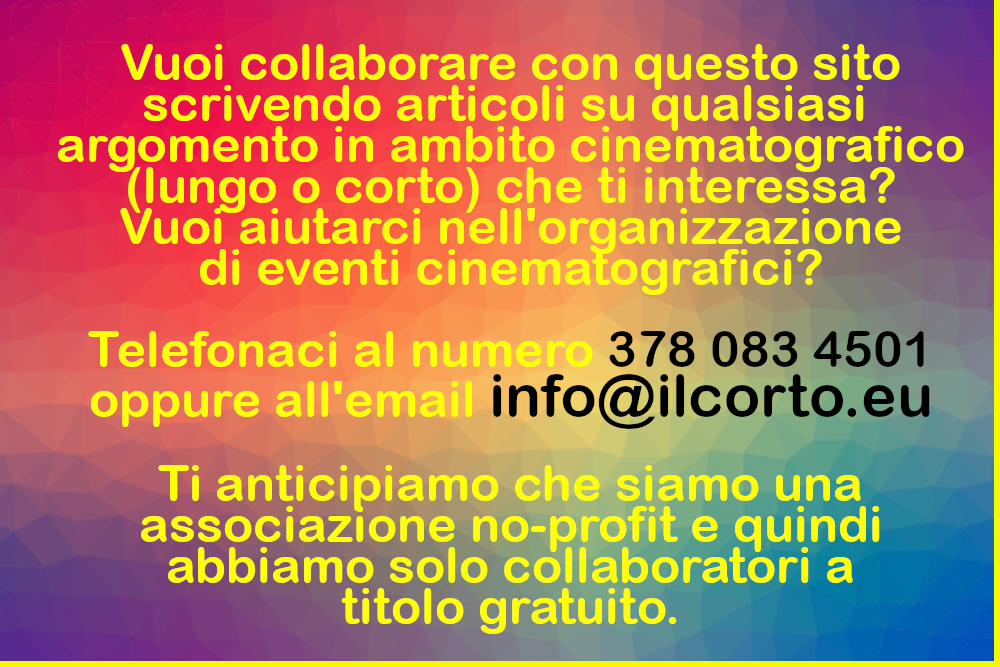Los Angeles o Manhattan? Il premio oscar Giuseppe Tornatorenon sceglie: «A me il cinema americano piace tutto. Loro sono l’industria, ma dall’Italia hanno davvero imparato molto»
Il cinema americano è sempre stato prioritario, decisivo nella storia di quest’arte così straordinaria. E noi ne siamo stati tutti affascinati e condizionati in maniera sostanziale. È tuttora così, anche se spesso siamo portati a pensare che oggi la cinematografia d’oltreoceano non sia più grande com’era una volta. Ma credere che quello che viviamo oggi sia meno importante di quello che abbiamo vissuto ieri, è un vizio comune nel quale inciampiamo spesso e temo che sarà sempre così anche tra cinquant’anni. Personalmente, come spettatore vedo e amo tutto e il contrario di tutto. La prima volta che sono entrato in una sala da solo me la ricordo ancora. Davano Gli argonauti di Don Chaffey (1963), la storia di Giasone alla conquista del vello d’oro: un film tutto effetti speciali, che mi ha letteralmente folgorato. Poi ho adorato John Ford e la grande epopea del western americano, L’uomo che uccise Liberty Valance (1962) è un’opera per me importantissima.
Come i divi, i grandi attori, da Robert Mitchum a Paul Newman, che sono i primi che mi saltano in mente. E Marilyn Monroe, che da ragazzino mi piaceva da pazzi. Però amavo tantissimo anche Bette Davis, straordinaria, grande, grandissima. E quando nel 1972 è venuta in Italia insieme a Joseph Cotten a girare con Luigi Comencini Lo scopone scientifico, a fianco di Alberto Sordi e Silvana Mangano, mi è sembrata una cosa davvero straordinaria. Mi fa sempre questa impressione tutte le volte che dei grandi attori americani arrivano a lavorare qui da noi: trovo sia un modo eccezionale per dimostrare che i legami tra il nostro cinema e quello americano sono molto più forti di quel che pensiamo. Ma arriviamo agli anni ’80, con altri fantastici protagonisti della storia del cinema: Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg che hanno segnato una stagione cinematografica fondamentale.
Trovare le ragioni vere della supremazia incontrastata del cinema Usa però non è semplice. Ci hanno provato in tanti, da sempre. Di sicuro è un’industria potente, la seconda più importante del Paese, e questo gli dà più forza, più energia. E ha fatto nascere più scuole. E non si tratta solo di scuola di New York o di Los Angeles, la prima più vicina all’Europa, più “antropomorfica” come direbbe Visconti, la seconda più attenta al consumo e al cinema di “genere”. L’aspetto più importante è che gli americani hanno sempre pensato all’arte del cinema come a una materia da studiare e da insegnare, mentre qui da noi è sempre stata considerata la strada per chi voleva tentare la fortuna. In più in America, a differenza di quel che capita in Europa, non c’è mai stata difficoltà a coniugare contenuti e divertimento. Da noi si è sempre considerato che solleticare il pubblico sia una cosa che non si fa, e così il cinema d’autore ha una casella e quello “di genere” ne ha un’altra. Loro, invece, non hanno mai avuto il complesso di fare film per divertire, sconvolgere, intrattenere gli spettatori. Come non si sono mai preoccupati dei limiti: gli americani fanno i film come si deve e se non hanno i mezzi non li fanno. Noi ci siamo sempre dovuti arrangiare, anche se questo - con tutte le implicazioni positive e negative che ne derivano - ci ha fatto produrre del grandissimo cinema.
Ma c’è un’altra ragione, secondo me, alla base della supremazia del cinema statunitense: è che riesce a ispirarsi e prendere dagli altri senza crearsi problemi. Anzi ammettendolo serenamente. Un esempio: il cinema d’impegno civile degli anni ’70, come Tutti gli uomini del presidente di Alan Pakula (1974) o I tre giorni del condor di Sydney Pollack (1975), ha preso le mosse dal nostro cinema impegnato di quegli anni. In fondo gli americani si sono nutriti di noi più che noi di loro. Sono meno chiusi e settorializzati, più aperti rispetto a noi europei che, condizionati anche dalla storia dei nostri Paesi, siamo sempre costretti a lottare per poter esistere. Sono più aperti in assoluto. Un “vecchio” come Clint Eastwood in Italia farebbe fatica a lavorare. Non gli darebbero una lira per fare un film, come a tutti i nostri grandi vecchi che allo scoccare dei 70 anni hanno cominciato ad avere difficoltà a trovare un produttore.
Sì, certo, c’è l’eccezione di Mario Monicelli, ultranovantenne ancora all’opera: però, quanto ha faticato per fare il suo ultimo film? Fosse stato in America avrebbe lavorato di più e con tempi di attesa molto più brevi. Adesso però anche oltreoceano qualche segno di crisi creativa si intravede. Puntano sui remake (a questo proposito, sta per uscire anche quello del mio Stanno tutti bene, con De Niro al posto di Mastroianni, e io lo aspetto con curiosità e con lo stupore che mi prende tutte le volte in cui un mio film viene amato in Paesi diversi da quello per cui era stato pensato), ripiegano sulla fantascienza e sembra che di quel grande cinema resti poco, che ora ci sia meno grandezza di allora. Stavolta però non è colpa del voler vedere l’ieri meglio dell’oggi, piuttosto dipende forse dall’immane rivoluzione tecnologica che sta trasformando la cinematografia mondiale. E che causa smarrimento.
Giuseppe Tornatore
24 marzo 2009
da: http://www.corriere.it/cinema