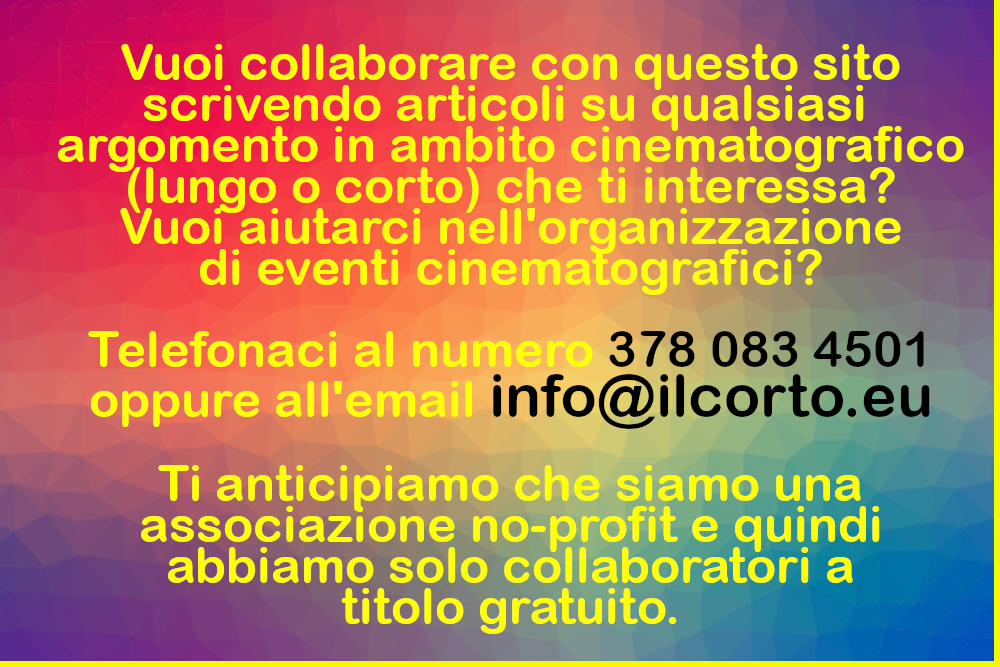Le lezioni di Gianfranco Manfredi
In questa lezione si prendono in esame altri due modelli di presentazione del protagonista, modelli molto diversi tra loro, ma che hanno una caratteristica in comune: il protagonista è anche il narratore del film. Questa soluzione corrisponde, in romanzo, al racconto in prima persona.
I due diversi modelli sono:
1. La voce fuori campo ( o Voce Off) del protagonista si sovrappone alla scena, anche quando lo stesso protagonista già compare nella scena. E’ un modello che proviene dalla narrativa e in particolare dal “noir”, dai gialli in cui il protagonista (spesso un detective, ma non necessariamente) ricostruisce e racconta i fatti dopo che essi sono avvenuti. Il racconto è dunque racconto del passato, la voce narrante è la voce della memoria: la memoria del protagonista e la “futura memoria” di chi ascolterà il suo racconto. Billy Wilder ha usato questo modello in modo esemplare in due suoi capolavori:La Fiamma del Peccato , in cui il protagonista-narratore si confessa al registratore, già moribondo, e Viale del Tramonto in cui il protagonista-narratore è addirittura un morto, il suo racconto è dunque il racconto di un fantasma. C’è sempre un tono di confessione drammatica, anche quando il racconto non indulge affatto al sentimentalismo, in questo procedimento narrativo. Usarlo fuori da questo contesto non è in linea di massima consigliabile.
2. Il protagonista parla direttamente al pubblico, in voce e in persona, guardando nella macchina da presa e presentandosi, spesso su sfondo neutro. Questo modello proviene dal teatro, dove si chiama à part. Nella commedia dell’arte e nel teatro settecentesco derivato dalla commedia dell’arte (vedi Marivaux o Goldoni) la rappresentazione, al principio o in corso, viene come congelata e sospesa. Il protagonista fa un passo avanti e si rivolge direttamente alla platea, a volte per rivelare propri pensieri nascosti ( che devono restare nascosti agli altri personaggi) a volte per instaurare un rapporto diretto con il pubblico, uscendo così dalla storia narrata e rivelandosi come narratore, commentatore, persino come autore della messa in scena. Questo modello è tipico della commedia brillante. C’è infatti un’evidente ironia nel fatto che il protagonista prenda, come narratore, “distacco” dalla vicenda e persino da se stesso come personaggio.
Cos’hanno in comune dunque questi modelli? Il coro, che nel modello “parlano di lui” della Prima Lezione esercitava di fatto il ruolo di chi introduce al pubblico il protagonista e riferisce le premesse indispensabili a comprendere la storia che seguirà, perde la sua coralità, non è un insieme di voci, ma una galleria di figure distinte: “gli altri personaggi” . Non è il coro (la società) a narrare i fatti, ma lo stesso protagonista (l’individuo). La vicenda è tutta raccontata dal punto di vista del protagonista. L’oggettività di quanto accade è dunque una ricostruzione soggettiva.
Questo comporta una scelta che dominerà tutta la narrazione successiva. Il protagonista può raccontare solo fatti cui ha assistito personalmente o di cui è venuto direttamente a conoscenza. Dunque lo sceneggiatore non potrà facilmente staccare su un’altra situazione, su eventi paralleli che il protagonista non ha vissuto e non conosce. Il protagonista sarà sempre in scena. E quando non ci sarà dovrà comunque essere al corrente di quanto è accaduto indipendentemente da lui.
Il genere drammatico e quello comico si prestano particolarmente ai due diversi modelli proprio perché in entrambi il protagonista, le sue riflessioni, la sua esperienza di vita, sono il vero centro della narrazione. E la narrazione è anche racconto della sua “presa di coscienza”.
Questo non significa però che ogni altro personaggio debba diventare per forza di cose secondario, anzi è vero l’opposto. Nei due film di cui esamineremo in breve l’inizio, ma che vi raccomando di vedere nella loro interezza, l’esperienza del protagonista è segnata dall’incontro con una donna (con un altro da lui, anzi una sua opposizione). Fin dal titolo è chiaro che quest’altra persona è presentata dal protagonista come la vera protagonista della vicenda che lo ha visto coinvolto. Infatti il primo film si intitola Gilda e il secondo, nell’originale, Annie Hall (solo nella versione italiana è diventato Io e Annie). Il protagonista narratore ( Glenn Ford nel primo film, e Woody Allen nel secondo) mentre si presentano, in realtà cedono o “simulano” di cedere la scena alla donna che drammaticamente nel primo caso, simpaticamente nel secondo, hanno travolto la loro vita.
Insomma l’ego trip abbastanza inevitabile in questo genere di racconto viene opportunamente corretto da una sorta di cessione della scena “all’altra”, e l’autobiografia del protagonista è anche la storia di una contraddizione svelata, di un cambiamento nella propria vita, di un’irruzione “fatale” che ha spezzato il narcisismo del protagonista e compromesso/svelato la sua finta quanto esibita sicurezza di autosufficienza.
Tutte queste implicazioni vanno tenute ben presenti, quando si sceglie di usare questi modelli.
Usare la voce fuori campo come puro espediente di comodo per sintetizzare certi passaggi della vicenda è una soluzione poco efficace e piuttosto misera, che può risultare fastidiosa. Si può invece benissimo usare la voce fuori campo di un terzo personaggio che non è né il protagonista né la protagonista, ma un testimone della vicenda, una sorta di “coro” individuale . E’ la soluzione brillantemente usata da Clint Eastwood, nel suo recente Million Dollar Baby.
Usare l’autopresentazione al pubblico è anche più rischioso, anzitutto se il protagonista non è un uomo di spettacolo o un movie maker che per esprimersi d’abitudine usa la cinepresa (o la web cam) e il proprio corpo d’attore, invece della carta scritta e del semplice racconto orale. Nell’auto presentazione visiva inoltre è implicita una buona dose di spudorata “sincerità” e di esibizionismo, dunque il modello applicato a un personaggio che non abbia queste caratteristiche non risulterebbe coerente, né credibile.
In conclusione, questi modelli sono da usare con estrema consapevolezza e legano la narrazione molto di più di quelli presentati nelle due precedenti lezioni. E va anche osservato che mentre i modelli delle prime due lezioni si possono sposare (guardate per esempio l’inizio di Lawrence d’Arabia che ci presenta il protagonista in corsa folle sulla sua motocicletta per morire subito, e poi alla sua celebrazione solenne dopo i funerali, mette in scena il coro che “parla di lui”) i due diversi modelli presentati in questa lezione molto difficilmente possono venire mescolati ad altri.
1. GILDA (1946) Soggetto di E.A.Ellington; Adattamento di Jo Elsinger; sceneggiatura di Marion Personnett ( revisionata dalla produttrice/sceneggiatrice Virginia Van Upp); regia di Charles Vidor.
- Il protagonista maschile.
Johnny Farrell ci appare, scarmigliato, in un vicolo mentre gioca a dadi. La sua voce fuori campo recita: Per me un dollaro era un dollaro in ogni lingua. Era la mia prima sera in Argentina e non sapevo molto degli abitanti del posto, ma conoscevo i marinai americani e sapevo che era meglio starne alla larga.” Johnny vince una bella mazzetta di dollari e prudentemente si allontana. Verrà fatto subito oggetto di un’aggressione e la affronterà con calma imperturbabile, fin quando uno sconosciuto, un nuovo e misterioso personaggio destinato ad essergli amico e socio, giungerà a scacciare il ladro.
Il protagonista, un giocatore d’azzardo, ci viene subito presentato in azione. E’ un uomo che si gioca la vita a dadi. Esperto e abituato a fronteggiare i rischi. In un minuto di rappresentazione, il suo ritratto è già compiuto.
A rapidi stacchi vedremo Johnny passare dalle stalle alle stelle. L’uomo che lo ha salvato nel vicolo è proprietario di una lussuosa sala da gioco, nella quale Johnny fa rapidamente carriera fino a diventare braccio destro del capo. Il suo amico si fida a tal punto di lui, da lasciargli la gestione della sala, quando è in viaggio.
- La protagonista femminile.
Gilda appare dopo un quarto d’ora dall’inizio del film. La sua presentazione non è improvvisa come quella di Johnny, ma ritardata in modo esasperato. Il biscazziere amico di Johnny è tornato da uno dei suoi viaggi e Johnny lo va a trovare. C’è un’altra presenza in casa, si sente risuonare una musica dal primo piano e una voce femminile che canta. I due salgono le scale, attraversano una porta, sostano, in ascolto: Johnny è a disagio come se presagisse il peggio, l’altro è fiero ma anche stranamente mellifluo. Attraversano un’altra porta. Per primo, il padrone di casa: Gilda, sei presentabile? Finalmente lei entra in campo, in primo piano, sollevando la testa di scatto e gettando i lunghi capelli all’indietro. Sì. Nota la presenza di Johnny, si fa più controllata, si tira su una spallina, ma fa la dura e aggiunge una frasetta che suona allusiva: Lo sono più del necessario. Che significa? Ha già conosciuto Johnny? E’ stata una conoscenza intima?
Il film è un noir. Gilda ha tutte le caratteristiche della femme fatale. Non è importante sapere da dove viene, come e quando il biscazziere l’ha conosciuta, perché l’ha sposata. E’ importante vederla e coglierne il carattere: le piace il lusso, le piace cantare e curare il suo corpo, sa usare fino in fondo il suo fascino, non è una sentimentale o se lo è, lo nasconde sotto un atteggiamento sprezzante.
Commento
La prima cosa da segnalare è che la sceneggiatura di questo film è stata rielaborata fino all’ultimo, passando da diverse mani. Intere scene sono state aggiunte a lavorazione quasi ultimata e tra queste, due davvero fondamentali: i numeri musicali di Rita Hayworth ( Put the blame on me, Amado mio). Le due canzoni illuminano un contrasto interiore del personaggio, da un lato la sua fiera consapevolezza di essere “una peccatrice” (Put the blame on me), dall’altro la sua capacità di essere un’amante appassionata e devota, quando ciò è inevitabile ( Amado mio, love me forever) . Molti dialoghi vennero corretti a film già terminato. Questo per farvi capire che il lavoro dello sceneggiatore non è da considerarsi affatto concluso a copione terminato. Il lavoro dello/degli sceneggiatori è sempre suscettibile di miglioramento e accompagna il film fino all’ultimo momento utile prima dell’edizione definitiva. Questa continua revisione può certo seminare qualche incertezza e anche qualche lungaggine nel racconto ( intorno alla metà del film, il racconto di Gilda si fa piuttosto confuso e certo smarrisce la brillantezza dell’inizio), ma può anche irrobustire il film con dei momenti che risollevano l’attenzione del pubblico, narrativamente fondamentali ed espressivamente molto intensi.
Studiatevi bene le scene che intercorrono tra la presentazione di Johnny e quella di Gilda, in particolare l’incontro di Johnny con il biscazziere (Ballin Mundson) dove il dialogo pare la fiera dell’irrealtà e dell’improbabilità, scelta di grandissimo coraggio che da un lato asseconda la rapidità, dall’altra ci introduce a un mondo e a una vicenda in cui “tutto può accadere”, anche se come presto capiremo, la vicenda è predestinata, i suoi sviluppi “inevitabili”. E’ una storia che nasce e finisce sotto l’insegna del Fato. E questo dà anche ragione della scelta iniziale, cioè del farla raccontare dalla voce off del protagonista.
Seppure entrambe fulminanti, le apparizioni del protagonista (subito in campo) e della protagonista
(ingresso ritardato) sono opposte e ci mettono dunque di fronte a due personaggi contrapposti. Il protagonismo maschile è un protagonismo della presenza costante, quello femminile è protagonista anche nella sua assenza, perché sa farsi aspettare e desiderare , e poi non delude certo l’attesa, anzi la supera. E’ immagine pura, assoluta protagonista dell’inquadratura, oltre che del film.
Le prime parole dei due sono scolpite. Per me un dollaro era un dollaro in ogni lingua. Johnny si presenta attraverso la sua filosofia di vita. Sono più presentabile del necessario. Gilda non parla della sua filosofia, ma del suo corpo. La sua consapevolezza è consapevolezza fisica. La sua ironia è una lama a doppio taglio: parla di sé, ma è anche un messaggio rivolto a qualcuno.
2. ANNIE HALL (Io e Annie) (1977) Scritto da Woody Allen e Marshall Brickman. Regia di Woody Allen.
- Il protagonista maschile.
Alvy Singer ( il personaggio interpretato da Woody Allen) parla, su fondo neutro, direttamente al pubblico, di fronte alla MDP che rimane fissa su di lui.
C’è una vecchia storiella. Due vecchiette sono ricoverate nel solito pensionato per anziani e una di loro dice: Ragazza mia, il mangiare qui fa veramente pena. E l’altra: Sì, è uno schifo, ma poi che porzioni piccole! … Beh, essenzialmente è così che io guardo alla vita: piena di solitudine, di miserie, di sofferenze, di infelicità e disgraziatamente dura troppo poco. E c’è
un’altra battuta che è importante per me. E’ generalmente attribuita a Groucho Marx, ma credo dovuta all’origine al genio di Freud e che è in relazione con l’inconscio e che recita così, parafrasandola: Non vorrei mai appartenere a nessun club che contasse tra i suoi membri uno come me… Questa è la fottuta chiave della mia vita di adulto nei confronti delle donne. Sapete, ultimamente i pensieri più strani attraversano la mia mente perché sono sui quaranta e penso di attraversare una crisi o che so, chi lo sa… oh, io non mi preoccupo di invecchiare, non sono di quei tipi…lo so, quassù mi si apre una piazzetta, ma peggio di questo per ora non mi è successo, anzi credo che migliorerò invecchiando… il tipo virilmente calvo, cioè l’esatto contrario del tipo argentato distinto, ecco… e se no, nessuno dei due, divento uno di quelli che perdono i filini di bava dalla bocca, vagano per i mercatini con la borsa della spesa sbraitando contro il socialismo… Annie e io abbiamo rotto e io ancora non riesco a farmene una ragione.
Il protagonista, un commediografo di successo, ma in particolare un creatore di battute, si presenta senza bisogno di chiarire il suo mestiere, semplicemente dicendo una serie di battute.
Attraverso le battute ci chiarisce la sua filosofia di vita. Ci chiarisce anche il suo carattere autoironico, ma anche autoindulgente. La sua attitudine a divagare, la sua inclinazione alla logorrea. Ci mette parecchio ad arrivare al punto, ma quando lo fa è deciso, chiaro e inequivocabile. Io e Annie abbiamo rotto.
Il protagonista continua la sua auto-presentazione risalendo all’infanzia ( che vediamo in alcune divertenti scene esemplari), alla sua famiglia, al suo quartiere, al suo successo da adulto, al suo migliore amico, finché lo ritroviamo importunato all’ingresso di un cinema da qualcuno che lo riconosce vagamente per averlo visto in TV. Dall’inizio del film sono passati circa 9 minuti.
Il racconto è stato svolto a rapidi stacchi. Più di trent’anni sono passati in questi nove minuti.
- La protagonista femminile.
Alvy, fuori dal cinema, era in attesa di Annie. Sopraggiunge un taxi. Lei scende, con un abito molto anni 70, casual, curato, ma senza sfoggio di eleganza né di seduzione. Non guarda neppure in faccia Alvy.Le sue prime parole sono: Sono proprio di pessimo umore.
Il film è una commedia. L’attesa per l’apparizione della protagonista c’è, ma è un’attesa senza mitizzazioni, quotidiana. Lei scende da un taxi. La MDP non ce la mostra in PP, né da sola, ma a contrasto con l’ansia e l’atteggiamento normalmente risentito di lui, subito spezzato da una presa di distanza: niente discussioni, sono di pessimo umore. Come dire: un fatto mio, tu non c’entri niente. Lui non è un avventuriero, lei non è una dark lady. Sono due di noi.
Commento.
Nell’assoluta diversità dei due film, divisi da trent’anni, da generi opposti, da bianco e nero e colore, avrete notato le analogie narrative. Un minuto per la presentazione di Johnny, tre per l’enfatica auto-presentazione di Alvy. Un passaggio narrativo in “riassunto” per sintetizzare il vissuto del protagonista e portarci al vero punto focale della storia: l’apparizione di Lei. Di una Lei attesa. Di una Lei che si fa attendere.
Le scene “riassuntive” sono comunque, in entrambi i casi, ben lontane dalla frettolosità di una narrazione sbrigativa e puramente informativa. Sono anzi costruite, in ogni singolo stacco, come scene con un principio e una fine. Il passato è presentato per tappe e per momenti esemplari.
Il dialogo riveste una funzione essenziale. I protagonisti maschili si presentano attraverso la loro filosofia di vita. Le protagoniste femminili attraverso la loro condizione, il loro essere nell’istante.
I protagonisti maschili narrano la storia (e narcisisticamente si inscrivono nella Storia) , le protagoniste femminili sono la vita, prima e al di là della biografia. I primi “si proiettano”, le seconde “sono” (proiettate quanto si vuole, ma in fondo inattingibili). I primi rievocano, le seconde vengono evocate.
Si può legittimamente obiettare a questa differenza di “ruolo”, del tutto culturale, ma quasi sempre presentata come “naturale”, come “regola”. Non è sufficiente considerare che il primo film (Gilda) è stato scritto da due sceneggiatrici e prodotto da una donna. I ruoli definiti sono comunque quelli.
Si può raccontare una situazione capovolta? Dove cioè sia Lei a narrare, e Lui ad essere narrato? Naturalmente sì, ma senza smarrire la consapevolezza di quanta attenzione anche psicologica sia necessaria per distinguere i ruoli e presentarli (nel primo quarto d’ora del film) nel modo più coerente. L’impresa è tale da far tremare i polsi se si considera che nessuno ha finora osato fare un remake di Gilda “dal punto di vista di Gilda” , però Diane Keaton in Looking for Mr. Goodbar (In cerca di Mr.Goodbar) qualcosa del genere lo ha fatto, e con notevole efficacia.
Esercizio
L’esercizio che vi propongo questo mese ha lo scopo di verificare se qualcuno di voi si è preso la briga di studiare i film fin qui proposti. Dunque anche se potete continuare a mandare i vostri elaborati, questa volta consiglio di scegliere uno dei film fin qui esaminati e vederlo con attenzione, scena per scena. Rispondendo in particolare a questa domanda: a parte l’inizio del film, quale scena del film vi ha colpito di più? Descrivetela. E valutate: Cosa accade al protagonista in questa scena? Dove è collocata questa scena, a che punto del film? Perché secondo voi è esemplare e cruciale?
Il prossimo aggiornamento, ai primi di luglio. Nella prossima lezione, a partire da Taxi Driver di Martin Scorsese esamineremo il protagonista presentato in soggettiva dello stesso protagonista, cioè attraverso il suo modo di vedere la realtà. L’identificazione del pubblico con il protagonista,viene spinta avanti al punto di farci vedere il film con gli occhi stessi del protagonista.
Lezione 3 di Gianfranco Manfredi by www.gianfrancomanfredi.com
Nella precedente lezione abbiamo visto il protagonista presentato dal “coro”. Qui esamineremo il modello opposto. Il protagonista appare per primo ed è lui a condurci alla scoperta degli altri personaggi. Questo genere di approccio non esclude affatto la rappresentazione dell’ambiente sociale, ma attribuisce all’individuo e alla sua psicologia un ruolo da subito più autonomo e centrale. Non è attraverso l’ambiente sociale che comprendiamo e giudichiamo l’individuo, ma è attraverso un individuo esemplare che comprendiamo e giudichiamo la società.
Porre al centro del racconto una biografia, in cinema, non significa necessariamente raccontare l’intera vita di un personaggio (come in Citizen Kane). Può bastare la narrazione di un momento del tutto particolare della vita del protagonista, un momento unico che tuttavia ce ne illumina i tratti psicologici fondamentali. Non ci interessa, in questo caso, sapere quali siano state le esperienze infantili del personaggio, né come egli sviluppi e concluda la propria esistenza. La morte del protagonista può anche essere raccontata, se necessaria al disegno compiuto della sua personalità, ma le conclusioni possono essere molte e diverse: aperte verso nuovi e possibili sviluppi, chiuse come un cerchio che torna su se stesso riaffermando una sorta di permanente “stato dell’anima” di cui il personaggio è e resta prigioniero, oppure chiuse in quanto destinate a non ripetersi perché “superate”. Lo stesso vale per la nascita o l’infanzia . Si possono raccontare se sono fondamentali per comprendere la genesi del carattere del protagonista, le contraddizioni della sua attuale condizione sociale e psicologica, ma possono anche venire considerate per “date” e implicite, soprattutto se il ritratto psicologico del protagonista non è di tipo psicoanalitico classico, ma comportamentale. Sta all’autore, insomma, scegliere il percorso. Qui ci limiteremo ad esaminare come si presenta il protagonista da subito e “in azione” e come si possa, a partire da lui, incontrare il suo ambiente e gli altri personaggi. Presenterò due esempi tratti da Il Laureato (The Guaduate, 1967) di Mike Nichols, con Dustin Hoffman, e da Io la conoscevo bene (1965) di Antonio Pietrangeli , con Stefania Sandrelli.
2. A partire dal protagonista.
A) Il Laureato (The Guaduate, 1967) di Mike Nichols, con Dustin Hoffman. Sceneggiatura di Calder Willingham e Buck Henry , tratta dal romanzo di Charles Webb.
I dati di partenza su cui si trovano a lavorare gli sceneggiatori sono questi: Benjamin Braddock ha appena concluso i suoi studi in un college dell’Est e torna all’ovest ( a Los Angeles). Il suo periodo di formazione è concluso. Si trova a dover decidere cosa fare della sua vita. E’ confuso, smarrito.
1. Il film inizia da un primo piano di Ben in aereo. Le prime informazioni ce le da l’altoparlante di bordo. Signore e signori, stiamo iniziando il nostro atterraggio su Los Angeles (…) dopo quattro ore e mezzo di volo. L’informazione è voce di fondo. La macchina da presa (MDP) resta concentrata sul volto di Ben, sguardo nel vuoto, un’espressione insieme tesa e assente, che il giovane protagonista mantiene anche dopo l’atterraggio, quando lo vediamo (sui titoli di testa) camminare da fermo, trasportato dal tapis roulant dell’aeroporto, come un sonnambulo.
2. Ritroviamo , sempre in PP, il protagonista a casa, in camera sua, con lo stesso sguardo nel vuoto e un acquario alle spalle. Suo padre lo raggiunge, ma la MDP resta su Ben. Il padre lo vediamo entrare in campo, ma non gli sottrae neppure per un secondo l’attenzione del pubblico.
Padre: Ehi, ma che fai? Gli ospiti sono tutti giù, Ben. Sono impazienti di vederti.
Ben: Senti, puoi dire che ho bisogno di restare solo, per un po’.
Padre: Ma sono tutti i nostri amici più cari. Non ti hanno più visto da quando sei nato. Cosa c’è, Ben?
Ben: Sono un po’…
Padre: Preoccupato?
Ben: Beh…
Padre: Per che cosa?
Ben: Forse per il mio avvenire.
Padre: In che senso?
Ben: Non lo so. Io vorrei che fosse…
Padre: Che fosse come?
Ben: Diverso.
Entra la madre di cui udiamo la voce fuori campo e che sollecita il figlio a scendere e a mostrarsi agli amici di famiglia.
3. Ben è sceso in salotto. La MDP continua a non staccare mai da lui e dal suo volto. Gli altri personaggi che gli si affollano intorno sono apparizioni fugaci che lo salutano o ne commentano il passaggio con chiacchiere di circostanza. Apprendiamo da queste chiacchiere che Ben ha superato l’età dei primi amoretti (cioè che presto dovrà farsi una famiglia) che per la laurea gli è stata regalata un’Alfa Romeo (il che rimarca anche il benessere della sua famiglia), che ha vinto un premio accademico, e altre informazioni che hanno la stessa impersonale distanza delle comunicazioni dell’altoparlante all’aeroporto: è stato capitano della squadra di corsa campestre, capo del circolo dei dibattiti, condirettore e poi direttore del giornale del college. In sostanza, un ottimo studente, che riceve l’approvazione piena del suo ambiente sociale, riunito a festeggiarlo. Ma lui, per quanto cortesemente, sfugge. Un amico di famiglia lo prende da parte e gli dà un consiglio per il suo avvenire, che suona come un ammonimento: Voglio dirti una parola sola, solo una parola. Mi ascolti? Plastica! L’avvenire del mondo è nella plastica. Tra le tante presenze, ne notiamo bene soltanto una. Una signora elegante che siede in disparte, a bere e fumare , e tiene d’occhio Ben, consapevole del suo disagio (la signora Robinson). Ben si rifugia di nuovo in camera sua, ad osservare l’acquario. La porta si apre e la signora Robinson fa il suo ingresso, sicura di sé, invadente, ma come lui estranea e diversa rispetto all’ambiente convenzionale del salotto.
Da notare.
1. La prima immagine del protagonista è in aereo, sguardo nel vuoto. Ma quell’espressione non è occasionale, frutto del jet lag o dell’ansia dell’atterraggio. E’ lo stato d’animo che, senza bisogno di parole, già ci testimonia la condizione del protagonista. Si potrà osservare che questo genere di scelta ( seguire il protagonista fin dal principio in PP, concentrando su di lui e sul suo volto tutta l’attenzione del pubblico) attiene alla regia, non al lavoro dello sceneggiatore, ma in questo caso non è affatto così. Questa stessa espressione assente tornerà diverse volte nel corso del film e affiorerà di nuovo nel finale. E’ il marchio distintivo, non solo dello stato d’animo, ma del carattere del protagonista. E’ insomma una scelta narrativa.
2. Per maggiore chiarezza, quanto ci era stato espresso in modo puramente visivo, viene poi chiarito nel dialogo con il padre. Il protagonista, sollecitato, spiega di sentirsi confuso, e in sostanza “diverso”. Non è soltanto il contenuto del discorso a illuminarci sullo stato confusionale del protagonista, ma anche la forma smozzicata, incerta, delle sue risposte al padre. Però da tanta incertezza, nasce una risposta chiara, una dichiarazione esplicita. In una sola parola: diverso.
3. Le voci del “coro” , a contrasto, oltre a offrirci nuove informazioni sul protagonista, ne danno un giudizio positivo, carico di soddisfazione e di attese, ma l’imbarazzo di Ben conferma, nei fatti, il suo senso di estraneità rispetto all’ambiente. Da cosa è diverso? Dalla plastica (anche qui: una sola parola, a compendiare le attese conformiste che gli altri ripongono in lui). Il nostro protagonista non vuole fare il protagonista, rifiuta il suo ruolo. Eppure la MDP continua a seguire lui. Il protagonismo di Ben sta nella sua riluttanza ad assumere il ruolo assegnatogli socialmente. Nel suo atteggiamento, si riconferma diverso. La lunga sequenza si chiude circolarmente, riportandolo nella sua stanza di fronte all’acquario. E dall’irruzione della signora Robinson, nasce la prima e decisiva svolta del racconto.
Commento - Nel ritratto cinematografico del protagonista, i fatti, i comportamenti, le azioni o le non-azioni (ciò che si vede) precedono le spiegazioni verbali, e poi le seguono, per correggerle o rafforzarle. Il racconto cinematografico mostra prima di spiegare a parole. E’ racconto per immagini. Non dimenticate mai che il cinema nasce muto. Non è la parola , il linguaggio verbale a occupare (come alla radio, o come ancor più in letteratura) il centro della comunicazione, ma quello che si vede e che decidiamo di far vedere. Quando dunque volete presentare da subito, fin dalla prima inquadratura, il protagonista, ricordate di metterlo in una situazione/condizione che ci faccia da subito (senza bisogno di parole) capire non solo chi è fisicamente, ma come si sente, e qual è il segno distintivo del suo carattere. Questa situazione dev’essere chiara ed esemplare. Una metafora, se volete (l’aereo che sta atterrando, lo stordimento del “ritorno a casa”) ma mostrata concretamente. Figuratevi la scena mentalmente, proiettatevela. Non pensate che questo sia il lavoro del regista. Il regista potrà scegliere una diversa messa in scena, ma è bene che pur senza scendere in dettagli di movimenti di macchina e in minuzie stilistiche, lo sceneggiatore non perda comunque mai il focus del racconto: ciò che ne deve occupare, visivamente, il centro.
Per differenza. Quanti film iniziano con una panoramica della città in cui si svolge la vicenda? Con un aereo che atterra, prima di vedere in azione il protagonista? Questa sorta di inquadratura di codice, che ci informa sul luogo in cui si svolge la vicenda, o ci offre un puro prologo visivo su cui magari appoggiare i titoli di testa, non è di alcun rilievo in una storia psicologica che intende concentrarsi sul vissuto del protagonista e porre lui al centro della vicenda. Possiamo informare il pubblico circa il “dove” in altro modo, non mostrando il luogo, ma facendolo capire da voci di fondo.
E ancora: quanti sceneggiatori avrebbero resistito alla tentazione di mostrarci il Laureato al College, vedendolo nel contesto dei suoi amici per poi sottolineare la differenza tra lui e il contesto famigliare? O presentandolo magari impacciato nel ricevere la laurea in toga? Ma questo passaggio è superfluo se l’oggetto della nostra narrazione non è la differenza tra la vita studentesca e quella famigliare, ma il difficile inserimento sociale di un giovane alle prese con i propri dubbi e con i propri problemi di ingresso nel mondo degli adulti. Non cominciate mai un film con una premessa che esce dall’oggetto della narrazione. Centratelo subito, senza indugi. Si parte dalla situazione in corso, in atto. E la situazione, in questo caso, coincide con la presentazione del protagonista e del suo carattere. Non basta che il protagonista entri in scena. Come ci entra? Come ci appare? In che momento? In quale condizione psicologica? Questo è il punto. Noi dobbiamo coglierlo ed esprimerlo figurativamente. Ne stiamo dipingendo il ritratto. Non bisogna disperdersi in dettagli estranei a questo scopo.
B) Io la conoscevo bene (1965) di Antonio Pietrangeli , con Stefania Sandrelli. Soggetto e sceneggiatura di Antonio Pietrangeli, Ruggero Maccari, Ettore Scola.
Per quanto questo film non sia tratto da un romanzo, è esplicita l’intenzione degli autori di voler raccontare una Madame Bovary degli anni 60. Invece di una vita “da romanzo”, Adriana, la nostra, illetterata protagonista, sogna una vita “da cinema”. E’ una bellissima ragazza, candida e un po’ svanita, che non considera il suo corpo, costantemente oggetto di mire maschili, come un qualcosa da esibire con fierezza o su cui speculare, ma come una sorta di dotazione naturale, vissuta senza malizia alcuna, anzi con indolenza. Il suo sogno è quello di uscire da una vita dura e ingrata, meschina, di cui pure non si lamenta, per diventare una presenza sullo schermo.
1. Il film inizia con la panoramica di una spiaggia desolata. Ombrelloni chiusi, cartacce disseminate, brutte case sul fondo, sabbia grigia. La panoramica si conclude su Adriana stesa a prendere il sole, in solitudine. Dai piedi, la MDP sale al suo costume da bagno, alla sua schiena nuda, al suo volto, con gli occhi chiusi, di ragazza assopita e inerte. Non è chiaramente lì per esibirsi visto che è sola. E’ innocente nel suo mostrarsi. Il programma musicale di canzonette che risuona dalla sua radio a transistor è terminato. Una mosca sembra svegliare Adriana che la allontana con un soffio, senza un gesto, e resta ad occhi chiusi. Si ode il segnale orario. Ore 15.30. Adriana continua a restarsene semi assopita. Cominciano le notizie del giornale radio. Importanti avvenimenti politici. Subito Adriana si alza, raccoglie le sue cose e se ne va. Pochi passi di corsa sugli zoccoli e già si ritrova in una periferia di palazzoni, strade assolate e semideserte. Si ferma a un baracchino di bomboloni, il cui maturo gestore sonnecchia. Si fa allacciare da lui il reggiseno.
Adriana: Presto, capitano, che sennò faccio tardi.
Capitano: Chi c’ha fretta, vada piano.
Adriana: Grazie, capitano.
Altra corsetta zoccolando. Un uomo sta bagnando la strada con una pompa di gomma. Adriana lo chiama per nome, si fa annaffiare per togliersi la sabbia di dosso. Lo ringrazia. Corre ad alzare la saracinesca della bottega di un parrucchiere. Entra, corre nel retrobottega. Si toglie l’accappatoio e si distende di nuovo, su un lettino. Inerte come all’inizio.
2. Stacco. Adriana al lavoro. Fa le mèches a una cliente. Fa cadere per sbaglio una lozione. Ha un rapido flash. Si ricorda di un’aggressione sessuale subita passivamente sul pianerottolo di casa da parte di un uomo che nella foga, con un calcio, ha spedito una bottiglia a infrangersi sui gradini. Riprende il lavoro, distratta, svanita. A fine turno, mentre il proprietario della bottega entra in negozio per controllare l’incasso, Adriana è ancora sul lettuccio del retro a leggere, o più esattamente a sfogliare, un fumetto di quart’ordine (Demoniak). L’uomo, più che maturo, sprovvisto del minimo fascino, le si siede accanto e le accarezza le gambe parlando d’altro. Lei continua a leggere.
Proprietario: E lascia perdere sto libro!
Si china su di lei.
Adriana: Ma non potrebbe essere più gentile?
Però lascia fare, rassegnata, indolente.
3. Stacco. Adriana si vede in compagnia di Vittorio Gassman. Si vede sullo schermo accanto a lui. E’ una sua proiezione nella proiezione. La sera, infatti, Adriana fa la maschera in un cinema. Scambia qualche piccola chiacchiera con una sua collega. Accompagna un cliente al suo posto e nemmeno si accorge che lui si stanca di seguirla e va a sedersi per conto suo.
Da notare- Rispetto al Laureato, qui non ci sono parole che confermano o spiegano fatti o circostanze inerenti al personaggio. Il personaggio compare e dal suo atteggiamento, dai suoi piccoli comportamenti, comprendiamo chi è. Un ritratto indubbiamente difficilissimo da rendere perché ricco di sottili sfumature, e che in questo caso non può avvalersi della parola per spiegarsi, perché di “parole” Adriana non ne ha a disposizione. Non è un’intellettuale: ignora il giornale radio, vive di canzoni, di fumetti ordinari e di sogni cinematografici, porta in giro il proprio corpo rassegnata alla libidine maschile. E’ abituata a cancellare i ricordi spiacevoli che riaffiorano alla sua mente. Subisce. Chiede solo un po’ di gentilezza. La stessa semplice gentilezza che caratterizza la sua ingenua disinvoltura e familiarità nei rapporti umani.
Con molta maggiore radicalità del precedente esempio e con un compito estremamente più difficile ( raffigurare la psicologia di un personaggio apparentemente sereno eppure tragico, come viene compiutamente rivelato dal suo suicidio finale, superficiale ed estremamente sensibile, sospeso tra speranza e rassegnazione, protagonista e vittima, indipendente e succube dell’ambiente) Adriana viene raccontata mostrandola, non in azioni clamorose, ma per minimi dettagli di vita, senza che mai il racconto perda di presa diventando insignificante o noioso.
Anche qui, il momento iniziale ( l’inerzia dell’abbandono del suo corpo al sole su una spiaggia marginale e disastrata) è già un compiuto ritratto del personaggio, non mera premessa a un racconto che verrà dopo. E l’inizio è anche un insospettabile preannuncio, a violento contrasto, della fine. Giace inerte sulla sabbia e giacerà sull’asfalto dopo esserci gettata dalla finestra.
Ci siamo limitati alla presentazione del personaggio, ma il film è da studiare tutto per vedere con quale mirabile fluidità vengono, attraverso Adriana, presentati gli altri personaggi, tutti maschili, che le si affollano intorno. Il coro maschile non darà mai giudizi su di lei come “persona”, tutti potranno dire, un domani “Io la conoscevo bene”, ma nessuno ha fatto il minimo sforzo per conoscerla veramente, e chi forse avrebbe potuto farlo, è passato quasi inosservato agli occhi di Adriana, permanentemente sognanti un “altrove” che non esiste, se non in immagine, un altrove “fantasma”.
Commento- I grandi personaggi vivono dal loro primo apparire. Non solo quelli che rappresentano uno “stato dell’animo”, ma anche quelli che hanno una pura evidenza simbolica. Tarzan è un uomo bianco, nudo, che compare su un albero e ulula come un animale. E’ già tutto in questa prima immagine. Dracula appare in un castello in rovina, come un’ombra inquietante che emerge dai secoli. Non c’è alcun bisogno di raccontarne l’origine. Se si vuole, lo si può fare, e lo si è fatto. Ma al pubblico cinematografico, a noi, non importa nulla di Lord Greystoke, o delle battaglie del principe valacco Vlad Drakul. Ci basta vederli apparire perché essi esistano senza vita precedente e ci parlino senza parole. La loro prima inquadratura è già fondamentale, è già una rivelazione. Una presentazione qualsiasi, sciatta, non evidente di per sé, è una presentazione mal pensata e mal scritta, in genere rivelatrice solo del fatto che noi stessi che scriviamo non abbiamo ancora chiaro chi sia il nostro personaggio. Non lasciamoci ossessionare da tutti i dettagli biografici, dalla “carta d’identità” che abbiamo stilato di lui prima di cominciare a raccontarlo, non preoccupiamoci di fornire subito al pubblico una massa di informazioni sul suo conto. Concentriamoci sul suo ritratto e cerchiamo di renderlo espressivo sin dal primo momento.
Ma in pratica, come possiamo descrivere questa prima apparizione del personaggio? Così come uno sceneggiatore può pensare (a torto) che la “messa in scena” sia compito esclusivo del regista, può anche pensare che la caratterizzazione psicologica, i gesti e le azioni più normali e quotidiani, siano dominio e competenza degli attori e che sia superfluo sottolinearli. Non è così, perché è anche dalle azioni minime che riusciamo a comprendere e far comprendere un personaggio. Questo però non significa affatto inzeppare la sceneggiatura di indicazioni. Può chiarire questo punto un altro esempio (tratto dalla sceneggiatura del film White Heat del 1948/49 , film di Raoul Walsh con James Cagney). Gli sceneggiatori descrivono così il personaggio femminile di Verna, al suo primo apparire: Verna si muove dal letto alla porta, serrandosi la vestaglia alla vita. Il suo volto è bellissimo, algido come la neve. La filosofia di Verna è semplice: e io cosa ci guadagno?
Come potete vedere, non è necessario che lo sceneggiatore, nello script, si diffonda in lunga descrizione della psicologia del personaggio e in un pignolo elenco di gesti, anzi la sua presentazione dev’essere sintetica e ficcante esattamente come la presentazione visiva e centrare subito il punto. Il regista poi, nel film, sceglierà di rappresentare Verna ancora distesa a letto, per sottolineare meglio la sua natura da “bambola viziata”, ma quelle poche righe sulle caratteristiche dominanti del personaggio ne hanno già dettato il ritratto, fisico e psicologico.
Esercizio- I due esempi sopra proposti (Il Laureato e Io la conoscevo bene) sono quasi inarrivabili nella loro perfezione stilistica, ma se si devono cercare dei modelli di riferimento è sempre meglio considerare i più impeccabili, non certo per imitarli banalmente, ma per assimilarne la lezione (e confrontandoli ad esempi meno riusciti, sarà più semplice scovare le pecche di questi ultimi).
Se avete un personaggio in testa, provate a presentarlo come se doveste raccontarlo in una sola immagine. Cercatela questa immagine iniziale e riassumetela in pochissime righe (come nell’esempio proposto da White Heat). Questo esercizio potrebbe sembrare più semplice del precedente (c’è molto meno da scrivere), ma in realtà è parecchio più difficile. Potrà esservi utile scrivere dapprincipio una descrizione lunga (vi aiuterà a chiarirvi le idee), ma successivamente riducetela della metà e poi ancora della metà, fino a centrare l’essenziale, nel modo più espressivo ed efficace.
( Nella prossima lezione prenderemo le mosse da Gilda del 1946 di Charles Vidor e Io e Annie del 1977 di Woody Allen. Nel primo esamineremo il problema della “voce fuori campo” , aggiunta alla presentazione visiva del protagonista; nel secondo quello della “voce-volto” in campo, cioè del protagonista che si presenta al pubblico direttamente, “confessandosi” alla macchina da presa. Due ulteriori gradini dell’approfondimento della Presentazione del Protagonista).
Lezione 2 di Gianfranco Manfredi by www.gianfrancomanfredi.com
(per la prima lezione, cliccare qui)
Quando lo sceneggiatore presenta il personaggio protagonista, si trova a dover soddisfare due distinte esigenze: una è informativa. Si tratta cioè di fornire al pubblico le informazioni di base utili a identificare il personaggio nei suoi connotati essenziali, cioè la sua “carta d’identità”. L’altra è espressiva. La semplice lettura di una carta d’identità non basta infatti a definire le caratteristiche psicologiche di un personaggio, né il suo momento emotivo, né il suo temperamento.
Troverete in tutti i manuali di sceneggiatura indicazioni sulla creazione preliminare di uno schema di definizione del personaggio, proprio sulla base del modello “carta d’identità”: età, luogo di nascita, professione, sesso, aspetto e segni particolari. I manuali precisano immancabilmente che è bene per un autore definire in anticipo anche altri dettagli, per esempio sulla famiglia del personaggio, se ha genitori ancora in vita, fratelli, figli, coniugi e altri parenti, se ha tic o gusti particolari, quale sia il suo grado di istruzione, il suo curriculum vitae, le sue principali qualità/punti di forza e i suoi difetti/debolezze. Insomma tutti i dettagli utili a comprenderlo anche se poi molti di questi dettagli non verranno affatto utilizzati nella storia. I manuali di sceneggiatura però in genere trascurano di precisare e avvertire che tutti questi utili approfondimenti del personaggio, poi condizioneranno pesantemente il lavoro dello scrittore. Umberto Eco, in una recente intervista rilasciata a Enrico Ghezzi, ha giustamente sottolineato: “quando io decido che il mio personaggio ha sessant’anni ed è nato a Padova, già mi sono in qualche modo legato. Ci saranno cose che potrà fare e altre che non potrà fare.” Insomma: ogni caratteristica fissata a priori, da un lato ci apre un possibile scenario creativo, dall’altra ci limita ed esclude altri possibili sviluppi e scenari. Nella fase di ideazione di un personaggio questo deve essere tenuto ben presente. In pratica, la narrazione potrà essere più libera se si parte da poche definite caratteristiche, da arricchire magari nel corso della narrazione, mentre sarà tanto più vincolata quanto più vasta sarà la gamma di caratteristiche prefissate. Inoltre l’informazione da dare al pubblico sul personaggio, al principio di una storia, sarà più facilmente sintetizzabile quanto meno sarà diffusa. In particolare nella scrittura cinematografica, la natura di un personaggio va mostrata in azione, cioè nei fatti e nei comportamenti, non è sufficiente, anzi è spesso stucchevole comunicarla a parole. L’informazione non deve dunque mai essere staccata dalle esigenze espressive. Non tutti i dettagli della biografia di un personaggio hanno eguale valore dal punto di vista espressivo. Bisogna scegliere quali sono i caratteri dominanti, quelli che intendiamo sottolineare nel corso del racconto, e presentarli subito in modo efficace, perché possano venire riconosciuti a colpo d’occhio, senza bisogno di spiegazioni eccessive. Esamineremo mese per mese , per aggiornamenti successivi, alcune differenti tecniche di presentazione del personaggio protagonista, tra le tante possibili. Per questo mese cominciamo con una tecnica classica e cioè …
1. L’ingresso ritardato, ovvero: “ dicono di lui”.
Questo genere di presentazione del protagonista può essere anche definito “teatrale”, in quanto l’origine è tipica del teatro e in particolare del teatro da “capocomico”. Se guardate le commedie di De Filippo o di Govi, in genere la scena iniziale presenta dei personaggi di contorno grazie ai quali cominciamo a conoscere l’ambiente (la scena) e il protagonista, che è ancora assente, ma al centro dei loro discorsi. Tutti parlano di lui. Quando poi il protagonista finalmente entra in scena, salutato da un applauso, è già al centro dell’attenzione e prima ancora che si muova e parli, il pubblico ha potuto avere delle informazioni sul suo conto e coltivare delle attese. In questo genere di presentazione “sociale”, inoltre, si offre al pubblico una pluralità di punti di vista sul personaggio. In questo modo, i pareri su di lui possono risultare contrastanti e contraddittori. Il personaggio non viene presentato solo per quel che è, ma anche per come è interpretato/vissuto dagli altri. Alla chiarezza delle informazioni si sovrappone una zona di incertezza e di mistero: il personaggio potrebbe non essere affatto come viene dipinto dagli altri, o avere risvolti occulti. Paradossalmente, la nostra curiosità cresce quanto più diverse sono le opinioni espresse sul personaggio. Da un lato cominciamo a conoscere chi è, dall’altro ci domandiamo “ma chi sarà mai veramente?”
Uno smagliante esempio cinematografico di questa tecnica di presentazione è nel trailer di “Citizen Kane” (Quarto Potere) di Orson Welles. Potete trovare questo trailer nei contenuti speciali di uno qualsiasi dei DVD della serie RKO, disponibili in italiano. Il trailer inizia con un microfono che entra in campo a captare la voce di Orson Welles, il quale, dopo una rapida e vivace presentazione del cast, lascia la scena ai personaggi di contorno, senza mai mostrare se stesso. E i comprimari esprimono tutti opinioni violentemente contrastanti sul protagonista Charles Foster Kane, alimentando in questo modo la curiosità del pubblico.
Come introduzione a questa carrellata di pareri sul protagonista, Welles ha subito precisato: “Non so che dirvi di lui, c’è così tanto da dire…”
Ed ecco le opinioni:
“Charles Foster Kane ha dato inizio alla guerra, ma se non fosse stato per lui, gli USA avrebbero il Canale di Panama?”
“ E’ un comunista!”
“ Governatore? Quando gli elettori e sua moglie sapranno cos’ho scoperto su di lui e una certa biondina, non lo eleggeranno neanche spazzino!”
“ Lo sposerò la settimana prossima. Alla Casa Bianca.”
“ Certo che lo amavo. Gli ho dato 60 milioni di dollari!”
“ Per forza lo amo. E’ l’uomo più ricco d’America.”
“ E’ un pazzo.”
“ E’ meraviglioso.”
Conclude Welles, sempre fuori campo: “Signore e signori, non so cosa penserete del sig. Kane. Non ne ho idea: io ho solo recitato il suo ruolo. Beh, Kane è un eroe. E una canaglia. Una nullità e un uomo d’oro, un formidabile amatore, un grande americano e un gran bastardo. Dipende da chi ve ne parla. Qual è la verità su Charles Foster Kane? Venite al cinema e lo scoprirete da soli.”
Da notare.
1. I pareri espressi su Kane, violentemente contrapposti, sono tutti decisi. Nessuno esprime dubbi o valutazioni ambigue. Il dubbio deve restare tutto del pubblico. L’autore non sta semplicemente usando una tecnica pubblicitaria, né sta soltanto distribuendo i ruoli tra i personaggi del film, tutti definiti a seconda dell’opinione espressa su Kane, ma sta anche affidando un ruolo al pubblico: quello di formarsi un suo proprio giudizio.
2. Le opinioni su Kane vengono espresse in forme sintetiche, colorite ed efficaci (non lo eleggeranno neanche spazzino, gli ho dato 60 milioni di dollari). I personaggi secondari, ciascuno con la propria personalità e il suo linguaggio, parlando di Kane presentano anche se stessi e incuriosiscono a loro volta.
3. Pur nei contrastanti pareri, vengono date alcune informazioni certe: Kane si muove su uno scenario politico (vengono nominate la guerra, il comunismo, gli elettori, la Casa Bianca), la sua vita privata è sfoggiata in pubblico (amori, scandali, ricchezza) ma nasconde dei misteri (come si comporta sotto sotto con sua moglie e le altre donne? Quali sono le sue arti seduttive? Come ha fatto i soldi? ).
4. La storia, nel suo sviluppo, si regge sul mistero della personalità di Kane. E’ questo il suo vero motore narrativo.
Rispetto a quanto detto in precedenza e a quanto insegnato dai manuali di sceneggiatura, qui si usa come punto di forza espressivo non quanto conosciamo del personaggio, ma proprio tutto quello che non conosciamo affatto. La tecnica capovolge la regola. Il compito dell’autore in apparenza era quello di spiegare il protagonista, ma è stato svolto molto meglio e più coerentemente alla storia, non spiegandolo affatto, anzi affidando al giudizio del pubblico la valutazione finale. ( Del resto,
quando la comunicazione non si preoccupa di stimolare il nostro spirito critico e il nostro libero giudizio, ci declassa a popolo bue).
Commento. Il film Citizen Kane ( 1940) è stato tradotto in italiano con il titolo Quarto Potere. Infatti il film parla del potere della stampa. Ma di questo tema, nel trailer, non c’è traccia. Non si fa parola del tema centrale del film! Questo potrebbe indurre molti a pensare che il trailer è sbagliato. Non sarebbe stato più corretto informare il pubblico che il misterioso Kane è un magnate della Stampa? Come mai tra le informazioni contenute nel trailer proprio questa, così decisiva, non c’è? Anzitutto, di film sul potere della stampa ce ne erano già stati parecchi e scegliendo di centrare il trailer su questo aspetto, Citizen Kane non sarebbe apparso come un film originale, ma come un altro film sulla stampa. In secondo luogo, “la stampa” non è una persona. E’ un tema. Centrare il trailer su un tema avrebbe voluto dire offrire al pubblico una percezione astratta, ideologica, del film. Con la sua scelta, Welles esprime con grande efficacia che il centro di una rappresentazione non può essere un Tema, ma deve essere un Uomo. Il che illustra perfettamente quando dicevo al principio: una storia senza personaggi, una storia puramente “tematica”, non ha forza. D’altra parte Welles è assolutamente onesto e veritiero nel sottolineare che si tratta della storia di un personaggio. Il film inizia con Kane bambino. E’ una biografia, che molti interrogativi rendono inquietante. E infine (ma qui si esce dal campo delle “regole e delle tecniche di composizione” e si entra nel campo della genialità pura) scegliendo di tacere al pubblico un’informazione essenziale, Welles si comporta esattamente come la Stampa, che proprio mentre asserisce di informare sui fatti essenziali, e al contempo “democraticamente” propone al pubblico opinioni contrastanti in proposito, occulta contenuti fondamentali, cioè cose che per opportunità o convenienza “è meglio non si sappiano”. La comunicazione mediatica è esattamente questo. Il trailer di Welles, tacendo il contenuto fondamentale del film (il Potere della Stampa e della Comunicazione) lo rivela nondimeno sotto metafora, e ne usa spudoratamente i meccanismi, con corrosiva ironia.
Sviluppo del modello. Ho scelto di illustrare questo modello come primo tra i tanti, perché si tratta del modello più antico. Dicendo che è di origine teatrale ho implicitamente chiarito che lo si ritrova già nella tragedia classica ( questa è la funzione del “coro”: introdurre e commentare il carattere del protagonista e le vicende in cui è implicato), in Shakespeare, insomma in secoli di teatro fino a giorni nostri. Va precisato che un inizio affidato al “coro” non è una semplice introduzione, ma è già di per sé narrazione: infatti ci presenta a confronto, da subito, il personaggio e il proprio ambiente, il singolo e la collettività che ne valuta il carattere e le azioni. Se la nostra narrazione non considera centrale il rapporto individuo-gruppo, questo tipo di inizio non è il più adatto. Tuttavia questo modello ha dato vita nel corso del tempo a molte varianti. Il fatto che si tratti di un modello antico non significa affatto che sia un modello sorpassato. L’esempio fornito dal trailer di Welles, ci mostra in modo molto preciso che dall’iniziale contesto teatrale già il modello si sposta verso un modello di comunicazione che ha a che vedere con l’inchiesta giornalistica. In molti film successivi questo legame è stato esplicitato al punto che il modello non è stato usato soltanto come inizio utile alla presentazione del protagonista e alla sua entrata in scena, ma come struttura dell’intero racconto. Nei film Zelig, Lenny, Harry ti presento Sally, Man on the Moon, il modello, sotto forma di interviste “giornalistiche”, scandisce tutti i passaggi della narrazione, dal principio alla fine. Le regole base di questo modello si ritrovano anche in film che non contengono riferimenti esplicitamente teatrali, né giornalistici. Prendiamo ad esempio il recente La maledizione della Prima Luna di Gore Verbinski. Il titolo originale del film è Pirates of the Caribbean (Pirati dei Caraibi) e gli sceneggiatori Ted Elliot e Terry Rossio si preoccupano subito di destare la curiosità del pubblico su questo protagonista collettivo: i pirati. Nella scena d’apertura, vediamo un grande vascello che fende la nebbia. A prua, una bambina scruta il mare. Il film, prodotto dalla Disney, si rivolge anche a un pubblico infantile e in questa bimba che cerca di orientarsi nella nebbia, curiosa di veder apparire qualcosa , gli spettatori più giovani possono immediatamente identificarsi. A bordo, il “coro” ( il capitano del vascello, il nostromo, il padre della bambina) discute di pirati: c’è chi li vorrebbe impiccare, c’è chi li teme per le loro gesta feroci, c’è chi cerca di smussare i toni (il padre della bimba) per non impressionare troppo la piccola. Lei, candidamente, esprime un’opinione contrastante: vorrebbe incontrarli, questi famosi pirati che hanno acceso la sua immaginazione. Ora la corrente trascina un ombrellino bianco, simbolo di candore, e poi dalla nebbia appare un giovane naufrago, anche lui un ragazzino, esanime sul rottame di una nave. Quando la nebbia si apre, ci appare un altro vascello in fiamme e la superficie del mare disseminata di rottami. Non si tratta più di semplici discorsi sui pirati, ma della dimostrazione visiva, concreta, di quello che i pirati, ancora invisibili, possono fare. Anche qui c’è chi cerca di smussare: potrebbe essersi trattato di un semplice incidente, ma è ormai chiaro che questa spiegazione è solo un patetico tentativo di tranquillizzare. Il naufrago viene portato a bordo e affidato alla vigilanza della bambina, che ha all’incirca la stessa età. La bimba scopre al collo del ragazzo un medaglione con effigiato il teschio simbolo della pirateria. Dunque quel ragazzo non è una vittima, ma un pirata! Sarebbero quelli i terribili corridori del mare? Dei ragazzini? La bimba decide di proteggerlo e nasconde il medaglione.
Insomma: vediamo qui in azione il nostro modello di riferimento, in tutti i dettagli: 1. Si esprimono opinioni contrastanti sui pirati, 2. Le opinioni sono espresse in un linguaggio vivace e inequivocabile e ci permettono di capire il diverso atteggiamento e le diverse caratteristiche dei singoli personaggi del coro; 3. Ne ricaviamo alcune informazioni certe: il mare è battuto dai pirati, c’è una grave emergenza in corso, l’atmosfera è gravida di attesa e pericolo, ma tutto è immerso nel mistero, inclusa l’identità del giovanissimo naufrago che potrebbe essere vittima o aggressore; 4. Il motore della storia è il mistero circa l’identità dei pirati: sono creature demoniache, affascinanti avventurieri o cos’altro? E cosa rappresenta davvero il misterioso medaglione, al contempo raffinato esteticamente e intimidatorio con quel teschio che vi campeggia al centro?
In conclusione: un modello antico non è necessariamente un modello superato. Diffidate di chi sostiene che le forme di rappresentazione ereditate dal passato sono “vecchie” e come tali da abbandonare. Si tratta invece di archetipi, di fondamenti della rappresentazione, di cui uno sceneggiatore deve avere consapevolezza, imparando a svilupparli e ad adattarli di volta in volta alle proprie esigenze di racconto.
Esercizio. Cercate altri esempi cinematografici di questa tecnica di presentazione del personaggio ed esploratene le varianti. Provate poi su queste basi a scrivere un inizio di storia, sempre con presentazione del protagonista da parte degli altri personaggi e ingresso ritardato del protagonista stesso, ma in diverse versioni, indicando tra le possibili varianti quale risulti per voi la più efficace. Considerate anche casi in cui il modello è applicato male ed evidenziatene gli errori. Nella ricerca dei materiali, non è infatti indispensabile fare riferimento a dei capolavori o a dei film ben realizzati. Jerry Lewis nella sua scuola di cinema, usa di preferenza film decisamente brutti. Per imparare a individuare gli errori è molto utile guardare dei film mal riusciti. Gli errori degli altri ci abituano a riconoscere più facilmente i nostri. Cercate però di non citare film troppo sconosciuti o introvabili per non mettere in difficoltà chi leggerà i vostri esempi.
Lezione 1 di Gianfranco Manfredi by www.gianfrancomanfredi.com
IL FANTASY
Molti ritengono che il Fantasy sia una Fiaba per adulti, si tratta invece di una versione moderna del genere Epico/Mitologico. I due filoni principali del Fantasy sono l’Heroic Fantasy e la Quest. Nel primo caso, il protagonista è un eroe assoluto. Che si tratti di Maciste (figura inventata, ma che rielabora la mitologia classica) o di Conan (il cui autore Robert Ervin Howard inventa ex novo una propria mitologia), non ha importanza. Il celebre critico e scrittore americano Lyon Sprague de Camp dà questa definizione dell’ Heroic Fantasy: “Con questo termine si indica quel genere di storie ambientate non nel mondo come è, era o sarà, ma come dovrebbe essere per ambientarvi un buon racconto. Le storie che si riuniscono sotto questo nome comune sono fantasie avventurose che si svolgono in mondi immaginari preistorici o medievali (…). In mondi del genere, città scintillanti alzavano le loro torri ingioiellate verso le stelle, stregoni mormoravano sinistri malefici in spelonche sotterranee, spiritelli dispettosi saltellavano tra rovine dimenticate, mostri primordiali si aprivano sentieri attraverso giungle inesplorate e il destino dei reami era in bilico sulle lame rosse di sangue delle spade impugnate da eroi dalla forza e dal coraggio soprannaturali.”
Si potrebbe dunque pensare, stando a questa definizione, che non si possa definire Heroic Fantasy il racconto mitologico classico (quello delle fatiche di Ercole, per intenderci) e neppure quello cavalleresco (come il ciclo di Re Artù), dato che essi prendono spunto da un mondo che è realmente esistito. Però a ben vedere, soprattutto se si considera la storia del cinema, sia i film sull’antichità classica degli eroi semidei, che quelli sull’Europa cavalleresca rappresentano in larga parte mondi re-inventati, in direzione dell’avventura fantastica. (Per inciso va osservato che il personaggio di Conan appare subito dopo la morte del grande scrittore fantastico e avventuroso sir Arthur Conan Doyle). Era realistico il mondo pagano di Cabiria di d’Annunzio e Pastrone? Erano realistici gli antichi regni di D.W. Griffith e Cecil B. De Mille? No, erano totali reinvenzioni, anche sotto il profilo scenografico, dove la precisione storica veniva sacrificata a vantaggio di un accumulo di elementi figurativi provenienti da tradizioni diverse e liberamente mescolati e ricreati. La vera differenza tra l’Heroic Fantasy e il Genere Epico classico o cavalleresco, è dunque un’altra. L’Heroic Fantasy è rigidamente manicheo: da un lato i buoni, condotti al riscatto da un Eroe semi-dio, dall’altro i cattivi, terribili tiranni che fondano il loro potere sul connubio con le Forze del Male e con Divinità oscure e feroci. L’epica classica invece (pensate all’Iliade di Omero) non distingue affatto tra buoni e cattivi, non rappresenta gli Achei come incarnazioni del Bene e i Troiani del Male, considera luci ed ombre di entrambi e anzi casomai propende per i vinti (i Troiani). Anche il racconto cavalleresco ci mostra spesso Eroi smarriti, che perdono il senno e si consegnano all’arbitrio, e Nemici capaci di gesta generose, ben forniti di senso dell’onore. Del resto il genere “cavalleresco” si fonda per definizione sul rispetto dell’avversario. Nel ciclo di Re Artù, Maghe, stregoni e falsi profeti, sono distribuiti equamente in entrambi i campi. (Avrete forse seguito recentemente sui giornali una piccola polemica a proposito del film 300, tratto dall’omonimo fumetto di Frank Miller. Roberto Saviane, che pure è un autore colto e intelligente, ha sostenuto contro chi accusava quel film di “fascismo”, che si trattava invece di racconto epico e che il racconto epico è di per sé manicheo. Sbagliato. Non è l’epica, ma l’Heroic Fantasy, ad essere manicheo. 300 è decisamente un film di Heroic Fantasy, anche se prende spunto dall’evento storico delle Termopili. D’altro canto, la celebrazione del Buono che combatte soltanto Guerre Giuste contro Cattivi rivoltanti e depravati, non è certo scaricabile tutta sul fascismo, come attesta la storia stessa del cinema mitologico, egualmente diffuso in Europa e in America fin dai tempi del cinema muto, poi per tutta la guerra fredda e persino ben addentro i “progressivi” anni 60).
In cosa la Quest si differenzia dall’Heroic Fantasy? Si intende per Quest, la ricerca di un oggetto sacro, miracoloso, magico (il Santo Graal, l’Anello dei Nibelunghi, il Vello d’Oro). Il lungo cammino, disseminato da ostacoli, alla ricerca di questo oggetto, è anche un percorso spirituale, nel corso del quale il cercatore non si limita a sfruttare le sue abilità, ma le affina, non è virtuoso fin dal principio, ma migliora, diventando così degno, a poco a poco, e non senza contraddizioni, cadute e sconfitte temporanee, del proprio scopo. L’oggetto simbolico, di per sé, ha valore solo in quanto la Quest stessa acquista valore. Nella Quest, l’Eroe non è necessariamente un semi-dio, anzi più spesso è un individuo comune. Nel corso del suo cammino incontra altri volenterosi come lui e la sua ricerca viene condivisa, diventa collettiva. Se il Male è sempre rappresentato (come nell’Heroic Fantasy) come Forza Oscura e Tirannica, a fargli da contrasto non è un Eroe Giusto e Buono per natura e dotato di grandi poteri, ma una comunità di esseri diversi, in genere piuttosto egualitaria: la Comunità degli Ultimi e degli Esclusi. Nella Quest spira un’aria decisamente più popolaresca e “democratica” che nell’Heroic Fantasy.
Veniamo ora all’aspetto comune di questi due tipi di Fantasy che risiede, come ha ben definito De Camp, nell’invenzione di un mondo. Per lo sceneggiatore si tratta di cambiare totalmente l’approccio narrativo. Il contesto non è dato, va inventato (di sana pianta, o recuperato da epoche e mitologie rielaborate). Avrete notato che nella maggior parte dei romanzi Fantasy, alla stessa apertura del libro, la prima cosa che si vede è una mappa che indica i luoghi in cui si svolgerà la vicenda. E’ dall’invenzione del mondo che si parte, non dall’invenzione della storia e dei personaggi. Questo mondo fantastico deve essere tale da poter offrire tutte le possibili occasioni all’avventura e dunque è costruito su una geografia impossibile che accumula ogni genere di paesaggi dentro uno spazio limitato: foreste, paludi, deserti assolati, ghiacciai, lande nebbiose e cunicoli sotterranei. La geografia umana è altrettanto ricca: nani e giganti, razze di tutti i generi, donne mostruose e bellissime, pirati e cavalieri, selvaggi e sapienti, e chi più ne ha, più ne metta. Megalopoli labirintiche si alternano a villaggi di capanne, città portuali a rocche fortificate. La cosa più difficile è, partendo da questa assoluta improbabilità e incongruenza di base, mantenerla plausibile, e ciò si può fare se alla grande varietà “spaziale” e ambientale si fa corrispondere un tracciato temporale ben definito. In altre parole, l’epoca, per quanto non “storica” dev’essere comunque chiara. Facciamo un esempio: la scelta delle armi. In Guerre Stellari abbiamo un esempio prezioso di Fantasy Fantascientifico. Che si tratti di Futuro è reso evidente dalle astronavi, che questo Futuro sia un aggregato di lontane e mitiche Epoche Passate, è reso manifesto dalle armature, dai mantelli, dalle spade. Ma c’è un equilibrio: le spade dei cavalieri Jedi sono spade-laser, cioè l’estetica richiama l’Antico, ma l’uso esprime il Futuro. Se i cavalieri Jedi usassero delle spade normali, lo troveremmo ingiustificabile e ridicolo per dei personaggi abituati a muoversi su astronavi avveniristiche fornite di armi ad altissima tecnologia.
In Conan la scelta è quella di una non meglio precisata età barbarica. La scelta delle armi, degli elmi, dei costumi, va di conseguenza. Possono esserci elementi più antichi (fionde, mazze di pietra, bastoni) ma infilarne di più moderni sarebbe insensato quanto fare irrompere un veicolo a motore in mezzo ad un’umanità che si muove a piedi o a cavallo. Se uno stregone guarda in uno specchio magico, le immagini che vede non devono sembrare dei cinegiornali ( lo dico perché in molti casi questo è avvenuto) altrimenti ne ricaveremmo un effetto parodistico. In un film di Shrek possiamo persino divertirci a far trasmettere uno spot pubblicitario dallo specchio magico, ma in un Fantasy Avventuroso il nostro specchio magico dobbiamo inventarlo in modo che non ci faccia assolutamente venire in mente un televisore.
Ho ritenuto opportuno evidenziare questo aspetto perché in diversi soggetti fantasy che mi avete inviato, non è tenuto nella dovuta considerazione. Più il nostro mondo è di fantasia, più dobbiamo cercare di costruirlo con delle caratteristiche rigorose. E in questa scelta l’elemento decisivo su cui potete orientarvi è il tempo, la scelta dell’epoca.
Dal punto di vista della costruzione della storia invece, il tracciato è tradizionale, quasi obbligato.
Di solito l’ Heroic Fantasy presenta al principio della storia una strage imputabile ai Cattivi. L’Eroe ( Maciste o Conan) spesso viene colpito personalmente: è il suo villaggio, la sua gente che sono stati uccisi. Lui è tornato a casa troppo tardi per poterli salvare. Ciò che lo spinge a muoversi è non solo il senso della Giustizia in generale, ma la giustizia intesa come Vendetta . La violenza dell’Eroe è giustificata da quella che ha dovuto subire. In altre parole: l’azione del Cattivo, deve precedere quella del Buono.
Nella Quest la storia si apre in genere con un prologo nel quale si rappresenta la lotta in atto nel nostro mondo fantastico e si precisa quale ne è il palio: l’oggetto magico che in mano ai buoni può rappresentare l’occasione di riscatto e in mano ai cattivi la definitiva fine di ogni speranza. Da ciò, per stacco, si stringe su una situazione apparentemente del tutto marginale rispetto a questo scenario apocalittico. Un personaggio o dei personaggi che in teoria non dovrebbero essere affatto decisivi ai fini della Guerra, proprio perché giudicati da tutti insignificanti, cresciuti come sono in disparte, scoprono e spesso malvolentieri di avere una missione: sono proprio loro gli insospettabili eletti che potranno salvare il mondo. Dopodiché il racconto si snoda attraverso una serie di episodi che ci consentono di incontrare personaggi e situazioni diverse, di aggregare il gruppo attraverso reclutamenti che paiono casuali, ma che si rivelano sempre oculati perché le doti e i limiti di ciascun essere che si aggiunge alla comitiva è complementare a quelli degli altri. I singoli sono imperfetti, solo l’insieme è completo, e questo insieme si crea un pò per volta lungo il viaggio.
Si può qui rintracciare, nel confronto tra Heroic Fantasy e Quest, una differenza di cui abbiamo già parlato. Abbiamo detto che l’Epica è frutto di una contaminazione tra gli opposti generi della Tragedia e della Commedia. L’Heroic Fantasy (con i suoi protagonisti semi-dei, le loro grandi azioni, una certa enfasi nella rappresentazione e nel linguaggio, e un senso dominante del Destino, per cui la natura stessa dei personaggi dipende dagli eventi che abbiamo stabilito di raccontare)
ha un’indubbia origine nella Tragedia. La Quest invece (con una notevole prevalenza di personaggi comuni e persino buffi, tali da destare più simpatia che estatica ammirazione, sempre attivi e reattivi al punto che le circostanze che si trovano ad affrontare paiono – e sono- predisposte proprio per mostrare la loro capacità di sopravvivere, fino alla vittoria collettiva finale) affonda le sue radici nella Commedia.
Riguardo infine all’invenzione del mondo, tenete sempre presente che non state scrivendo un Romanzo: in cinema (e in fumetto) avete a che fare con un racconto per immagini. In questo genere di film (e di fumetti), l’invenzione degli ambienti, degli scenari, dei costumi, dei personaggi e delle creature, in genere precede, e comunque deve accompagnare sempre, la scrittura della sceneggiatura vera e propria. Lo sceneggiatore non è chiamato semplicemente a vedere il personaggio nella propria immaginazione, deve poterlo vedere disegnato, progettato nei dettagli. Solo così può “metterlo in scena”.
Dunque anche se parecchi di voi sognano di poter scrivere un film Fantasy, impresa già di per sé proibitiva in Italia, rendetevi conto che non si può scrivere una buona sceneggiatura di questo genere, se non all’interno di un progetto molto concreto, di cui la scrittura è solo un elemento.
Come dovrete disegnare la Mappa del vostro mondo fantastico, così dovrete anche partecipare alla visualizzazione degli ambienti, dei costumi, dei personaggi e persino degli oggetti di scena. In un Fantasy questi non sono elementi decorativi, ma direttamente narrativi.
Come esercizio finale vi consiglio di studiare da questo punto di vista uno dei film della saga de Il Signore degli Anelli: distaccatevi dalla trama in modo da considerare meglio come tutto l’apparato visuale del film sia, al di là del plot, il vero e sostanziale centro motore del racconto.
24° Lezione di Gianfranco Manfredi by www.gianfrancomanfredi.com - I Generi moderni (VI)
L’ADATTAMENTO (II)
b) Il postino suona sempre due volte
Il romanzo di James Cain esce negli USA nel 1934 e ha un primo adattamento cinematografico in Francia nel 1939 (Le dernier tournant, di Pierre Chenal) . Viene successivamente riadattato nel 1942 in Italia (Ossessione di Luchino Visconti) con un film oggi considerato come il primo manifesto del neorealismo. In America viene portato sullo schermo solo nel 1946 (The postman always rings twice, di Tay Garnett ) e infine ripresentato a colori e in una nuova e differente versione nel 1981 (di Bob Rafelson, con sceneggiatura di David Mamet).
(NOTA- Non deve stupire che un classico della letteratura americana come il Postino di Cain sia stato adattato allo schermo per la prima volta in Francia. I francesi, oltre ad aver definito e codificato il genere noir di cui Cain è un Maestro riconosciuto, vantavano una robusta tradizione di storie di coppie criminali. In questo caso si può citare sicuramente Thérèse Raquin (1867) di Emile Zola, dal quale il romanzo di Cain prende chiara ispirazione. Si è anche scritto che a sua volta, quasi a chiudere il cerchio, al romanzo di Cain si sia ispirato Albert Camus per il suo L’etranger (1942). Questo secondo richiamo mi pare tuttavia piuttosto flebile in quanto, sul piano della vicenda, l’unico collegamento tra il romanzo di Camus e quello di Cain sta nel fatto che essi sono scritti in prima persona da un condannato a morte. E’ comunque interessante notare come nel romanzo criminale, e in particolare nel Noir, le singole e ben distinte opere di autori, anche di notevole rilievo e di grande personalità, tendano ad iscriversi, nella percezione dei lettori, in una sorta di comune flusso narrativo. Questo conferma quanto sia importante l’indagine delle caratteristiche dominanti dei generi che, come ho cercato di mostrare, non si poggiano soltanto su delle strutture di racconto, ma esprimono delle filosofie correnti, dei punti di vista ben riconoscibili da cui si guarda alla vita, cioè delle interpretazioni del mondo condivise, che in quanto tali, travalicano i singoli autori e le singole opere. Le persone avverse a un certo genere, che si tratti dell’Horror piuttosto che della Love Story, del Noir o del Porno, lo sono perché non ne condividono la filosofia, non per una valutazione di tipo estetico. La valutazioni estetiche riguardano infatti le singole opere e i singoli autori, non possono riguardare un Genere nel suo complesso).
Qui confronteremo tra loro due adattamenti del romanzo di Cain: Ossessione di Visconti (film interpretato da Massimo Girotti e Clara Calamai) e l’edizione del 1981 di Rafelson (interpretata da Jack Nicholson e Jessica Lange). Entrambi i film sono facilmente reperibili in DVD e ve ne raccomando la visione e lo studio, in modo da approfondire meglio e più direttamente ciò che qui, per esigenza di sintesi, mi limiterò ad accennare.
1. Il plot
Questa è la scaletta del romanzo, capitolo per capitolo. Vi sarà utile anzitutto come modello di riassunto “per tappe” di un romanzo ( cosa che dovrete sempre fare per preparare un adattamento) e poi come riferimento per confrontarlo ai due film sopraccitati.
Califonia, tra il confine con il Messico e Los Angeles. Frank Chambers, un vagabondo di 24 anni, si ferma a un distributore di benzina con autorimessa dotato anche di una bettola, proprietà e abitazione di Nick Papadakis, un grassone di mezza età, di origine greca. Questi, che ha bisogno di un garzone, offre subito a Frank di restare lì. Frank esita, finché adocchia, in cucina, Cora, la giovane moglie di Frank, una bruna formosa, non particolarmente bella, ma sfrontata e aggressiva, quanto basta per fargli subito bollire il sangue. Frank decide di restare.( Capitolo 1).
Frank aggiusta l’insegna luminosa del locale e conquista subito la fiducia di Nick. Con Cora le cose vanno molto rapidamente: sotto il reciproco atteggiamento di sfida c’è una chiara tensione sessuale che viene sfogata subito. Al primo bacio lei gli ribatte “Mordimi!” e lui le fa zampillare il sangue dalle labbra. Poi se ne vanno di sopra.( Capitolo 2).
Frank approfondisce la conoscenza di Cora e apprende che viene dallo Iowa dove, eletta Reginetta di Bellezza, aveva vinto una trasferta a Hollywood. Qui però non era riuscita a superare i provini, a causa del suo accento rustico. Per un po’ si era prostituita, ma quel lavoro la disgustava, e dunque alla prima proposta di matrimonio, aveva accettato. Adesso però, è stanca di quel grassone del greco. Frank le propone di andarsene via insieme, ma Cora non vuole fare la vita della vagabonda. Invita piuttosto chiaramente Frank a far fuori suo marito. Frank non se la sente, anche perché lo trova un brav’uomo. D’altro canto, ormai non può più rinunciare a Cora. L’intesa non è più soltanto sessuale, con lei gli pare di stare in un’altra dimensione, come sospeso tra inferno e paradiso.
(Capitolo 3 ).
Frank ha ideato l’omicidio, in modo da farlo passare per un incidente (una caduta in bagno), ma è Cora ad eseguire il piano. In quel preciso momento però un agente di polizia si ferma al distributore, Frank lo intrattiene, mentre un guasto manda in tilt l’impianto elettrico e la casa resta al buio. Cora non è riuscita a completare l’omicidio. Il greco è esanime e probabilmente non s’è neppure reso conto di quanto è accaduto. Non si può far altro che chiamare un’ambulanza, ad evitare che il poliziotto possa nutrire sospetti. Al risveglio in ospedale, il greco non ricorda quanto è accaduto. Il poliziotto intanto ha trovato un gatto morto fulminato vicino alla cassetta delle valvole. Ogni possibile sospetto si è dissolto. Frank e Cora per il momento, l’hanno fatta franca.( Capitolo 4).
Frank e Cora, mentre il greco è ricoverato, passano una settimana felice. La tensione per quanto è accaduto sconsiglia loro di riprovarci in futuro. Decidono di partire, ma lei si ferma subito e scoppia in lacrime. Proprio non ce la fa a lasciare quel poco di sicurezza che si è guadagnata. Si commuove anche Frank. Si lasciano piangendo. (Capitolo 5).
Frank va a San Bernardino, per quindici giorni gioca a biliardo e spenna due tipi . Con duecentocinquanta dollari in tasca, se ne va a Glendale dove spera di incontrare di nuovo Cora e il greco che frequentano spesso il mercato locale. Gioca ancora a biliardo però stavolta viene spennato lui e si ritrova di nuovo senza un soldo. Al mercato incontra Nick, che è uscito dall’ospedale e sente la sua mancanza: i due garzoni che aveva assunto in sostituzione di Frank, erano un buono a nulla e un ladro. Frank torna con il greco. Con Cora tiene le distanze. Una notte la sente urlare in camera. Cora chiede a suo marito di allontanare Frank, sostiene che non lo sopporta. Frank intuisce che in realtà Cora voleva che lui ascoltasse la litigata, anche se non ne comprende i motivi. Più tardi, Cora gli rivela che il greco vuole un figlio da lei. Questo, Cora lo considera intollerabile. E’ in previsione una gita a Santa Barbara per una festa. Il greco si aspetta che in quell’occasione Cora dia il suo consenso. Cora implora Frank di accompagnarli e di approfittare del viaggio per ammazzare Nick. Altrimenti per lei non resterà altra strada che il suicidio. Non vuole un bambino dal greco, lo vuole da Frank. Si dichiarano il loro amore. (Capitolo 6).
Alla festa, il greco si ubriaca. Frank regge il gioco e simula ubriachezza. Nel viaggio di ritorno, è Cora a mettersi alla guida. Durate una sosta per un apparente disturbo al motore, Frank colpisce greco con una chiave inglese. I due amanti spingono l’auto in una scarpata e si fingono a loro volta vittime di un incidente, percuotendosi l’un l’altra. La violenza e la tensione sono tali che finiscono per possedersi sul posto. (Capitoli 7 e 8).
Poi Frank e Cora si ripassano la versione da fornire alla polizia. Una caduta casuale, mentre Frank sta risalendo la china, lo spedisce nel mondo dei sogni. Intanto Cora ha fermato un’auto di passaggio ed è stata chiamata un’ambulanza. Ci sarà un’inchiesta,però. La polizia infatti non è affatto convinta della dinamica dell’incidente e Frank si trova ad affrontare un processo. C’è di mezzo un fatto di cui Frank non sospettava: Nick aveva stipulato un’assicurazione sulla vita. La polizia, su input degli agenti assicurativi che non vogliono pagare il premio, sospetta che Frank lo abbia ucciso con la complicità di Cora per tenersi la proprietà e incassare i soldi. Frank professa la sua innocenza, ma è sotto farmaci e approfittando della sua labilità mentale, la polizia gli fa firmare una dichiarazione nella quale accusa Cora ( Capitolo 9).
Frank si procura un avvocato piuttosto astuto. Cora, incattivita, vuole confessare tutto. Rinchiusa in carcere, detta la sua confessione a un dattilografo, convinta che il tipo le sia stato mandato dalla polizia, mentre in realtà è un emissario dell’avvocato di Frank che ha pensato bene di farla sfogare, per guadagnare il tempo necessario a sistemare le cose. L’avvocato tratta con l’assicurazione e con raffinati espedienti, ottiene che la denuncia contro Frank e Cora venga ritirata. I due amanti vengono liberati. (Capitolo 10 e 11).
Dopo il funerale del greco, Cora e Frank trovano modo di spiegarsi tra loro. Di nuovo, dalle parole passano ai fatti e si prendono con brutalità ( Capitolo 12).
Il rapporto tra Cora e Frank si trascina tra litigi e sbornie. Frank ha un’avventura fugace con un’artista di un circo. Lei si trova bene e con lui e gli propone di aggregarsi alla carovana. Ma Frank sente che ormai non può più fare a meno di Cora e torna da lei ( Capitolo 13).
Cora nel frattempo è stata in Iowa per il funerale di sua madre. Il rapporto tra lei e Frank pare rasserenarsi. Ma rispunta fuori il dattilografo dell’avvocato che dopo essere stato licenziato ha bisogno di soldi e vuole ricattare Cora, avendo conservato la sua confessione. Frank lo pesta a sangue, si impossessa della confessione e la distrugge. Cora lo deride: per lei la cosa era irrilevante, una volta assolta non poteva più essere processata per quel reato. Il rischio avrebbe riguardato solo Frank. E’ irritata con lui perché ha scoperto la sua avventura con la donna del circo, e ha una crisi isterica. Durante la notte, si calmano e si spiegano. Decidono di sposarsi. Lei rivela a Frank di aspettare un bambino da lui. Dopo il matrimonio vanno a fare un bagno in spiaggia. Mentre tornano a casa, hanno un vero incidente di macchina e Cora resta uccisa ( Capitoli 14 e 15).
Frank viene accusato d’aver provocato a bella posta la morte di Cora e stavolta l’avvocato non riesce a fare nulla per lui. Disilluso di tutto, sperando ormai solo di poter riunirsi a Cora nell’aldilà, Frank scrive la sua storia nel braccio della morte, dopodiché attende solo che lo vengano a prelevare (Capitolo 16).
I primi capitoli del romanzo sono brevi e rapidissimi. I fatti si susseguono a un ritmo bruciante. Il capitolo 9 è molto più lungo. La vicenda rallenta dando spazio all’inchiesta ,alle strategie processuali, insomma al lato più propriamente “giallo” della storia. Ma il rallentamento corrisponde anche al venir meno della furente tensione erotica tra i due personaggi, che seppure con alti e bassi, scarti e ritorni indietro, si trasforma in una storia d’amore segnata tanto dalla colpa quanto dal sogno di trovare stabilità: una casa, un reddito sicuro, un bambino, un futuro più sereno. Il finale è improvviso e tronca la storia con freddezza, proprio come se le forbici del destino ne spezzassero il filo di netto. Questa alternanza di ritmo, molto ben giustificata nel romanzo, presenta un problema dal punto di vista della trasposizione cinematografica. I ritmi in un film si possono certo alternare, ma bisogna sempre stare attenti che le diverse parti (grosso modo i Tre Atti) non abbiano tempi troppo diversi tra loro perché l’opera complessiva non risulti squilibrata. Nel caso, il Primo Atto potrebbe apparire troppo sbrigativo, il Secondo eccessivamente lungo e il Terzo Atto nient’altro che un brusco finale. Come è stato risolto il problema nei film di Visconti e di Rafelson?
In Ossessione, Visconti parte in quarta, con lo stesso ritmo incalzante e provocatorio del romanzo. Poi elimina dei passaggi. Cancella del tutto il primo tentativo di omicidio, passando subito all’omicidio riuscito. Nella parte centrale del racconto, evita le alternanze e gli andirivieni tra l’ambiente reclusorio e statico della trattoria e le escursioni en plein air alle città vicine. Lascia la trattoria e si affida alla dinamica del viaggio, degli ambienti sociali e degli spazi aperti, potenziando la dinamica degli eventi, ravvicinandoli temporalmente, in modo che pur aprendo lo spazio del racconto, il ritmo non rallenti troppo. In questa sezione, Visconti inserisce un personaggio di sua invenzione: il protagonista incontra infatti un suo simile, un ex vagabondo che fa l’imbonitore da fiera, che lo aiuta, gli procura un lavoro, per quanto poco gratificante, e da amico ne ascolta lo sfogo e gli consiglia, senza successo, di tenersi ben lontano dalla donna che gli ha fatto perdere la testa. E’ un inserimento brillante. Il romanzo infatti è narrato in prima persona e il protagonista può dunque raccontare i suoi dubbi direttamente al lettore, ma in un film deve esteriorizzarli a un interlocutore, qui genialmente rappresentato nella figura di un alter-ego. Inoltre in questo modo, si mostra che il protagonista ha avuto a disposizione un’alternativa, una scelta diversa, e questo rende drammaturgicamente più efficace il fatto che la rifiuti, a dispetto di ogni evidenza. Tutta la lunga fase processuale viene eliminata. La polizia agisce sul campo, segue e insegue i sospetti, che fuggono e si sfuggono, si tradiscono, cedono ai nervi, si ritrovano, vivono permanentemente braccati dagli altri e da se stessi, finché l’incidente fatale durante l’ultima e apparentemente liberatoria fuga, diventa la fine inevitabile della corsa. Lui è ancora chino sul cadavere di lei, quando la polizia lo raggiunge. Tutto si conclude lì. Ma non è un finale brusco. E’ una finale predestinato. Non c’è più nulla da spiegare, perché la vicenda si è spiegata da sola, nel suo svolgersi.
Nel Postino suona sempre due volte di Rafelson, la prima parte viene invece rallentata, l’incontro sessuale tra i due protagonisti è frutto di un corteggiamento più cauto che esplode con furia proprio perché rimandato. In uno sforzo di maggiore rispetto del romanzo, nessun passaggio narrativo viene trascurato o eliminato, anzi se ne aggiungono altri. Ad esempio nel romanzo la festa del greco uscito dal ricovero in ospedale non viene affatto raccontata, mentre nel film è rappresentata in una scena di parecchi minuti nella quale il greco ha un rilievo, come personaggio, del tutto assente nel romanzo. Le partite a biliardo (eliminate da Visconti) diventano un gioco d’azzardo stradale e vengono così sbrigate più velocemente, ma restano comunque un passaggio poco incisivo. La parte processuale è così ampia da diventare un film nel film e il personaggio assolutamente minore dell’avvocato assume un ruolo ingiustificato da co-protagonista. L’unico taglio, tra tante aggiunte, è nel finale, dove Frank resta prostrato e sconfitto di fronte al cadavere di Cora, senza che ne segua l’arresto e la sedia elettrica, che a quel punto sarebbero un’appendice drammaturgicamente forzata e inutilmente punitiva. La critica cinematografica, che in genere tende a premiare lo sforzo di maggiore fedeltà a un’opera narrativa, in questo caso è stata compatta: il film è insopportabilmente lento.
2. I protagonisti
Ho già sottolineato nelle prime lezioni, quanto sia fondamentale in un film presentare con efficacia i personaggi, in modo da esprimerne subito, visivamente, non solo il carattere, ma il momento emotivo in cui si trovano. La presentazione che Visconti fa della coppia protagonista è esemplare. Lui, scoperto addormentato sul retro di un carro, viene svegliato e si avvia alla trattoria, entra e si avvicina al banco, senza che il pubblico possa mai vederlo in volto. Sente una donna cantare dalla cucina. Si avvia da quella parte, sempre di spalle, e si ferma sulla soglia. Davanti a lui ora c’è l’altra protagonista, ma nemmeno lei vediamo: lui la impalla lasciandocene scorgere soltanto le gambe nude e dondolanti. Stacco su di lei che si sta limando le unghie seduta su un tavolo e solleva lo sguardo, smettendo di cantare, con espressione più sfrontata che sorpresa. Solo a quel punto vediamo il volto di lui, che si incanta e si accende. Ricordo che il film è del 42. Il protagonista presentato di spalle anticipa di molti anni lo stile di presentazione dei personaggi di Brando e di James Dean. La protagonista, preceduta dal suo canto, e rappresentata come una sensuale apparizione, vi ricorda nulla? E’ la sequenza di presentazione di Gilda, di cui abbiamo già parlato. Solo che Gilda è un film di quattro anni dopo! L’intensità di questo primo incontro tra i personaggi, che è anche il nostro primo incontro con loro (si scoprono con uno sguardo, nell’istante stesso in cui noi li scopriamo), esprime già il loro distinto carattere e insieme il rispecchiamento dell’uno nell’altra, la reciproca intesa.
Nel film di Refelson l’incontro è invece rimandato. Tutta la rappresentazione è più debole. Prima entra in scena Jack Nicholson e ci viene mostrato immediatamente, affidandosi semplicemente a lui. Non è il personaggio che entra in scena: è Jack Nicholson. Jessica Lange la vediamo dal suo punto di vista: una presenza femminile che traffica in cucina e gli dedica solo uno sguardo distratto. Inoltre la precisione drammaturgica e l’esibita fedeltà al romanzo vanno entrambe a farsi benedire a priori e indipendentemente dalla volontà dello sceneggiatore, in virtù della stessa scelta degli attori che non corrispondono per nulla ai personaggi del romanzo: Jack Nicholson non è un ragazzo di ventiquattro anni apparentemente innocuo, è un uomo adulto e con la faccia da gangster. Non c’è alcun motivo logico per cui il greco possa fidarsi di lui e offrirgli un lavoro da garzone, né si capisce perché Cora dovrebbe sentirsene attratta e insieme giudicarlo abbastanza ingenuo da poter essere manovrato. Jessica Lange inoltre non è certo il tipo della ragazzotta rustica ex-miss scolastica di uno sperduto borgo dello Iowa e infatti, forse proprio per evitare l’implausibilità, nel film non ci rivelerà nulla del suo passato. (Se infine si considera che originariamente il ruolo di Cora era stato offerto addirittura a Maryl Streep , appare evidente quanto il film fosse fuori strada prima ancora di venire realizzato). Forse si confidava che la scelta di attori di grande richiamo avrebbe reso più esplosive le scene calde (quasi hardcore, non solo per la furia, ma per l’insistenza su certi dettagli, come la mano e la faccia di Nicholson tra le cosce di Lange). Anche queste scene paiono forzate, troppo volute, ed esse stesse deboli (non ci sono i morsi e il sangue del romanzo). Era del resto piuttosto ingenuo pensare che potessero ancora apparire forti nel 1981, cioè ben otto anni dopo Ultimo Tango a Parigi. Non c’è dunque da stupirsi troppo se, completamente fuori ruolo, sia Nicholson che Lange hanno offerto una delle interpretazioni peggiori della loro brillante carriera.
3. L’ambiente
Gli anni 30 e il desolante sud California di Cain immergevano la vicenda criminale nella giusta cornice della Depressione, nella quale le illusioni e le speranze dei due giovani protagonisti non potevano che richiedere il prezzo del delitto e andare drammaticamente deluse. Le trasposizioni europee, sia quella francese che quella italiana, trovarono sicuramente un punto di grande forza espressiva nel dipingere un quadro di campagna degradata a puro territorio di attraversamento, luogo di marginalità assoluta rispetto alle grandi città. Visconti sceglie un’ambientazione molto insolita, nel cinema italiano di tutte le epoche, e cioè le Marche, che sono per tradizione una sorta di territorio “a parte”, sufficientemente neutro da non richiedere caratterizzazioni troppo pronunciate in termine di usi locali e di dialetto, come sarebbe stato invece scegliendo il Veneto o la Campania. Questa felice scelta impedisce al contesto di inghiottire la vicenda. La vicenda, tanto accuratamente ambientata, quanto spaesata, mantiene così una sua esemplarità al di là dell’ambiente, come è caratteristica di un vero dramma, che in quanto dramma umano, deve riguardare tutti, e non apparire mai come pretesto per raccontare una realtà sociale specifica. Tanto per chiarire: L’Oro di Napoli non può ovviamente venire ambientato altrove, le sue storie si inscrivono in un ritratto della città, di quella città e della sua cultura. Le dinamiche di un noir invece debbono serbare una loro astrattezza. Il luogo non è certo indifferente, né il momento, ma non deve mai prevalere sul destino dei protagonisti che anzi ci vengono narrati come “estranei”, irriducibili alla realtà che li circonda, in disperato conflitto con essa, in cerca di riscatto e di fuga, nomadi perpetui e predestinati, trascinati come rifiuti dal fiume della vita. L’ambiente giusto è dunque quello che meglio consente di rappresentare questa loro condizione vissuta di estraneità.
Nel film di Rafelson invece il contesto, spostato in una terra di nessuno del centro america, incrocio di tutte le direzioni possibili, e negli anni 40, è una cornice d’epoca di mero contorno, resa meno miserabile e più patinata da una fotografia flou chiaramente orientata ad alleggerire, quasi si pensasse che il film fosse già di per sé sufficientemente crudo da non dover venire aggravato da immagini di degrado. Pesava sicuramente il confronto con la precedente edizione americana, la quale trasferiva la storia in un bianco e nero, gioco perpetuo di luci ed ombre, che la rendeva assolutamente astratta e la impreziosiva con il caratteristico glamour del film noir: Frank, un duro attraente, Cora una bionda platinata. Rispetto a questa attrattezza totale, probabilmente Rafelson intendeva dare maggior peso al realismo d’ambiente, pur serbando uno stile elegante che preservasse il film dal rischio opposto, quello di precipitare nel trucido. Si resta così a metà strada, in una caratterizzazione che non caratterizza a sufficienza, né in direzione dell’astratto, né in quella del concreto. Lo stesso per le scelte di dialogo, che nel romanzo è costituito da una lingua frammentaria e incerta, a volte esibizionisticamente sferzante, altre volte ingenuamente sentimentale e ridondante di luoghi comuni. Cioè la lingua di due ragazzi immaturi. Il linguaggio usato da Nicholson e Lange è scarno e funzionale, nemmeno questo ci aiuta a capire chi sono. Il risultato è che tutto appare ancor più finto e nulla ci aiuta a capire perché i protagonisti ragionino e agiscano in quel modo.
( NOTA- Come si vede, non sempre la quantità di mezzi a disposizione, l’eccellenza del cast, la forza d’impatto della promozione, riescono a salvare un film dal flop e, ciò che più conta, da un modesto risultato espressivo. Ho già accennato a come Jerry Lewis nella sua scuola di cinema facesse studiare i film brutti in modo da far capire bene agli allievi i possibili errori. Ma film brutti non significa necessariamente film realizzati dilettantisticamente, anzi i film non riusciti che allo studio ci rivelano gli errori più sorprendenti, sono proprio quelli realizzati con i migliori professionisti. Il professionismo di per sé non preserva dagli errori. Non si sbaglia soltanto quando si è alle prime armi, si può sbagliare sempre, anche ai massimi livelli. Studiare gli errori è fondamentale per evitarli. Ma non commettere mai più errori è praticamente impossibile, soprattutto in un lavoro complesso e collettivo come quello del cinema. Se restate frustrati di fronte a un vostro errore, tanto da sentirvi spinti a rinunciare, non siete fatti per questo lavoro. L’errore è oltre che difficilmente evitabile, fondamentale, se si impara a riconoscerlo, per crescere ed affinare la propria espressività. Il vero problema casomai è che oggi l’industria cinematografica non consente più come un tempo la possibilità di sbagliare ai registi, agli attori e, in misura certo minore, anche agli sceneggiatori. O si ottengono risultati immediati o continuare diventa difficile. Questo però non è colpa di chi lavora come regista, come attore o come sceneggiatore. E’ un errore dell’industria, che riconosciuto o meno, crea danni strutturali e di lunga durata.)
In conclusione: molti sono gli elementi da soppesare in una trasposizione da romanzo a film.
Il primo è la scelta di cosa mantenere e di cosa eliminare. Un film non si appoggia soltanto sul linguaggio verbale: ci mostra le cose, ci fa ascoltare suoni, rumori, musiche o silenzi, e da questo punto di vista è una narrazione globale, più ampia di quella della letteratura. Ma un film ci racconta tutto questo in un tempo dato, che è tempo narrativo (format e scansione ritmica del racconto, che in un romanzo non corrispondono a regole predeterminate) e tempo di ricezione (uguale per tutti gli spettatori, mentre il tempo di lettura di un romanzo è differente per ogni singolo lettore). Sotto questo profilo, la narrazione di un film è molto più breve e sintetica. Mostrando di più, può però raccontare meno, se vuole raccontare bene. Una digressione in un film pesa molto di più che in un romanzo e tra l’altro in un romanzo possiamo anche prenderci il lusso di saltarla e passare oltre, mentre in un film no (in genere ci ritroviamo dormienti prima che sia finita). Le scelte che eliminano sono dunque in un adattamento cinematografico più opportune e premianti di quelle che aggiungono. In particolare gli snodi della vicenda vanno semplificati. Le aggiunte si rivelano necessarie non solo e non tanto per potenziare l’aspetto spettacolare (esempio: l’aggiunta dell’animata scena di ballo e di festa in onore del greco), ma per poter esprimere in linguaggio cinematografico, cioè mostrando in azione, ciò che in un romanzo viene semplicemente narrato a parole e in una dimensione psicologica distinta dagli eventi (esempio: i tormenti interiori di Frank, da lui confessati in Ossessione a un altro personaggio).
Il secondo elemento fondamentale è la rappresentazione dei personaggi, rispetto alla quale il cinema è certo più erede delle tecniche di scrittura teatrale che di quelle romanzesche. In un film il personaggio fin dal suo primo apparire deve trasparire, cioè comunicare la sua fisicità, il suo ruolo, la sua essenza e il suo stato d’animo. Una presentazione casuale o sbagliata finisce per pesare negativamente sul personaggio, sulla sua identità e sul suo sviluppo drammaturgico.
Il terzo elemento è la scelta dell’ambientazione. Bisogna valutare molto bene se in un romanzo i personaggi e la storia sono inseparabili dal loro ambiente (abbiamo ad esempio visto come si sia in prevalenza scelto di non separare Jekyll dalla Londra vittoriana, e del resto sarebbe ben più arrischiato separare Sandokan dalla Malesia ), o hanno invece sufficiente autonomia da poter essere trasportati in altro contesto e in altra epoca (ad esempio Emma Bovary in quanto personaggio-simbolo di un certo tentativo di evasione/riscatto femminile è stata spesso dislocata senza soffrirne troppo). Tuttavia bisogna anche valutare attentamente come e quanto il mutato ambiente si presti a mettere in luce (meglio se in nuova luce) quel personaggio e quella storia, a meno che non si voglia farne un adattamento così libero da rendere pretestuosa l’origine letteraria.
23° Lezione di Gianfranco Manfredi by www.gianfrancomanfredi.com
Prima di affrontare l’esame di altri generi cinematografici, è bene considerare un aspetto che li percorre trasversalmente. Avrete già notato che abbiamo spesso parlato di film, di generi diversi, ma egualmente ricavati (più o meno liberamente) da romanzi. Per lo sceneggiatore non si tratta in questi casi di scrivere una storia originale, pensata fin dal principio per il cinema, ma di trasporre cinematograficamente un’opera narrativa preesistente e che il più delle volte non prevedeva neppure una versione cinematografica. Sembrerebbe un compito particolarmente difficile per uno sceneggiatore, ma è tuttavia un’esperienza fondamentale, anche a puro titolo di esercizio, e offre notevoli vantaggi. Anzitutto siete liberati dall’esigenza di dover inventare una storia e creare dei personaggi, perché la storia e i personaggi esistono già. In secondo luogo, imparando a sceneggiare una storia scritta da altri, potrete familiarizzarvi con una situazione assolutamente abituale nel cinema. E’ infatti ancora oggi piuttosto raro che un film nasca dall’idea narrativa di uno sceneggiatore. Nella stragrande maggioranza dei casi, sarete chiamati a sceneggiare un’idea di altri, nata cioè da uno stimolo produttivo, dall’ispirazione di un regista o dalle aspirazioni di un attore di cartello. E spesso queste idee nascono da narrazioni pre-esistenti. Proprio per questi motivi uno dei test di ammissione più frequenti alle Scuole di Cinema è l’adattamento. Il fondamentale requisito di uno sceneggiatore non sta nel fatto di essere autore originale di una storia, ma di essere in grado di “mettere in scena” una storia, non necessariamente creata da lui stesso.
Ecco i requisiti preliminari per realizzare un adattamento:
1. Leggere il testo originale. Questo può sembrare ovvio, ma non lo è. Di certi romanzi classici, già oggetto di numerose trasposizioni, si può pensare di conoscere già la storia, quanto meno nei lineamenti essenziali, e che dunque basti rinfrescarsela con una rapida lettura. Niente di più sbagliato. I testi letterari che hanno avuto molte trasposizioni, si prestano alle più diverse interpretazioni: le varie versioni (teatrali, radiofoniche o cinematografiche) non sono meri remake, anzi ciascuna di esse si giustifica per la sua particolarità. Questo avviene perché ogni lettura di un romanzo interviene nel romanzo stesso. Il romanzo è fin dalle origini molto più interattivo di quanto si pensi, sicuramente molto più interattivo del cinema. Il lettore è infatti costretto ad immaginarsi i personaggi, gli ambienti e le situazioni, e ciascuno se li figura secondo la propria e autonoma sensibilità. Inoltre certi passaggi narrativi che risultano fondamentali per alcuni lettori, per altri non lo sono altrettanto e possono persino passare inosservati. Infine tempi, modi e capacità di lettura sono diversi da lettore a lettore. Dunque leggete e lasciate anzitutto che il romanzo solleciti la vostra immaginazione.
2. Scalettate gli eventi del romanzo, i passaggi fondamentali che scandiscono la storia dal principio alla fine. Passando alla sceneggiatura non dovrete necessariamente rispettare la struttura originale, ma dovrete comunque tenerla ben presente, per poter valutare ogni singolo scostamento. In un romanzo c’è sempre qualcosa da togliere, nel passaggio al film, e non lo si può togliere a caso, altrimenti si perde l’equilibrio dell’insieme. A volte c’è anche qualcosa da aggiungere, per esprimere meglio una situazione. Saltare o aggiungere un passaggio, alterare l’ordine degli eventi, riassumere un momento per sottolinearne invece un altro, sono tutte scelte che devono corrispondere all’efficacia cinematografica, ma anche a una coerenza generale del racconto.
3. Guardate, se ci sono, le precedenti trasposizioni cinematografiche. Molti non lo fanno per il timore di restarne condizionati. Timore ingiustificato. Che dalla stessa storia si possano trarre versioni tanto diverse, non potrà che stimolare il vostro particolare punto di vista. Sicuramente leggendo il romanzo avete avuto altre suggestioni e vi capiterà come al pubblico di restare se non delusi, perplessi di fronte a certi film tratti dal romanzo, perché avete visto trascurati momenti che alla vostra lettura sembravano invece tanto essenziali, quanto espressivi. Potrete di fronte alla pluralità e varietà delle versioni, sentirvi più liberi di esplorare fino in fondo la vostra.
4. Cercate di individuare il centro, il focus del racconto. Concentratevi su quei momenti del romanzo che per voi ne hanno espresso il senso più profondo. Qualcuno di voi potrà trovare la storia inscindibile dal suo contesto storico e geografico perché è proprio questo contesto che vi ha affascinato. Qualcun altro potrà invece essere più attratto da aspetti del tutto attuali, da una dinamica psicologica o di eventi che può essere raccontata e reinterpretata anche al di fuori di quel contesto. Qualcuno potrà trovare il focus nella filosofia espressa dal romanzo, nel suo rivelare una certa “verità” ,un prezioso punto di vista sul mondo e sull’esistenza umana. Qualcun altro potrà essere conquistato da un personaggio, non necessariamente il protagonista , e prendere quello a paradigma, narrandone la storia nella storia, il romanzo nel romanzo. Cercate di non divagare da un elemento all’altro. Il racconto cinematografico comporta scelte nette e decise.
5. Evitate di considerare il romanzo originale come pure pretesto per raccontare dell’altro. Il romanzo è un pre-testo, solo nel senso che precede la vostra trasposizione, ma è un testo e fa testo, che voi lo vogliate o no. Gli scacchi e la dama si giocano con la stessa scacchiera, ma sarebbe insensato giocare a dama con le pedine degli scacchi. Il romanzo definisce il gioco, a voi le mosse, ma dentro quel sistema di gioco. Altrimenti non si capisce (non lo capisce il pubblico) perché abbiate scelto quel romanzo, quando potevate farne benissimo a meno e raccontare invece una storia vostra. Il rispetto dell’originale sta tutto qui: non sta nel seguirne pedissequamente i passaggi in un improbabile sforzo di fedeltà, sta nel rispetto della vostra stessa scelta di partenza. Motivatela, ma non traditela. Spesso la scelta non sarà stata vostra. Qualcuno vi avrà affidato il compito di sceneggiare il romanzo, dandovi indicazioni generiche oppure estremamente precise. Ma dal momento in cui accettate il lavoro, quelle indicazioni dovranno diventare vostre e la scelta altrui dovrà essere da voi condivisa. Altrimenti è più onesto che diciate: no, grazie, quel romanzo (o la versione che me ne proponete) non mi convince.
Vediamo ora un paio di esempi celebri di trascrizioni cinematografiche (il primo subito, il secondo nella prossima lezione) che ci saranno utili a chiarire e approfondire in concreto le indicazioni di cui sopra.
a) Lo strano caso del dottor Jekyll e di mister Hyde
Il romanzo breve di Robert Louis Stevenson esce nel 1886 e viene adattato per il teatro già nell’anno successivo da Thomas Russell Sullivan, che inserisce nel plot una storia d’amore del tutto assente nel romanzo. Questo primo adattamento fornirà poi la base per le più note versioni cinematografiche del romanzo (in totale se ne contano più di 120 e l’elenco continua ad allungarsi). Vediamo alcune delle variazioni più cospicue apportate all’originale.
1. La struttura narrativa
Il romanzo di Stevenson , come risulta evidente fin dal titolo, è un mistery. Inizia con un
 atto di violenza su una bambina perpetrato da uno sconosciuto. Si scopre poi che questo sconosciuto (Hyde) è stranamente protetto da un medico e ricercatore illustre (il dottor Jekyll). Finché si verifica un vero e proprio delitto, compiuto da Hyde, per inspiegabili motivi, ai danni di un anziano deputato. Hyde viene braccato. L’ambiguità del suo rapporto con Jekyll suscita angosce nella cerchia degli amici del dottore. Dello stesso Jekyll , sotto finale, si perdono le tracce o quantomeno il suo domestico si convince che l’uomo chiuso a chiave nel suo studio non sia Jekyll, ma Hyde. Nei rari momenti in cui riesce a vederlo, Hyde ha il volto coperto da una maschera, ma la sua bassa statura e la sua magrezza lo rivelano comunque tutt’altra persona dal dottore che è alto e rotondo. Irrompendo nello studio, dopo una notte molto agitata, un avvocato amico di Jekyll e il domestico trovano a terra il cadavere di Hyde. Una testimonianza autografa di Jekyll svela il mistero: Jekyll e Hyde erano la stessa persona, trasmutata grazie agli effetti di una pozione.
atto di violenza su una bambina perpetrato da uno sconosciuto. Si scopre poi che questo sconosciuto (Hyde) è stranamente protetto da un medico e ricercatore illustre (il dottor Jekyll). Finché si verifica un vero e proprio delitto, compiuto da Hyde, per inspiegabili motivi, ai danni di un anziano deputato. Hyde viene braccato. L’ambiguità del suo rapporto con Jekyll suscita angosce nella cerchia degli amici del dottore. Dello stesso Jekyll , sotto finale, si perdono le tracce o quantomeno il suo domestico si convince che l’uomo chiuso a chiave nel suo studio non sia Jekyll, ma Hyde. Nei rari momenti in cui riesce a vederlo, Hyde ha il volto coperto da una maschera, ma la sua bassa statura e la sua magrezza lo rivelano comunque tutt’altra persona dal dottore che è alto e rotondo. Irrompendo nello studio, dopo una notte molto agitata, un avvocato amico di Jekyll e il domestico trovano a terra il cadavere di Hyde. Una testimonianza autografa di Jekyll svela il mistero: Jekyll e Hyde erano la stessa persona, trasmutata grazie agli effetti di una pozione.In tutto il romanzo, i veri protagonisti restano sempre sullo sfondo e nell’ombra. I personaggi guida sono altri: gli amici, i conoscenti e i domestici di Jekyll. La tecnica, per tutto il romanzo, è quella del “parlano di lui”, anzi “di loro”: Hyde e Jekyll. In alcuni incontri fugaci, Hyde intrattiene diverse conversazioni, piuttosto ambigue. Jekyll è anche più riservato e sfuggente. Solo alla fine il dottore si racconta in prima persona e svela il mistero con una confessione postuma.
Gli adattatori si ritrovarono subito di fronte a un problema. Mentre in un romanzo i fatti possono essere narrati da testimoni, in teatro e in cinema il vero testimone dei fatti è lo spettatore. Ciò che in un romanzo viene riferito, in teatro e più ancora in cinema deve venire mostrato.
Questo coinvolge anche le scelte di tecnica narrativa. In un romanzo il “parlano di lui” può essere usato per l’intero sviluppo della storia . In Dracula di Bram Stoker, scritto in forma di romanzo epistolare, tutti parlano di Dracula, mentre lui non si esprime mai, è solo oggetto delle narrazioni altrui. In cinema, come abbiamo visto nelle precedenti lezioni, il “parlano di lui” può venire usato come prologo introduttivo alla comparsa del protagonista, come intermezzo di scansione, o come voce fuori campo di un narratore non-protagonista, ma in ogni caso i protagonisti devono agire ed esprimersi direttamente.
A questo primo problema di trascrizione, se ne aggiungeva un altro: il romanzo era divenuto subito talmente popolare che tutti conoscevano già il finale. Non si poteva dunque trasporre il romanzo rispettandone la struttura e la tecnica narrativa, ma nemmeno le caratteristiche di mistery perché il mistero non c’era più, e il finale non sarebbe stato per il pubblico un colpo di scena inatteso.
Bisognava dunque individuare altrove il focus narrativo e per il teatro ottocentesco (dove erano popolarissime le figure degli attori trasformisti) non c’era nulla di più stimolante che rappresentare dal vivo e in scena la trasformazione di Jekyll in Hyde. Il tema centrale del romanzo, al di là della struttura, era quello dello sdoppiamento di personalità, presentato in modo radicale, non come un comportamento doppio da parte di un singolo individuo, ma proprio come lo sdoppiamento di un individuo in due persone diverse. Era questo che il pubblico si aspettava di vedere. Dall’indeterminazione del mistery, dove i fatti salienti avvengono dietro le quinte, sono inafferrabili e vengono svelati solo alla fine, bisognava dunque passare alla concretezza emotiva dell’horror.
Ma la scelta di rappresentare la trasformazione, rispetto al romanzo, metteva gli adattatori di fronte a un altro problema e cioè…
2. I personaggi di Jekyll e Hyde
Nel romanzo, la descrizione di Jekyll è chiarissima. E’ un uomo di cinquant’anni, alto e rubicondo. Da giovane è stato un po’ scavezzacollo, ma ormai è uno studioso serissimo e per quanto sia impegnato in esperimenti segreti , nessuno dubita della sua limpidezza morale.
La descrizione di Hyde è invece volutamente vaga e imprecisa. Di sicuro sappiamo che è “un giovanotto” , di piccola statura, poco più di un nano, che ha un modo molto caratteristico di muoversi, rapido, leggero e a tratti scimmiesco. Una lieve peluria gli ricopre il dorso delle mani.
Ma quanto al volto, mistero assoluto. Nessuno riesce pienamente a descriverlo.
“ Che aspetto ha?” chiede l’avvocato Utterson a suo cugino Enfield (il quale, testimone di un’aggressione di Hyde a una bambina, lo ha fermato e poi trattenuto presso di sé per un’intera notte, costringendolo a rifondere i danni alla famiglia dell’aggredita). E questa è la risposta: “Non è facile a descriversi. C’è in lui qualcosa di strano, di ripugnante, di detestabile. Non ho mai visto un uomo così antipatico, eppure non saprei dire il perché. Colpisce sgradevolmente, sembra che vi sia in lui qualcosa di deforme , ma non saprei specificare cosa. Ha un aspetto anormale e tuttavia non potrei indicare esattamente in lui nulla fuori dell’ordinario. No, caro, non riesco a capirlo. Non riesco a descriverlo.” Altre volte nel romanzo si rimarca questa indefinibilità di Hyde, in nessun punto si dice che è un mostro. Un vetturino che lo incontra lo trova persino comico (perché Hyde indossa i vestiti di Jekyll, troppo grandi per lui), e soltanto di fronte alla sua reazione infastidita, ne intuisce la pericolosità.
Come mai Stevenson insiste tanto su questa indescrivibilità di Hyde? Da un lato, sottolinea che la ripugnanza destata da Hyde è di tipo istintivo… come quando ci troviamo di fronte a una persona che emana energie negative, che trasmette una deformità di tipo morale più che di tipo fisico. D’altro canto, da grande scrittore, Stevenson suscita l’inquietudine dei lettori mettendoli nella disagevole condizione di non potersi figurare Hyde. Il verbo to hide, significa nascondere. Mister Hyde è l’Uomo Nascosto (e Stevenson lo rimarca esplicitamente, perché la scelta del nome non sembri casuale). Il suo volto ci resta nascosto per tutto il romanzo. E questo ci inquieta molto di più che se Stevenson ci avesse descritto un mostro.
In teatro e più ancora in cinema è proibitivo rappresentare il non rappresentabile. Il pubblico è lì per vedere. Un personaggio di cattivo può essere mantenuto a lungo nell’ombra per renderlo più indecifrabile e minaccioso, ma a un certo punto deve essere mostrato. Nella foto allegata potete vedere il primo creatore dell’immagine di Hyde e cioè l’attore Richard Mansfield, primo interprete teatrale del doppio personaggio Jekyll/Hyde. Potete intuire, anche se la foto non è chiarissima, che raccorcia, accucciandosi, la sua statura e assume una postura scimmiesca. Gli spunta una barba, eppure non c’è ancora in lui l’aspetto mostruoso che ne ha fatto la fortuna cinematografica. In cinema è difficile rappresentare la deformità morale quando essa è unita alla trasformazione fisica. Una metamorfosi malvagia deve apparire anche fisicamente malvagia. Se dunque un uomo si trasforma in mostro, che mostro sia fino in fondo: più mostruoso apparirà, più lascerà il pubblico senza fiato.
Sono pochi gli esempi cinematografici di un Hyde più fedele a quello “indescrivibile” del romanzo. Nel film Il testamento del Mostro (1959), Jean Renoir grazie alla performance prodigiosa dell’attore mimo Jean-Louis Barrault, ci presenta un Hyde meno sfigurato del solito nel volto, ma tanto più inquietante nel movimento, nella camminata agile e nervosa, quasi comica a tratti, un Hyde che compie i suoi pestaggi con leggerezza fanciullesca, quasi danzando (e anticipando i picchiatori-clown di Arancia Meccanica ).
Terence Fisher nel suo The Two faces of dr.Jekyll (1960) ci presenta addirittura un Hyde bello e aitante. E una scelta simile compie Alistair Reid in un interessante film tv del 1981 con David Hemmings. L’intento è quello di discostarsi da un modello cinematografico ormai sedimentato e dunque troppo prevedibile. Vi siete abituati a vedere un Jekyll distinto e un Hyde mostruoso? Beh, io vi sorprendo presentandovi un Jekyll bolso e un Hyde seducente.
Questo capovolgimento totale, soprattutto nella versione di Reid, ha il merito di recuperare un tema ben presente nel romanzo e in genere trascurato: Jekyll è un cinquantenne alle soglie della vecchiaia e Hyde è giovane. Cioè quello che spinge Jekyll verso Hyde è il desiderio di ritrovare l’energia vitale che sta perdendo, di rivivere le potenti emozioni e le passioni travolgenti della gioventù e persino dell’infanzia, liberandosi dal ruolo sociale “per bene” tipico della maturità avanzata e anticamera del pensionamento. Cancellando questa motivazione, non ci capisce perché Jekyll si trasformi in Hyde. Resta solo il suo assunto morale (ben poco persuasivo in un ricercatore scientifico e in effetti per renderlo plausibile Stevenson fa di Jekyll un seguace della “medicina trascendentale”): Jekyll tenta di isolare il male per espellerlo. E’ vero che nel romanzo Jekyll sostiene proprio questo, che cioè lo scopo iniziale della sua ricerca era di perfezionare l’essere umano, separando il bene (prevalente) dal male (la parte meno sviluppata di noi, ecco perché Hyde è quasi nano), ma la narrazione ci mostra la verità al di là delle intenzioni “ideologiche” di Jekyll e cioè che Jekyll cerca di ritrovare attraverso Hyde la giovinezza e l’allegra dissolutezza che ha ormai perduto.
3. La pozione
Anche la vita di Hyde , oltre al suo aspetto, nel romanzo ci resta occulta. Sappiamo che è impegnato a dare sfogo alle libidini più perverse, ma non viene svelato quali siano. Di certo, Hyde è in preda a una costante e incontrollabile eccitazione. La “pozione” che dà vita ad Hyde, non è un filtro magico, è qualificata né più né meno che come una droga. Così si lamenta il domestico di Jekyll: “Ogni giorno, anche due o tre volte al giorno, sono dovuto correre da tutti i farmacisti della città. Ogni volta che tornavo a casa con la roba, mi diceva di riportarla indietro perché non era pura e mi dava un altro ordine per un’altra farmacia. Questa droga veniva chiesta disperatamente, chi sa per quale scopo.” Il dottor Lanyon, collega di Jekyll, descrive così la sostanza: “una specie di sale cristallino di color bianco.” Il famoso e misterioso filtro nel quale la polvere va versata è soltanto una soluzione adatta a sciogliere quel “sale”. Il filtro diventerà inefficace, sia a compiere la trasformazione che ad invertirla, senza la polvere giusta. Finché ce l’ha, Jekyll deve aumentarne la dose di volta in volta. Ad un certo punto non ne ha più e nemmeno può procurarsela perché scopre amaramente che quella originale, quella che funzionava, era stata casualmente adulterata. Dunque Jekyll non dipende dal filtro, ma da una droga che non ha fabbricato lui e che non riesce a ricreare. Per di più gli effetti hanno ricadute a lunga scadenza… la trasformazione in Hyde tende alla permanenza, mentre quella di rientro si fa sempre più fugace. Ormai il dottore non può più tornare indietro. E ad ogni nuova trasformazione, Hyde è sempre più esaltato e incapace di governare i suoi impulsi, che lo spingono non solo alla furia, ma anche a mille astuzie per procurarsi denaro, ad umiliarsi per sfuggire ai guai che combina, e infine addirittura al pianto dirotto e disperato di chi si sente minacciato dal mondo, dal suo creatore e persino da se stesso. Il suo percorso è suicida, perché in Hyde la via della distruzione non può che condurre all’autodistruzione. Per Stevenson, Hyde non diventa (fisicamente) un mostro, lo diventa (moralmente) sotto l’influsso della droga. Quando Lanyon gli porta l’ennesima polverina, Hyde gli grida: “L’avete qui? L’avete qui?” e gli afferra un braccio, scuotendolo, “in preda a una fosca eccitazione.” A Stevenson non interessa la corruzione dei costumi di Hyde, non gli importa nulla di raccontarci le sue imprese lussuriose, ci sta parlando del dramma della dipendenza, con una forza espressiva e una precisione che nessuno scrittore prima di lui aveva osato esibire. Ma questo aspetto del romanzo dovette apparire così perturbante che persino a distanza di decenni il cinema ha evitato di sottolinearlo. Nei film, è Jekyll che si suicida, per eliminare Hyde. Nel romanzo le cose non stanno affatto così. Nella sua lettera d’addio, Jekyll scrive: “In qual modo non posso prevedere, ma il mio istinto e tutte le circostanze della mia indefinibile situazione, mi dicono che la fine è sicura e dev’essere vicina.” Cioè la fine è inevitabile. Jekyll non la ricerca, ci si abbandona. Sa che diventerà Hyde e che Hyde sarà sempre più debole e non potrà reggere all’astinenza. Quando Hyde muore, Jekyll è già scomparso da tempo.
Il film tv di Reid, in uno sforzo di maggiore adesione al romanzo di Stevenson, ci mostra , alla fine, il cadavere di Jekyll che si trasforma in Hyde. Questa è un’eccezione assoluta tra i film tratti dal romanzo, nei quali è sempre Hyde alla fine a trasformarsi in Jekyll, con il trasparente intento di tranquillizzare il pubblico mostrando la redenzione di Jekyll che, nella morte, è riuscito a tornare se stesso.
4. La Londra Vittoriana
Il romanzo può anche essere legittimamente interpretato come un apologo morale che denuncia l’ipocrisia della società Vittoriana. Spesso la figura di Hyde è stata associata a quella di Jack lo Squartatore che insanguinava i vicoli di Londra in quegli anni, era probabilmente un membro illustre dell’aristocrazia e dimostrava una notevole perizia medico-chirurgica. Di questo riferimento Stevenson non può essere considerato responsabile, se non come anticipatore e profeta, in quanto il suo romanzo uscì nel 1886 mentre i delitti di Jack si verificarono due anni dopo. Per di più alcuni critici hanno rilevato che la Londra descritta da Stevenson somiglia più a Edimburgo che a Londra stessa e che il romanzo non inizia nelle nebbie, ma in una placida domenica assolata, nella quale l’aggressione di Hyde alla bambina risulta ancor più scioccante. Resta comunque indubbio che la cornice storico geografica e la quasi contemporaneità con i delitti di Jack The Ripper si imprimono indelebilmente nell’immaginario collettivo. La storia diventa un tutt’uno con la sua cornice e questo spiega perché la stragrande maggioranza dei film tratti dal romanzo ne ha rispettato appieno l’ambientazione (con aggiunta di molte nebbie).
5. Infedeltà o tradimento?
Riassumendo: nella maggior parte dei film tratti dal capolavoro di Stevenson, non solo la struttura narrativa viene cambiata, non solo Hyde, contro le indicazioni dell’autore, è raffigurato come un mostro, non solo la sua tossicodipendenza e la sua gioventù vengono trascurate, ma anche il finale risulta stravolto. Non si può però con questo dire che il cinema abbia (in generale) tradito il romanzo. Ne ha colto il seme (lo sdoppiamento) e l’ha piantato e fatto crescere in un altro terreno. Ha tolto al romanzo molte delle sue caratteristiche e ha aggiunto cose e personaggi che non c’erano: quadri di vita sociale di Jekyll, squarci di vita dissoluta di Hyde, personaggi femminili (una promessa sposa di Jekyll e una prostituta schiavizzata da Hyde, vedi il film di Victor Fleming del 1942). Chi adattava di volta in volta non ha semplicemente portato il romanzo sullo schermo: ha condotto, a partire dal romanzo, un’operazione di riscrittura che teneva conto delle esigenze proprie della narrazione cinematografica in generale e anche del particolare momento di mercato che suggeriva adeguamenti (più o meno opportuni) al gusto del pubblico. Ha considerato anche le versioni cinematografiche precedenti, diventate la “vulgata” del testo, per aggiornarle o distaccarsene.
Tra i tanti film prodotti ne voglio ricordare uno in particolare, una classica versione “infedele”, e tuttavia pregevolissima: quella di Robert Mamoulian (del 1931). Qui la scelta di adattamento è resa trasparente fin dalla prima meravigliosa sequenza. Il film inizia in soggettiva di Jekyll. Noi siamo Jekyll, vediamo quello che lui vede. Usciamo di casa con lui, prendiamo una carrozza, andiamo in Università a tenere una lezione, e ad ogni passaggio veniamo omaggiati da servitori e persone che incontriamo, finché ci ritroviamo soli di fronte a uno specchio, in cui Jekyll vede il suo volto fino a quel momento occulto. Jekyll incontra Hyde già quando è di fronte allo specchio, di fronte a un se stesso che è altro da sé. In altri termini, anche senza droga, il germe della schizofrenia e dello sdoppiamento è in tutti noi.
Questo è sicuramente il messaggio più potente trasmesso dall’opera di Stevenson. Jekyll ci coinvolge perché tutti noi possiamo essere lui. In ciascuno di noi c’è una parte nascosta (Hyde) che chiede di uscire e una parte manifesta (Jekyll) che già all’origine è ambigua, tanto che persino il nome di Jekyll allude seppure in modo più mascherato (Je-kill: Io Uccido) alla potenzialità omicida di ogni essere umano. Attraverso uno scostamento narrativo dal romanzo, Mamoulian è riuscito ad esprimerne il significato centrale, separandolo ed isolandolo da quelli accessori, e rendendolo visibile.
Il compito di un romanziere è suggerire ai lettori una pluralità di interpretazioni in modo che ciascuno di loro, secondo la propria sensibilità, possa relazionarsi al racconto, facendolo proprio.
Il lavoro del cineasta consiste invece nello scegliere un’interpretazione tra le tante possibili ed esprimerla con radicalità, in modo che colpisca lo spettatore, molto più passivo di fronte allo schermo di quanto non sia un lettore di fronte a una pagina scritta.
Il cinema è una potente macchina di semplificazione che a volte può apparire devastante rispetto ai modelli letterari di riferimento, ma se di questa semplificazione facciamo lo strumento per cogliere l’essenza di un’opera, esprimendola non in un concetto, ma nella sintesi di un’immagine o di una sequenza, allora possiamo sperare di rendere omaggio all’originale creando al contempo cinema nella necessaria, indispensabile autonomia e secondo le modalità espressive specifiche del mezzo.
Nella prossima lezione esamineremo un’altra celebre trascrizione: Il postino suona sempre due volte.
NOTA
Da questo mese inauguro una nuova sezione (Contributi) con un interessante intervento/lezione di Davide Aicardi sulla Sketch Comedy. Davide fa parte della redazione di autori del programma TV Camera Café e sa bene di cosa parla. Tra le persone che seguono questo corso ce ne sono parecchie che frequentano corsi e scuole di cinematografia (anche internazionali) o che hanno già avuto delle esperienze professionali sul set o nella creazione di corti o di documentari. Sarebbe molto utile se raccontassero anche agli altri, che invece sono alle prime armi, le loro esperienze e le loro riflessioni. La sezione Contributi è aperta e spero di poter pubblicare presto altri utili interventi.
22° Lezione di Gianfranco Manfredi by www.gianfrancomanfredi.com